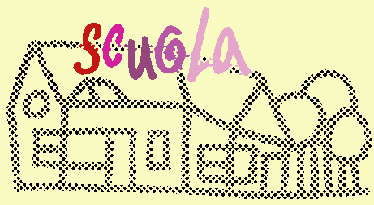Si
era parlato nel settembre scorso di questo film per complimentarsi con la scelta della
giuria della Biennale di Venezia di attribuire il Leone d'Oro all'ultima opera del regista
cinese, che ne aveva già conseguito uno nel 1992 con La storia di Qui Ju. Non a
caso un'altra opera centrata su un ritratto femminile forte, quello di una donna
determinata, ostinata, pronta a combattere la burocrazia ottusa del suo paese pur di
ottenere giustizia. I due film presentano molte affinità e si direbbe facciano parte di
un medesimo progetto culturale, quello di mostrare, con un realismo pittoresco, figurativo
e di "maniera" nell'attenzione ai particolari sociologici, l'estrema povertà
della campagna, l'aspirazione al benessere della città, la maniacale ossessione per il
denaro, l'individualismo sfrenato con conseguente perdita di valori collettivi cari alle
tradizioni maoiste, la funzione consolatoria incarnata dalla presenza televisiva,
impegnata stavolta in una missione "Arcobaleno della vita", che smuove la
generosità dei telespettatori, per consegnar loro (e anche a noi) un finalino edificante,
un happy end, dal quale si esce comunque con l'amara sensazione che "il non
uno di meno" è in realtà un io molteplice, una piaga diffusa in tutto il mondo.
L'abbandono scolastico raggiunge cifre da capogiro, non solo in Cina dove la stima parla
di un milione circa di bambini all'anno. Allora non è poi così ottimistico un film che
ne affida l'eventuale recupero solo grazie all'iniziativa e all'intraprendenza del singolo
(ma è già qualcosa, anche se il recupero scatta dietro il miraggio di un lauto
guadagno), anziché immaginare altre forme, magari istituzionali, di difesa del diritto
all'istruzione negato ai più deboli. Se avesse scelto questa seconda strada il regista
avrebbe compiuto una mistificazione ancor più beffarda, forse per questo gli si perdona
l'emozionalità melensa dell'epilogo con la troupe televisiva che arriva trionfalmente a
portare le donazioni dei telespettatori e le scatole dei gessetti che vengono aperte per
consentire a ogni bambino di scrivere finalmente un ideogramma colorato alla lavagna. Il
fervorino finale sembra diventare maniera, visto che già Keep Cool terminava con
un altro epilogo giustapposto e incoerente con il resto del film (anche tecnicamente
distaccato dal resto dell'opera), quasi che il bisogno di tacitare la censura abbia fatto
diventare Yimou attento a confezionare tirate moralisticheggianti finali che potrebbero
anche diventare repertori ironici e sottolineare ulteriormente il feroce egoismo del resto
del film, negandolo in una gara di solidarietà falsa, come soltanto la televisione riesce
ad essere.

Yimou non racconta una
fiaba, ambientata in una scuola fatiscente e degradata di un villaggio di campagna
sottosviluppato e misero, anche se alcuni ingredienti potrebbero far pensare che si tratti
solo di una storiellina (l'idea è stata tratta da un romanzo di Shi Xiangsheng); mette
invece la sua macchina da presa ad indagare i volti di personaggi reali, per confezionare
un'opera di condanna e critica sociale, capace di parlare a tutti, non uno di meno, con
semplicità e al contempo con estrema naturalezza nelle scelte registiche.
"Cinema verità", girato all'aperto, con attori non professionisti. Ogni
personaggio è recitato da chi nella vita ha lo stesso ruolo e lo stesso nome: il maestro
è davvero l'insegnante di quella classe, i bambini sono i suoi allievi, le offerte
pubbliche hanno veramente contribuito ad aiutare quella scuola.
Solo Wei Minzhi nella realtà non è supplente, bensì una studentessa tredicenne che sta
completando il suo ciclo di studi. Per questo viene affidato solo a lei il compito più
arduo, quello di tentare di cambiare il destino scolastico dei bambini che le sono stati
affidati nella finzione filmica per un mese soltanto. E sarà proprio lei a crescere e a
trasformarsi in un'ostinata guardia rossa irriducibile nell'epoca della dittatura
del denaro, nonostante abbia la memoria corta (non ricorda più nemmeno le parole di una
famosa canzone maoista, così come di fronte alla parodia del rito dell'alzabandiera con
tanto di inno nazionale cantato dai bambini dimentica di far issare il vessillo di stato),
attenda solo che la luce del sole illumini il chiodo conficcato nel muro ad indicare il
termine delle lezioni o all'inizio sia spinta dall'idea di potersi guadagnare lo
stipendio. Il che non è riprovevole: l'insicurezza del suo lavoro l'accomuna a tutti i
docenti precari, compresi quelli italiani, molti dei quali stanno ancora aspettando lo
stipendio dal settembre scorso.
La sua metamorfosi comincia quando il capovillaggio tenta di convincerla a lasciare che
una sua allieva possa trasferirsi in città per iniziare una carriera atletica: le
istituzioni hanno fiutato che c'è da sfruttare un talento olimpionico e da bravi rapaci
non mollano la presa. Ma anche la maestrina "sa correre veloce",
ribellarsi, conquistare la simpatia dei suoi allievi, che, a partire da quell'episodio,
imparano a conoscerla, abbandonano il clima sospettoso, per diventare solidali e complici,
capaci persino di smuovere una montagna di 1000 mattoni, per consentirle di racimolare i
soldi per il viaggio e per l'acquisto di due lattine light (Mao e la Coca Cola possono
andare a braccetto per queste generazioni), quando si decide a recarsi in città per
riprendere l'allievo Zhang Huike. Non si arrende all'idea di tracciare ancora un meno su
quel registro che annovera già troppe croci.

Cosa la spinge a
comportarsi così? I soldi, l'istinto, la sua caparbietà, un innato spirito combattivo,
l'improvvisa nascita di una consapevolezza del proprio ruolo didattico?
Il film non lo esplicita direttamente, ma lo lascia intuire attraverso l'analisi del suo
comportamento: resta per giorni in strada ad attendere che il direttore di una rete
televisiva possa riceverla e consentirle di diramare il suo accorato appello, non si
lascia sedurre dalla popolarità dell'audience, non risponde ai demenziali interrogativi
strappalacrime della conduttrice del programma "Arcobaleno della vita",
la solita trasmissione nazional-popolare. Sgorga solo ad un certo punto improvviso e
naturale un suo pianto a dirotto, un suo parlare a tu per tu con il bambino, che
dall'altra parte dello schermo (immerso in una realtà caritatevole, ma ambigua e pelosa,
come quella della proprietaria del ristorante, che gli ha dato da mangiare a patto che non
disturbasse i clienti per poi fargli lavare i piatti) risponde con le lacrime a quelle
parole, che gli svelano che è uno e solo uno tra i tanti destinati a lasciare la scuola,
ma in quanto tale è importante, unico e prezioso, e pertanto va reclamato il suo diritto
a riprendersi l'istruzione che gli stanno scippando.
"Che cosa ti è rimasto impresso dell'esperienza in città?", chiederà
la conduttrice del talk show al bambino sul pulmino carico di doni che lo sta
riportando al villaggio in compagnia della sua maestrina combattiva. "Che dovevo
chiedere da mangiare", risponde Zhang Huike. Elemosinare il cibo, fare la
carità: sono esperienze più umilianti dell'essere analfabeti? Il paragone non tiene,
forse Huike, terminati gli studi, tornerà in città e si ritroverà al punto di partenza,
sottoccupato, precario, mendicante per necessità. Diamogli il tempo di crescere, perché
in questo tempo la sua infanzia sia tutelata da siffatte umiliazioni, possa sognare,
divertirsi, immaginare destini diversi, anche quelli nascosti dietro al suo piacere di
scrivere alla lavagna con un gessetto azzurro (non nero come il lavoro minorile) il nome
della sua maestra.
Questo Wei lo ha capito, questo è anche il messaggio del regista quando dice: "Il
mio film andrebbe semplicemente guardato, invece di buttare tutto in politica. Anche
perché Non uno di meno è bello da guardare e da ascoltare. É un film sui bambini e i
bambini si possono solo osservare con amore ed ottimismo". |