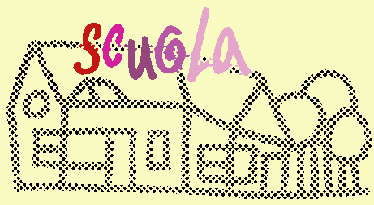 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |

15.01.2005
Tre più due uguale zero.
La riforma dell’Università da Berlinguer alla Moratti

a cura di Giovanni Savegnago
Non leggano questo libro quanti negli ultimi anni nei licei e negli istituti superiori (e sono tanti! particolarmente numerosi, spiace riconoscerlo, tra quei docenti che con maggior forza, da sempre, si erano battuti per lo svecchiamento e la democratizzazione dell’istituzione scolastica) si sono lasciati affascinare dal POF, si sono fatti promotori di Progetti, hanno accettato entusiasticamente di farsi carico delle Funzioni Strumentali, hanno investito tempo e intelligenza nell’elaborazione di Griglie sempre più raffinate, in grado di misurare con precisione millimetrica Conoscenze, Capacità e Competenze, al fine di un più adeguato raggiungimento degli Obiettivi, fissati tenendo naturalmente conto degli Stili cognitivi degli allievi, in modo da fornir loro Skillaggi professionali immediatamente spendibili sul mercato del lavoro... E non lo leggano neppure quei docenti universitari che hanno tratto profitto dalla moltiplicazione dei corsi conseguente alla Riforma introdotta gli scorsi anni negli atenei italiani, che hanno accettato di buon grado le defatiganti e spesso inconcludenti riunioni necessarie per definire quali corsi o moduli attivare, suddividere, spezzare, che non hanno battuto ciglio di fronte alla frammentazione dei contenuti della loro disciplina in Moduli, così come alla pratica di valutare i loro studenti esaminandoli sul prescritto numero di paginette fotocopiate ("Sulle fotocopie c’è scritto…", ricordava Riccardo Chiaberge su Sole 24Ore dello scorso 19 settembre, è una frase che sempre più spesso capita di sentir dire, durante gli esami, da studenti che si sono scordati di fotocopiare la copertina e quindi ignorano titolo e autore dell’opera sulla quale stanno sostenendo l’esame), la cui lettura è (per il momento ancora…) necessaria a fornir loro i Crediti necessari per accedere infine a quella Laurea breve triennale che, di fatto, non schiuderà loro – per lo meno per chi uscirà dalle facoltà umanistiche – alcun lavoro davvero qualificato (sicuramente non l’insegnamento, precluso a chi non avrà affrontato il successivo modulo di specializzazione biennale). Non lo leggano, dicevamo, perché la loro certezza di avere in questi anni bene operato schierandosi senza riserve a sostegno della scuola del Nuovo e dell’Accoglienza potrebbe venirne incrinata. Il che forse – fuori da ogni ironia – potrebbe favorire l’avvio di una seria e serena riflessione (che necessita tuttavia, come conditio sine qua non, dell’abbandono della consueta e spocchiosa accusa di conservatorismo rivolta a quanti in questi anni hanno sollevato dubbi e obiezioni sulle magnifiche sorti e progressive sulle quali sono incamminate la scuola e l’università italiane, a partire dalle riforme attuate durante il primo governo di centro sinistra dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione Luigi Berlinguer) su quanto sta oggi avvenendo, nel campo dell’istruzione, nel nostro Paese.
Costruito su una decina di contributi di docenti universitari attivi nel campo delle discipline storiche, linguistiche, filologiche (Claudio Magris, Cesare Segre, Massimo Firpo, Pier Vincenzo Mengaldo, Vittorio Coletti, Giuseppe Ricuperati, Giorgio Bertone, Michele Loporcaro, Raffaele Simone e Pier Marco Bertinetto), introdotti e coordinati da Gian Luigi Beccaria, il volume raccoglie interventi in qualche caso già comparsi su giornali e riviste o presentati nel corso di convegni, ed ha come bersaglio polemico privilegiato – come recita il sottotitolo - la riforma dell’università da Berlinguer alla Moratti, senza tuttavia trascurare di affrontare la questione più complessiva del degrado sempre più marcato che in quest’ultimo decennio ha investito l’intero sistema educativo italiano. La tematica affrontata, come si vede, non è certo nuova. È almeno dalla fine degli anni Novanta che attraverso libri e interventi su quotidiani e riviste si susseguono analisi e allarmate denunce sul progressivo svuotamento dei contenuti dell’insegnamento e sul contemporaneo avvitamento della didattica su se stessa che investe in pari misura la scuola superiore e l’Università (tra le numerose altre vorremmo almeno ricordare - per quanto concerne la produzione libraria - G. Ferroni, La scuola sospesa, Einaudi 1997; L. Russo, Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola italiana?, Feltrinelli 1998; F. Polacco, La cultura a picco, Marsilio 1998; A. La Penna, Sulla scuola, Laterza 1999; M. Bontempelli, L’agonia della scuola italiana, CRT 2000; M. Ferraris, Una Ikea di Università, Cortina 2001; J. Derrida-P.A. Rovatti, L’università senza condizione, Cortina 2002) e il disagio che tanti docenti della scuola superiore avvertono è ormai così diffuso da essere divenuto materia per esercitazioni letterarie (P. Mastrocola, Una barca nel bosco, Guanda 2004). Tuttavia l’autorevolezza che nel corso degli anni gli autori hanno accumulato nei rispettivi campi di ricerca, la loro posizione politica (tutti collocabili nell’ambito della sinistra), e soprattutto la lucidità degli interventi qui raccolti fanno di questo libro, secondo noi, un’opera che chiunque a vario titolo (docente, studente, genitore, sindacalista, politico) abbia oggi a che fare con la scuola e l’Università italiane dovrebbe leggere. Tra i numerosi bersagli che i diversi interventi prendono di mira vi è innanzi tutto la sempre più marcata tendenza alla professionalizzazione dello studio, che – secondo Cesare Segre – ha comportato un radicale rovesciamento della tradizionale gerarchia tra arte e tecnica. "Per concepire e realizzare un progetto" scrive appunto Segre "occorrono conoscenze teoriche, e anche una notevole capacità di connettere situazione precedente e risultato previsto e attuabile; è necessario saper organizzare il proprio e l’altrui lavoro, e sottoporlo a una continua critica che ne commisuri l’effetto alle necessità e alla possibilità di attuazione". Non solo, è necessario, se se ne presenta il bisogno, che il responsabile del progetto sappia percepire con prontezza gli eventuali cambiamenti intervenuti nel corso della sua realizzazione e sappia provvedere immediatamente. "Entrano in gioco capacità di analisi e di sintesi, capacità di organizzare il lavoro, capacità di portarlo avanti superando gli eventuali ostacoli" che solo le "materie in senso lato umanistiche, che nel loro spessore storico hanno tesaurizzato esperienze logiche e critiche anche secolari" sono in grado di sviluppare. Le "tecniche", in questo quadro, "potranno essere imparate dopo [corsivo ns], persino in sede di esercitazione, di applicazione o tirocinio". Esse, del resto, "continuano ad evolversi, e chi è aggiornato oggi sarà superato tra un anno. Chi ha appreso a fondo l’arte, invece, potrà facilmente adeguarsi ai mutamenti intervenuti nelle tecniche, o riadattare se stesso con agilità al proprio ambito di azione". Oggi, invece, questo impianto formativo "generalizzante" è stato del tutto abbandonato a favore di un insegnamento che mette al primo posto le "tecniche": gli studenti, ricorda ancora Segre, "vengono […] soppesati, incanalati, classificati, in funzione del loro futuro lavoro", e solo in via del tutto eccezionale viene prevista la possibilità di maturare una scelta diversa da quella originaria. In questo mutato contesto, si è assistito ad una riorganizzazione dei dipartimenti universitari che ha visto una crescente proliferazione dei corsi di laurea e degli insegnamenti. Costantemente all’inseguimento delle "nuove professioni", molte delle quali "sono fuochi di paglia, e declinano con la stessa velocità con cui si sono affermate", le università allettano gli studenti "con percorsi avveniristici o, più spesso, adatti a scuole professionali", al termine dei quali, spesso, chi li ha frequentati si ritrova frustrato, vittima di illusioni di breve respiro. Non solo: "corsi e dipartimenti concepiti secondo "l’ultimo grido", dopo breve tempo possono diventare obsoleti, e le strutture umane e tecniche allestite con fatica e spesa ingente si presentano come fastidiosi relitti". Questa impostazione professionalizzante degli studi non è del resto casuale, e risponde piuttosto a quello che, a detta di molti degli interventi, costituisce la vera "svolta" concettuale all’origine dei numerosi mali che affliggono oggi il sistema educativo italiano, e cioè la supina accettazione della concezione aziendalistica di scuola e università. Ma "è possibile aziendalizzare il sapere?" si domandava su Repubblica del 5 dicembre 2002 Umberto Galimberti, recensendo il libro di Derrida e Rovatti; "È possibile codificarlo per decreto ministeriale senza neppure interpellare i produttori di questo sapere che sono i professori universitari, oggi ridotti a impiegati della didattica creditizia con tempi ridottissimi per la ricerca? È possibile calare tutto questo dall’alto come un nuovo codice della strada con l’istituzione di targhe e libretti di circolazione, dimenticando che lo studente non è un veicolo, che il professore non è un sorvegliante del traffico, e soprattutto che il sapere non è una strada trafficata. E che comunque l’università non è un’azienda che rilascia patenti di guida?". Un’ideale risposta a questi interrogativi viene oggi fornita da Claudio Magris: "L’impresa ha la sua logica e la sua peculiarità e proprio per questo non ogni cosa è un’impresa. Una famiglia, una fabbrica di scarpe e una brigata alpina devono essere tutte gestite con oculatezza economica, senza sprechi e facendo quadrare i bilanci, ma senza scordare che il fine della fabbrica di scarpe è il profitto, il quale invece per la famiglia e per la brigata alpina – e anche per l’università – è un mezzo necessario per realizzare altri fini. La Fiat è un’azienda, l’Italia o la chiesa no". Tra le numerose conseguenze che l’aziendalizzazione di scuole e università ha prodotto quella più negativa è senza dubbio la "concorrenza" tra istituti e sedi universitarie. Già nel 2000 Massimo Bontempelli, parlando dei licei, aveva osservato nel libro citato che i diversi istituti, "per attrarre nel loro ambito il maggior numero possibile di allievi, e la maggiore quantità possibile di iniziative organizzate e di risorse economiche […], cur[a]no molto più la loro immagine esteriore, anche in maniera esplicitamente pubblicitaria, che la loro sostanza educativa, [spingendo] i loro insegnanti a moltiplicare le attività gestionali, di rappresentanza, o di offerta di nuovi servizi, impoverendo gli insegnamenti curricolari di energie, contenuti, tempo e continuità. La cultura, le capacità espressive e lo spirito critico dei giovani che escono da tali istituti sono visibilmente di basso livello, ma di ciò nessuno si cura. Basta, del resto, che una scuola abbia molte attività di intrattenimento, molti computer, e molti corsi di lingue straniere (indipendentemente dal fatto che poi gli allievi imparino o meno effettivamente la lingua studiata), perché la sua apparenza sia vincente sul piano della competizione". Di qui "lo spettacolo desolante degli insegnanti piazzisti del proprio istituto scolastico, di cui vanno a propagandare le virtù spesso inesistenti, per accaparrarsi più utenza". Scrive oggi Massimo Firpo: una "applicazione spesso dissennata dell’autonomia" porta "scuole, università e facoltà […] a contendersi gli studenti non sul terreno della qualità e dell’effettiva serietà degli studi (dal momento che i titoli da esse rilasciati hanno comunque valore legale), bensì su quello della capacità promozionale, dei gadget sportivi e psicopedagogici, delle mode culturali". Concorda Vittorio Coletti: "Nonostante la scarsità dei mezzi, scuole e università si immaginano di vivere allegramente sul "mercato" e usano i pochi fondi a disposizione per farsi pubblicità. I quotidiani sono pieni di inserzioni a pagamento dei vari istituti cittadini, che vantano i loro corsi e diplomi […]. Non ci sono denari per fare entrare giovani ricercatori, non ci sono fondi per borse di studio agli studenti, per laboratori e libri, ma vari milioni di euro del bilancio dell’istruzione nazionale finiscono in pubblicità e campagne promozionali". E quali sono gli obiettivi e i contenuti pubblicizzati? "Non c’è scuola o università che si vanti di avere i migliori professori (facendone magari i nomi) o il più grande patrimonio librario o le biblioteche più aperte e di più facile accessibilità o i laboratori meglio attrezzati: no, ma tutti magnificano prospettive improbabili di carriere, la bellezza del luogo, la pluralità dell’offerta didattica […] ecc.". Del resto, citiamo ancora le parole di Galimberti, "la formazione della personalità, l’autovalorizzazione, il riconoscimento, senza il quale nei giovani non si costruisce alcuna salda identità sono tutti valori spazzati via dalla riforma universitaria, perché sono valori che appartengono ad un’altra economia che non è l’economia aziendale, dove ciò che conta è solo l’accumulo dei crediti e la parziale remissione dei debiti. L’università, infatti, come fanno le banche con i debitori in procinto di fallire, pratica sconti, e a chi aveva trascinato gli studi senza speranza scrive una letterina per dirgli che può farcela ancora, perché con la riforma la strada è più breve e più spianata, basta che si procuri una calcolatrice e traduca tutti gli esami sostenuti, quando era in corso e fuoricorso, in crediti, fino a raggiungere la fatidica quota 180 che gli concede la laurea di primo livello per la gioia delle statistiche che in questo modo attestano la produttività dell’istituzione". E proprio l’introduzione dei crediti ha prodotto, secondo gli autori di questo libro, conseguenze fortemente negative: "I crediti hanno imposto una gretta mentalità" scrive Magris, "secondo la quale ogni attività dello studente – dalla lettura di un libro a una corsa campestre – deve comportare un utile formale e immediato. […] I crediti disabituano ad investire. Ogni investimento, all’inizio, è un rischio; le cose che facciamo solo per amore – anche leggere un libro – sono spesso quelle che poi ci rendono di più, ma indirettamente, ed è ridicolo pretendere punti perché si è letto – si spera con passione – Leopardi". Poiché, oggi, per laurearsi è previsto che si conseguano almeno dieci crediti in attività e competenze "altre" (linguistiche, informatiche, professionali, lavorative ecc.), con il sistema dei crediti ciò significa sostenere un corso supplementare di almeno 60 ore, oppure svolgere uno stage di 250 ore presso aziende o enti convenzionati. Presso le facoltà di Lettere, ricorda Coletti, gli studenti "lavorano lietamente in piccole case editrici, biblioteche, teatri, dove svolgono formative mansioni di fattorino, telefonista e perfino anche di portinaio.Comune a tutti gli interventi è il rifiuto di venire considerati i cantori del bel tempo antico. Nessuno nasconde che la scuola italiana presentasse carenze e ritardi anche molto gravi (tra gli altri, Vittorio Coletti ricorda i "risultati disastrosi" dell’insegnamento delle lingue straniere, il ritardo tecnologico di gran parte delle scuole italiane, quasi sempre sprovviste di aule attrezzate, la mancanza di un reale aggiornamento dei docenti, "demotivati da stipendi infamanti e spossati da un’infinità di mansioni burocratiche") o che troppi studenti non riuscissero a portare a termine gli studi o andassero fuori corso; o che, più in generale, il nostro sistema educativo avesse bisogno di un processo di modernizzazione. Nessuno rimpiange la vecchia università di élite, inaccessibile a larghissimi strati della popolazione, che è stata progressivamente sostituita, negli ultimi decenni, dall’università di massa. Ma "che si debba per questo abbassare il livello degli studi" afferma Mengaldo, "è una conclusione non solo semplicistica ma errata, e offensiva per quelle "masse". I nuovi soggetti e – attenzione – i nuovi ceti che si sono affacciati, come non succedeva da tempo, agli studi universitari, […] hanno invece assolutamente diritto a un insegnamento del più alto livello possibile, pari a quello dei tempi delle élite. Chi ragiona [diversamente] ragiona, penso senza rendersene conto, con una mentalità classista". Quasi le stesse parole usa Beccaria: l’attuale "abbassamento del livello [degli studi] sta diventando offensivo per quelle masse, le quali hanno diritto a un insegnamento del più alto livello possibile: a una tavola imbandita, non alle briciole di un pasto". Di fronte a questa situazione, "grave è il disinteresse per non dire la sordità della politica, e a dire il vero anche dell’opinione pubblica", sottolinea preoccupato Massimo Firpo; e ancora più grave, prosegue, "mi sembra l’esorcizzare [le denunce che da gran parte della cultura italiana si levano contro questo stato di cose] come mere resistenze passatiste, se non reazionarie, nei confronti dell’innovazione, dal momento che esse si levano non a difesa della vecchia scuola, ma a sollecitare riforme serie, che puntino su una riqualificazione del ruolo dell’insegnante, sull’esigenza di investire risorse cospicue nel sistema pubblico dell’istruzione, su una rivalutazione dei suoi compiti formativi, sulla necessità che esso offra equamente possibilità di promozione individuale e sociale".
Se l’analisi della situazione contenuta in questo libro è corretta, le prime vittime di questo stato di cose sono naturalmente gli studenti. Da un lato, infatti, essi vengono progressivamente allontanati da "quelle discipline che […] aiutano alla riflessione storica o estetica o filosofica o letteraria. Discipline […] che hanno favorito fino a ieri la maturazione di uno spirito critico, e l’educazione alla libertà, alla pluralità, alla tolleranza, acquisti e "valori"" scrive ancora Beccaria "che non vorremmo venissero a mancare al mondo che le nuove generazioni abiteranno". Dall’altro, a fronte di questa grave menomazione condotta nel nome della professionalizzazione, non si forniscono loro neppure reali sbocchi professionali, come ha ricordato su Repubblica dell’8 giugno 2004 Pietro Citati parlando del destino futuro degli attuali studenti della facoltà di Lettere: "la laurea breve non porta a nessun lavoro. In realtà, è una truffa. Non permette di insegnare nelle scuole medie e nei licei: consente, sì, di diventare redattore nelle case editrici, dove nessuno accoglierà mai un ventunenne che ignora la lingua italiana. Permette di fare la guida turistica e il custode dei musei: ma non credo che la richiesta sia grande". Ma ricadute negative si hanno anche sul corpo docente, sulle cui funzioni originarie si è nel corso degli ultimi anni innestato un crescente cumulo di impegni gestionali, amministrativi, organizzativi, burocratici, accompagnati spesso – per lo meno a livello di scuole medie e superiori – da una crescente disistima sociale. Ancora Coletti: "Se i professori non studiano più o studiano meno; se i loro corsi sono inevitabilmente più ripetitivi e meno vitalizzati dalla ricerca; se le loro mansioni sono sempre più burocratiche, scuole e atenei vedranno emergere una tipologia di docente burocrate e logorroico, intellettualmente ammuffito, che si rianima solo nelle mille riunioni come un solitario pensionato del condominio che si eccita nelle assemblee annuali per il rifacimento delle scale". Giorgio Bertone: "Abolendo […] i rapporti che garantivano ruolo e dignità del docente, abolendo gli esami, abolendo le "riparazioni" a settembre […], inventando il 6 "rosso" o con asterisco (per cui i 4 e i 5 diventano sufficienze politico-sociali, realizzando trent’anni dopo i sogni peggiori del Sessantotto), insomma programmando la promozione garantita fino a 18 anni (perché di questo si tratta, anche se L[uigi] B[erlinguer] non ha il coraggio di dirlo) con "debiti formativi" che ricevono un condono perenne (ora anche all’università), si pone l’insegnante in una posizione professionalmente, psicologicamente, umanamente debolissima; lo si espone, giorno dopo giorno, alla gogna del menefreghismo o della strafottenza degli studenti peggiori e al triste spettacolo dello sconforto, del senso di giustizia offesa, di inutilità, dei migliori e più impegnati". Non mancano nel libro interventi meno direttamente polemici con l’opera riformatrice attuata dai ministri che si sono succeduti nelle stanze di Viale Trastevere negli ultini anni e più orientati a spostare la riflessione sui cambiamenti che negli ultimi decenni hanno investito i processi di apprendimento e di comunicazione. È il caso di Raffaele Simone il quale, riprendendo in parte le tesi già esposte in un suo noto saggio (La terza fase. Forme di sapere che stiamo perdendo, Laterza 2000), sottolinea come, a partire almeno dalla fine degli anni Ottanta, a causa del progressivo affermarsi di quella che egli definisce "una delle maggiori "rivoluzioni cognitive" che il pianeta abbia conosciuto", e cioè lo straordinario sviluppo "delle tecnologie, delle risorse, degli atteggiamenti e delle pratiche connesse con l’informatica e la telematica", il tradizionale paradigma di acquisizione del sapere (da lui definito endopaideia, e sinteticamente riassumibile nella convinzione che la scuola fosse "un recinto chiuso […] in cui si impartiva un sapere legittimato – cioè dotato di senso, accettato da tutti e riconosciuto come "pregiato", "valido", sicuro e indiscutibile", "desiderabile e ricercato", un sapere ottenibile solo attraverso un metodo di lavoro i cui imprescindibili prerequisiti erano la lentezza, la fatica, la pazienza, l’attenzione) sia entrato in crisi, a causa delle "crescenti masse di conoscenza autonoma, anche di tipo razionale" che il "mondo esterno" (alla scuola) ha cominciato a produrre. Ciò ha fatto gradatamente emergere un nuovo paradigma di formazione – l’esopaideia –, secondo il quale "l’acquisizione del sapere (quello valutativo non meno di quello razionale) non è più un processo sistematico, disciplinato e metodico, e non ha alcun bisogno di svolgersi nella scuola. Questo tipo di paideia non ha più nulla a che fare con la scuola come istituzione-recinto, la considera, anzi, come il suo contrario. Le cose che si imparano "fuori" sono più divertenti, semplici e ricche di vita di quelle che si imparano "dentro". L’acquisizione del sapere deve sbarazzarsi del fattore "pena", di "penitenza" e di "noia" che lo ha contrassegnato per secoli". "Via via che l’esopaideia prende rilievo, l’endopaideia si ritrae e rivela la propria vera natura: è un castello separato dal mondo esterno, silenzioso e astratto. La vitalità è altrove [corsivo nel testo], è fuori, e lì bisogna ricercarla. Interi settori del sapere sono quindi classificati come poco rilevanti o irrilevanti, trattati di conseguenza e sottoposti a stigma o a dimenticanza". La sistematica "svalutazione della storia (e del passato in generale)" che ne consegue "è favorita poderosamente da due fattori correlati: la diffusione capillare, fino alle estreme frange della società, di una sorta di inesorabile "americanismo" volgare" secondo il quale "tutto ciò che sta alle nostre spalle conta meno di quel che sta dinanzi, del futuro, del "sogno"" e "l’imporsi di modelli genericamente "tecnici" di sapere", per i quali "conta solo quel che funziona (non quel che "pone problemi" o "che si guasta") e non importa domandarsi come le cose sono cominciate: il passato è solo una serie di "errori" che devono essere accantonati e dimenticati, salvo ripescarli come pretesti di entertainment, per esempio per sfruttarli in film con una certa quota di effetti speciali". Questioni, quelle sollevate da Simone, tutt’altro che di scarso peso, che tuttavia non ridimensionano affatto, a nostro parere, la validità delle critiche mosse dagli altri interventi raccolti in questo libro alle politiche della scuola attuate negli ultimi anni dai governi di destra e di sinistra che si sono avvicendati alla guida del Paese. Particolarmente dure sono quelle che Michele Loporcaro, dopo aver passato in rassegna i danni prodotti nel sistema educativo italiano dalla demagogia antimeritocratica diffusasi dopo il Sessantotto, muove alle forze di sinistra. Quasi prendendo idealmente spunto dalle complesse problematiche evocate da Simone, Loporcaro sostiene infatti che "Il progresso tecnologico non si può arrestare. Si può però gestire. Vale per la natura […]. E vale per la cultura: il progresso tecnologico va gestito con una politica culturale". Proprio qui, a suo dire, si si dovrebbe collocare il discrimine tra destra e sinistra in materia di politica scolastica: "Qui entra in gioco la scuola. O meglio, deve [corsivo nel testo] entrare in gioco, per un programma politico di segno progressista. La scuola deve sottoporre il progresso tecnologico a vaglio critico. Deve dare ai cittadini gli strumenti per analizzare la realtà sociale nei suoi diversi aspetti: la politica come la tecnologia. Questi strumenti sono la capacità di riflessione autonoma e il senso critico". "Per un programma politico di segno totalitario-reazionario, invece, è funzionale una scuola che si allinei pedissequamente ai cantori acritici del progresso tecnologico". Le due posizioni politiche, prosegue Loporcaro, non possono essere che nette: un programma democratico-progressista cercherà di frenare la "deriva" verso il futuro orwelliano preconizzato dagli esperti di comunicazione di massa portando "cerchie sempre più ampie della popolazione a partecipare [delle] capacità di riflessione e di discussione"; viceversa, un programma reazionario-totalitario "la favorirà con ogni energia". In questo senso, "se un governo di destra con tendenze autoritarie propone un modello di scuola imperniato sulle "tre i", internet, inglese, impresa, agisce lucidamente […]. Una scuola così concepita, avvicinando ai media visuali, allontanerà dal libro e deprimerà in tal modo la sensibilità culturale, la coscienza della storia e delle specificità culturali […]. Una scuola così prepara un mondo in cui si parla una lingua sola, radicalmente semplificata, e prepara non cittadini responsabili, parte di un’articolata società civile, ma futuri dipendenti di un’impresa, semplici sudditi di un potere economico i cui interessi si fondono con quelli dello stato", un’"anomalia" tutta italiana, quest’ultima, a cui guardano con preoccupazione gli osservatori europei (come ha scritto lo scorso anno su "MicroMega" Umberto Eco, qui citato da Loporcaro: "le preoccupazioni della stampa europea [nei confronti dell’Italia contemporanea] non sono dovute a pietà e amore per l’Italia ma semplicemente al timore che l’Italia, come in un altro infausto passato, sia laboratorio di esperimenti che potrebbero estendersi all’Europa intera"). Ma se "chi ha in mente una società totalitaria" prosegue Loporcaro "fa benissimo, dal suo punto di vista, a tagliare i fondi all’università e alla scuola, e fa benissimo a introdurre il video […] al posto del libro, l’inglese anziché tutto il resto (greco, latino, italiano, storia), l’impresa (o l’autoscuola, o l’apparecchiatura della tavola eccetera) anziché la cultura", "chi ha un’altra idea, un altro ideale di società [dovrebbe] opporsi [a tutto ciò]. Questo, in Italia, non succede per un difetto grave dello schieramento progressista, che infatti ha collaborato allegramente, al grido "il computer a scuola", alla virata in direzione utilitaristico-aziendalista che ora il governo attuale vuol giustamente, dal suo punto di vista, completare". Lo stesso concetto è ribadito poco oltre: "Che la destra italiana lavori coerentemente per favorire questi esiti [trasformare i cittadini-elettori in persone con un "livello intellettuale d’uno scolaro di seconda media, neppure tra i più bravi"] è ovvio. […] Ma che lo schieramento progressista proponga, ai suoi massimi livelli, un’ideologia e una prassi oggettivamente in linea con questi stessi principi, è parte integrante del problema centrale della politica italiana contemporanea: l’indistinzione degli schieramenti e la mancanza di una reale alternativa", che si manifesta anche in altri campi: "Alla demolizione dello stato sociale, alla deregulation e al prevalere del capitalismo selvaggio si lavora concordemente, da destra come da "sinistra". E così alla sostituzione del libro con lo spettacolo". Di qui l’appello che Loporcaro rivolge allo "schieramento progressista": è assolutamente necessario e urgente che quest’ultimo "acquisti consapevolezza di questa oggettiva convergenza con il programma berlusconiano e del suicidio politico che essa comporta". Come si vede il libro – che si conclude con una sorta di divertissement ad opera di Pier Marco Bertinetto il quale, con l’abituale ricorso alla tecnica del "manoscritto ritrovato" in un imprecisato futuro, presenta in modo brillante e al tempo stesso efficace il contrasto tra "novatori" e "tradizionalisti" in materia di politica scolastica che afflisse l’Italia "all’inizio del terzo millennio" – offre ampio materiale di riflessione. Un solo rammarico rimane a libro concluso: che esso raccolga le analisi e le denunce esclusivamente di studiosi impegnati sul versante umanistico. È pur vero che la loro critica si estende all’intero ambito scolastico e universitario, ma sarebbe senza dubbio interessante poter affiancare a queste anche le voci e le esperienze di quanti nella scuola e nell’università sono più direttamente a contatto con gli insegnamenti scientifici. Possibile che riforme tanto radicali come quelle che qui vengono denunciate non abbiano inciso in alcun modo, nel bene o nel male, sul versante scientifico degli studi? A quando una analoga riflessione di docenti e intellettuali impegnati su questo fronte?