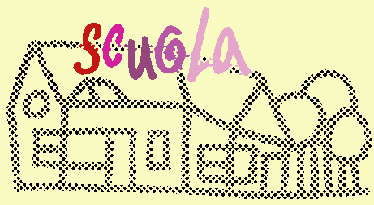 |
PavoneRisorse |
(11.09.2014)
Diversità,
differenze, diffidenze
di Franco De Anna
La “diversità”, si dice, è un valore. Come in un detto del
Talmud “Il Signore ha parlato, e io ho sentito due voci”. La diversità implica
il dia-logo. Ben vengano dunque le diverse voci.
La “differenza” invece, richiama e implica la ”sottrazione”. Il “togliere”
invece che l’unire. Il “ritrarsi”.
La “diffidenza” accompagna la differenza, costruendo il muro protettivo che
allontana la doppia voce del dialogo e risparmia la fatica dell’ascolto. Non si
impara nulla dalla diffidenza
La discussione attorno al documento del Governo sulla scuola mi sembra
riproporre l’attenzione a queste categorie. Constatazione un poco perplessa,
trattandosi di una discussione che avviene tra “addetti ai lavori”; in questo
caso tra “intellettuali” la cui responsabilità fondamentale è quella di
“produrre e riprodurre” significati sociali.
Una responsabilità che implica che, quale che sia la propria opinione sempre da
rispettarsi, la sua espressione sia accompagnata da “pensiero e analisi” capaci
di dare “ragioni” e ausilio alla significazione, al di là, ovviamente della
condivisione.
Provo a ripercorrere i punti più problematici del documento in discussione e le
reazioni che suscita, chiarendo fin da subito che non sarà il tentativo di
esplorare e rintracciare “ragioni” a farmi classificare come un “renziano” (non
lo sono..) o come un “antirenziano”.
Come in ogni contributo che si rispetti (e che sia sufficientemente noioso)
pongo una premessa di fondo.
Mi sono fatto la convinzione radicale che il nostro Paese si trovi, non da oggi,
a misurarsi con tre questioni di fondo maturate lungo tutta la sua storia,
recente e meno recente: la prima è la presenza densa e articolata di oligarchie
e corporazioni che si estendono sull’intera formazione sociale; la seconda è
l’assenza di realtà e cultura del mercato e delle sue funzioni, sempre
mortificate e compresse, in modalità tanto più efficaci ed occulte quanto più se
ne predichi ideologicamente la funzione salvifica (e così rinunciando ad ogni
effettiva e reale regolazione del mercato stesso). Già Gramsci ricordava
l’assenza di cultura liberale della borghesia italiana e, in parallelo, la sua
permanente tentazione “eversiva”.
La terza questione è il carattere di un sistema di welfare che protegge i
protetti e che, con il suo carattere previdenziale e assicurativo è lontanissimo
da un welfare di cittadinanza. Ognuno comprende che le tre questioni sono
largamente intrecciate tra loro nei caratteri del “compromesso sociale” che ha
accompagnato lo sviluppo del Paese, soprattutto negli ultimi quaranta anni. Ciò
che oggi non “tiene più” sia per il decadere delle risorse disponibili per quel
compromesso, sia per le modificazioni della stratificazione sociale, sia per il
mutamento delle strutture e dei processi produttivi.
Questa convinzione mi porta a confrontare e giudicare ogni politica pubblica
sulla base della sua possibilità/capacità di modificare realmente “qualche cosa”
rispetto a quelle tre “questioni” che rappresentano a mio parere la sfida per il
futuro. Ad esse faccio richiamo anche nel caso della politica scolastica.
In Costituzione il diritto
all’istruzione come fondamentale diritto di cittadinanza è articolato in
(almeno) due affermazioni (art. 34).
“L’istruzione inferiore, per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita”. Si
tratta dunque di un diritto incondizionato: le risorse pubbliche garantiscono la
piena fruizione di tale diritto da parte dei cittadini.
La seconda parte dell’art 34 garantisce a tutti l’accesso all’istruzione
superiore; ma è un “diritto condizionato”, la cui fruizione non è gratuita.
Richiede risorse da parte del cittadino che ne usufruisce, tanto è vero che
l’articolo prosegue dicendo che per “i capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi” la Repubblica provvede con contributi elargiti su base concorsuale.
L’istruzione superiore è un diritto, ma non gratuito: risorse pubbliche e
investimento privato (del singolo cittadino) si integrano.
Le proposte contenute nel documento governativo sono più che discutibili; ma
francamente l’appello alla Costituzione di qualche “oppositore” perché i costi
dell’istruzione siano integralmente coperti da risorse pubbliche è privo di
fondamento. Certo le parole dei costituenti appaiono oggi in parte obsolete
(quel “capaci e meritevoli” e quelle risorse distribuite per concorso appaiono
di un “altro tempo”). Se ne può convenire (mah!!…); ma allora occorre essere
disponibili ad affrontare una discussione seria su quantità, qualità e
distribuzione delle risorse necessarie al sistema di istruzione. E forse anche
realizzare che i padri costituenti (che certo non erano pedagogisti) dicono
“istruzione inferiore”, non scuola elementare e scuola media, e con quei termini
accennano certamente ad una “unitarietà” di quel livello di istruzione (la base
minima di cittadinanza) che rappresenta un orizzonte tuttora da realizzare di
fronte a ordinamenti permanentemente segmentati, differenze di culture ed
immaginari professionali, stratificazioni di interessi di settore… (di salari e
di orari..) Ricordiamo che ci si sta provando solo da poco e con strumenti
surrettizi di tipo organizzativo più che ordinamentale (i Comprensivi). Per
tacere del livello di sconsapevolezza e socializzazione della impostazione
“unitaria” dell’obbligo scolastico attuale. (Intervistare in proposito, per
esempio, una scrittrice di grande successo di massa come la Mastrocola)
D’altra parte se guardiamo alla distribuzione della popolazione scolastica
relativamente ai livelli di istruzione e alla piramide che si restringe
progressivamente dall’istruzione inferiore a quella superiore e fino
all’Università, risulta evidente la contraddizione reale tra una ispirazione
universalistica del diritto all’istruzione e la base sociale progressivamente
ristretta che ne usufruisce: le risorse pubbliche necessarie alla istruzione
superiore sono distribuite “controgradiente” rispetto alla distribuzione del
reddito (capisco che sia una provocazione, ma ci si provi a confrontare “tariffe
pubbliche”, dichiarazioni dei redditi e ….evasione fiscale in diverse
Università.. Quanto ai capaci e meritevoli…)
Sia sufficiente tutto ciò, per ora, a ricordare che porre la questione del
rapporto tra risorse pubbliche e private per il funzionamento reale del sistema
pubblico di istruzione, è porre un problema reale (vedi oltre), per il quale
occorre scegliere e discriminare risposte e soluzioni (non affermazioni
“ontologiche”): non è affatto il “sintomo” di opzioni privatistiche e di
dismissione del sistema pubblico, e tanto meno di vulnus costituzionale.
Quella che in letteratura si indica come
“crisi fiscale dello Stato” è processo storico che investe i sistemi di welfare
(almeno quelli europei) a partire dagli anni ‘80. In estrema sintesi si
configura come la contraddizione tra l’ispirazione universalistica di quei
modelli di welfare, la effettiva distribuzione sociale del reddito e dunque la
distribuzione e l’entità del prelievo fiscale necessario a supportare la
produzione di servizi sociali coerenti a quella ispirazione, e i costi interni
di organizzazione, riproduzione, gestione dei grandi apparati pubblici che alla
produzione di quei servizi dovrebbero provvedere (costi interni di
riproduzione spesso “autonomi” o comunque disfunzionali rispetto a quelli di
produzione dei servizi).
Quella crisi ha dato spazio alla controffensiva storica, innanzi tutto
politico-culturale, del neoliberismo (la “società non esiste” come diceva la
Thatcher e dunque smontiamo il welfare) ma ha anche ispirato tentativi di
riforma delle strutture e dei modelli di gestione degli apparati pubblici:
perché si mantenesse il loro carattere pubblico e contemporaneamente si
adottassero modelli gestionali capaci di dare produttività, efficienza, e di
porre al centro la “produzione” del servizio di cittadinanza, piuttosto che la
“riproduzione” degli apparati e dei loro “manuali operativi”. Cito solo la
scuola del New Public Management, con le alternative tra stato producer e
stato provider, categorie interpretative come il “quasi-mercato”,
l’enfasi sulle attività di miglioramento organizzativo e di valutazione dei
risultati.
Lascio ai lettori (eventuali) il compito di ricostruire il quanto, il come e il
perché la “classe politica” (intera) del nostro Paese sia stata in-capace di
affrontare quella crisi (quella sì “epocale”) dei modelli di welfare e di
ridisegnare i caratteri dell’intervento pubblico nell’economia e nella
“produzione” di servizi alla cittadinanza. Do solo un amaro suggerimento di
riflessione storica.
Nel febbraio del 1992 il Governo italiano (Andreotti) firma il trattato di
Mastricht che impegnava i Paesi europei a promuovere una convergenza reale nelle
strutture dei propri bilanci pubblici (al di là delle discutibili
parametrizzazioni), a partire proprio dalla consapevolezza della necessità di
pervenire a modellizzazioni e strutturazioni diverse dal passato dell’intervento
pubblico in economia e nella produzione di servizi.
Il trattato avrebbe dovuto aprire un decennio di “politica” e “politica
economica” capaci di realizzare quell’idea di convergenza e arrivare alla moneta
unica. Venti giorni dopo quella “storica” firma, nel nostro Paese partiva
Tangentopoli; nello stesso anno le stragi di mafia, e a seguire la fine
(ingloriosa) delle forze politiche che avevano gestito e governato il
“compromesso sociale” su cui si era modellizzato l’intervento pubblico, la
distribuzione della spesa, i caratteri del welfare, il diverso e variegato
protezionismo della borghesia italiana. Nei vent’anni successivi la politica
italiana ha fatto altro. E la società italiana, e la cultura italiana si sono
adeguate.
Nello sfacelo politico, proseguito negli anni seguenti, la continuità degli
apparati: la Pubblica Amministrazione, Il Consiglio di Stato, la Ragioneria, la
Corte dei Conti, i Tar (le stesse cose con cui dovrebbe fare i conti la riforma
della pubblica amministrazione che si annuncia: molto di più complessa che non
la predicazione della mobilità dell’usciere o dei dirigenti, comunque
necessari). Il “manuale operativo” della Pubblica Amministrazione garantiva la
riproduzione. Altro che New Public Management…
Qualche cosa si tentò, alla fine degli anni ’90, per esempio con la “Bassanini”
e, per la scuola, con l’autonomia scolastica. Ma forse affrontare quella svolta
in termini di rielaborazione di New Public Management nell’istruzione era
chiedere troppo (sebbene alcuni esempi nel settore della sanità siano più che
confortanti). Nel quindicennio successivo Viale Trastevere si rimangiò tutto,
non solo le risorse economiche, ma le stesse condizioni gestionali e
organizzative.
Curiose e istruttive le alleanze sociali e politiche realizzate lungo tale
“controffensiva”. In qualche intervento in questo dibattito l’autonomia
scolastica sarebbe il frutto di un tentativo di destrutturazione sistemica e
(notevole azzardo argomentativo) di una linea di continuità politica che unisce
i vecchi “comunisti” e i giovani “renziani”. In mezzo alla “congiura”,
morattiani e gelminiani variamente “funzionalizzati”. Per favore….
Proviamo a prendere per buona, fino a
prova contraria (un ipotetico cartesiano…) quella che può sembrare una
boutade del documento del Governo e che chiede di indicare le 100 norme
amministrative da abolire… Proviamo a farne un terreno di battaglia politica e
culturale che mira al bersaglio grosso: al superamento del “manuale operativo”
che assimila la scuola (produzione di servizi alla cittadinanza) alla Pubblica
Amministrazione (autorizzazioni, permessi, elaborazioni di “atti”, applicazioni
di “norme”).
Una sfida che guarda alla scuola come ad una impresa (combinazione di risorse
economiche ed umane, di strutture e di lavoro collettivo finalizzato ad un
traguardo comune, da raggiungere nel modo più efficace ed efficiente) il cui
obiettivo è “produrre” un servizio ad un diritto di cittadinanza… L’autonomia è
questa sfida. Nei confronti di Viale Trastevere prima di tutto (la quinta
colonna opera sempre nel quartier generale).
L’accostamento ha interpreti vari, da
Bertinotti (probabilmente fu il primo ad utilizzarlo nella polemica politica) a
Tremonti (che usava l’argomento per altri fini..). Ma indubbiamente si basa su
dati oggettivi. Si consulti il periodico Bollettino dell’Ufficio Studi della
Banca d’Italia che regolarmente dà conto della ricchezza delle famiglie
italiane, o si consultino le comparazioni internazionali. A fronte del dato
nazionale del debito pubblico senza confronti, si erge il dato di una notevole e
significativa consistenza del risparmio privato.
Ovviamente la sua distribuzione sociale è tutt’altro che omogenea e stabile ; ma
il possesso di titoli di stato, di obbligazioni, di Fondi, e, soprattutto, di
proprietà immobiliari, ha un “plafond sociale” significativamente diffuso ed
allargato.
Naturalmente l’oggettività del “dato” abilita (come sempre se ci si limita ai
“dati”) le interpretazioni politiche anche opposte. Per qualcuno la consistenza
del risparmio privato è di conforto ad una politica fiscale più “disinvolta (che
anche i ricchi piangano); per altri è l’invito a non drammatizzare i vincoli
europei sulla “disinvoltura” della gestione dei bilanci pubblici (in fondo
compensiamo..).
La domanda (eterna), di chiunque si misuri con i problemi di governo della
“città” (da Pericle a Quintino Sella..) è quella di come “mediare” tra la
ricchezza privata e le necessità, i bisogni e gli impegni del “pubblico”.
La “mediazione” tradizionale è quella
fiscale: i cittadini pagano le tasse e in modo proporzionale e progressivo. Lo
Stato usa tale “ricchezza” di provenienza “privata” ridistribuendola in servizi
alla cittadinanza. Ma un’altra mediazione è costituita dall’acquisto di debito
pubblico: se il privato acquista titoli del debito, finanzia lo Stato
(ricavandone un beneficio assoluto ma anche relativo con un trattamento fiscale
di favore). La situazione nazionale è nota: sono diffusi entrambi i tipi di
mediazione, cui se ne aggiunge un terzo, consistente, che nega la prima
mediazione (evasione) ed usa la seconda che garantisce un “di più” di
trattamento fiscale di favore.
Non mi interessa, in questa sede, la polemica specifica: l’articolata fisionomia
dell’evasione fiscale, i vincoli di altro tipo (mercato) che inibiscono
l’indirizzamento della ricchezza privata in impieghi produttivi, il peso
dell’intermediazione finanziaria e bancaria, la vocazione all’investimento nella
casa (con le distorsioni che tale domanda ha indotto nello stesso mercato
immobiliare)
Mi interessa invece sottolineare che il “patto sociale” che dovrebbe governare
l’efficacia delle diverse mediazioni tra ricchezza privata e necessità pubbliche
si destruttura per un insieme di concause: dalla elevatezza formale del prelievo
fiscale (un serpente che si morde la coda con l’evasione), alla considerazione
della scarsa efficacia ed efficienza dei servizi pubblici finanziati con il
prelievo, alla inesistenza di strumenti di semplice gestione di mercato (i
salotti buoni e le matrioske del capitalismo nazionale) per fare affluire
ricchezza privata verso destinazioni finalizzate, produttive ed esplicitamente
dichiarate e non semplicemente verso la indifferenziata macchina della spesa
pubblica, alla inesistenza di forme di rendicontazione sociale da parte delle
amministrazioni pubbliche, capace di coinvolgere i cittadini “finanziatori”.
Anni fa proposi, provocatoriamente, la emissione di bond finalizzati
all’istruzione (lo fanno molte università americane, come MIT di Boston per es..),
in modo che l’investimento della ricchezza e del risparmio privato con tale
finalizzazione potesse testimoniare l’effettiva consapevolezza (e speranza) di
ciò che, a parole, tutti sostengono: che le risorse impegnate in istruzione sono
realmente “produttive”.
Pur con l’insopportabile deriva anglicista (ha ragione Vertecchi) nel documento
del Governo si ripropone il tema della confluenza “finalizzata” di ricchezza
privata nel funzionamento dell’istruzione pubblica (esenzioni fiscali,
partecipazioni, fondazioni ecc…).
Il dato di realtà è difficilmente controvertibile: nei bilanci delle scuole
(resi opachi dalla esistenza anche cospicua di residui dovuti ad una
amministrazione pubblica creditrice inadempiente..), i contributi delle famiglie
rappresentano risorse “effettive” da utilizzare per le diverse necessità: da
quelle istituzionali di miglioramento dell’offerta formativa a quelle di
gestione di cassa mortificata dai ritardi della Pubblica Amministrazione, anche
per i consumi di gestione corrente.
La comparazione internazionale ci dice che in Italia tale contributo è assai più
basso di quanto avviene in Gran Bretagna, in Spagna, in Francia…Dunque non è
problema isolato e inaudito, ma comune. Di fronte a tale realtà, invece che una
invettiva frustrata avverso al pericolo di privatizzazione, mi pongo tre
problemi.
Il primo: l’autentico impegno (e fatica) democratico è dare conto alla comunità
locale, ai cittadini che fanno affluire risorse nella scuola, sia attraverso la
fiscalità che in forme finalizzate, di come queste sono impegnate e spese, e non
spedire un documento di bilancio verso un cassetto della rispettiva Direzione
Scolastica Regionale. Certo in tale impegno sta anche la dignità del
“funzionario” pubblico che sa iscrivere e ricondurre l’interesse locale entro
quello generale. Altrimenti a cosa servono i dirigenti pubblici?
Il secondo: posto che tale contributo di ricchezza privata sia così
significativo, cosa è meglio per salvaguardare da eventuali pericoli di
“privatizzazione” il carattere pubblico della produzione del servizio alla
cittadinanza? Raccogliere contributi individuali, segmentati, parziali e
dispersi, oppure caratterizzare tale contributo in termini di consapevolezza e
socializzazione? Meglio un contributo che proviene da una associazione di
cittadini, da una fondazione (con i loro organismi di gestione, controllo,
socializzazione) o quelli legati alla discrezionalità di un “privato
individuale”?
Il terzo: se il contributo delle famiglie e dei privati è già oggi così
significativo quantitativamente, e essenziale per la produzione di esperienze e
progetti qualificanti per la produzione del servizio, per quale straordinaria
ragione si deve darne conto utilizzando gli strumenti della contabilità
pubblica? Cioè nella formazione di un bilancio di natura squisitamente
finanziaria e non economica come quello pubblico; di difficile, se non
impossibile, approccio analitico e di rielaborazione dei costi effettivi; di
carattere formale e formalizzato (il controllo è in realtà la corrispondenza
delle poste in entrata e uscita: che cosa si sia davvero fatto sfugge e/o non
interessa ai revisori).
Domanda resa ancora più cruciale dal fatto che il “contributo pubblico” è oggi
spesso fonte di opacità dei bilanci delle scuola dovuta al cumulo dei residui e
del ruolo debitore della Pubblica Amministrazione.
Di nuovo invito: accogliamo la sfida a indicare norme amministrative inutili e
dannose puntando sulla necessità di rivedere l’applicazione pedissequa dei
modelli di contabilità pubblica (amministrazione) alla “produzione” di un
servizio ai cittadini come l’istruzione. Del resto il “regolamento” economico e
finanziario fu assunto come provvisorio e passibile di verifica successiva nel
momento dell’autonomia… è diventato “altro” nel frattempo (quindici anni…).
Il modello selettivo, autoritario, gerarchico e discrezionale del merito e della valutazione.
Alla fine del mio primo anno di servizio
come docente (1970/71 un istituto professionale) il Preside, dandomi la “nota di
qualifica” ( la valutazione annuale) mi disse, per giustificare un “distinto”
invece di “ottimo”, e con molta tranquillità “ Sa professore, è il suo primo
anno di lavoro, non posso, darle un “ottimo”, anche se sono molto contento di
lei… Il prossimo anno, se proseguirà così..”. Incassai e… basta.
L’anno successivo ero entrato in ruolo e nelle mani del mio Preside (diverso dal
precedente), depositai la promessa solenne e poi il giuramento di fedeltà alla
Costituzione ed alle Leggi dello Stato. Da comunista ero formato alla ribellione
e congiuntamente alla “disciplina” della ribellione. Ne avrei avute di cose da
dire su entrambe le procedure, ma le accettai.
Quale immagine della autorità e della “discrezionalità” dell’esercizio della
dirigenza pubblica è paragonabile a quella qui presentata. E (quasi) più quella
simbolica di chi raccoglie il tuo giuramento (per la vita e la professione) che
non quella di chi ti da la nota di qualifica…
Come sappiamo quell’incastellatura di gerarchia è stata smontata: non si valuta
più, ma neppure si giura più… ( e non voglio commentare i pro e i contro…). Ma
certo la tendenza pluridecennale è stata quella della destrutturazione della
piramide gerarchica. Affermare il pericolo del contrario, oggi, è descrivere una
realtà inesistente.
E’ sempre possibile sostenere che frequentiamo scuole diverse: così si potrebbe
comprendere come mai per qualcuno le scuole siano oppresse da una domanda di
partecipazione da parte di imprese e privati che vogliono determinarne, fino ad
impadronirsene, la gestione e conduzione; allo stesso modo per qualcuno vi sono
dirigenti scolastici scrupolosi che resistono a fatica ad offerte di
finanziamento privato che, in modo occhiuto ed interessato, vorrebbero
determinare indirizzi, modalità di gestione, uso delle strutture e dei
prodotti. (!?)
Ed allo stesso modo vi sono Presidi che non vedono l’ora (!?) di misurarsi con
la fatica ( e la responsabilità) di andare a caccia, sul mercato del lavoro
caratterizzato da una sproporzione enorme tra domanda e offerta, degli
insegnanti che effettivamente siano di loro gradimento. Poco importa che anche
nelle imprese la assunzione del personale sia una delle attività più gravose,
incerte e meno gratificanti, soprattutto a fronte della incommensurabilità tra
domanda e offerta, (c’è letteratura su questo: da Ottieri a Volponi); ma da noi
fanno testo Rembado e le sue giaculatorie.
Per alcuni tutto ciò è un pericolo implicito nel documento governativo.
Non c’è come costruirsi da sé i bersagli per essere sicuri di centrarli…