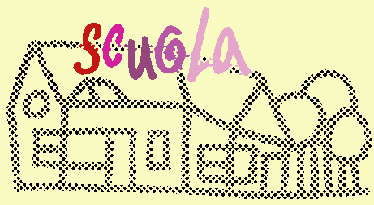 |
PavoneRisorse |
(12.10.2014)
Valori
assoluti, valori condizionati e ingorghi dialettici
di Franco De Anna
Un ministro di cui
pochissimi sentono nostalgia, è comunque citatissimo per avere affermato che
“con la cultura non si mangia..”. Non so se lo fece ad arte, ma in tale modo non
si smise di parlar di lui, e dunque se ne alimenta la fama, anche se per
smentirlo vigorosamente. In un florilegio che va da “in un Paese come il nostro
la cultura può alimentare l’economia eccome…” a “la cultura ed il sapere sono
sempre più essenziali alla stessa produzione della ricchezza…”. Confutazioni
quanto mai appropriate. Solo che…Quando si smette di polemizzare (facile…) con
quelle tesi, se ne scordano le implicazioni. Se l’istruzione, il sapere, la
cultura hanno rilevanza economica, occorrerebbe abilitare il ragionamento
economico quando si parla di istruzione, cultura, sapere… A tentar di farlo si
corre invece il rischio di essere liquidati come “liberisti, aziendalisti”, e in
un vario crescendo, succubi degli interessi dell’impresa, del capitale
internazionale, della finanza, ecc..ecc… (tracce più che consistenti nel
dibattito sulla scuola anche in queste pagine, ma pare che la cosa valga anche
per le orchestre…).
Aristotele dice che il sapere è proprio di ogni uomo. Hoi antropoi…Tutti,
uomini, donne, greci, barbari, schiavi… (ehm: sulla effettiva estensione di tale
principio lo stesso filosofo nutriva qualche distinguo… e da quei distinguo
sarebbe bene far ripartire la riflessione critica piuttosto che la tranquilla
assertività.). Consentendo (in prima battuta) potremmo dire che così si afferma
il principio che il sapere è un “valore incondizionato” insito nella natura
umana, un “valore assoluto”. E’, per usare un termine economico, “valore d’uso”
dell’uomo in sé.
Nulla da eccepire, ovviamente, ma non sono consentiti cortocircuiti: tra tale
affermazione e la deduzione che “dunque” l’istruzione e la scuola (come
l’orchestra..) siano in sé valori incondizionati, ne corre. Esse sono semmai le
modalità (storiche, sociali, organizzate in sistemi) attraverso le quali si
esercita, individualmente e collettivamente, la realizzazione (tendenziale, come
tutte le realizzazioni storiche determinate) di quel valore assoluto
aristotelico.
In questo “passaggio” vi è
qualche cosa di più della banale avvertenza che le “strutture organizzate”
(sistemi, istituzioni) attraverso le quali si dà determinazione storica a quel
valore, sono soggette alla “critica delle armi” dello sviluppo e
dell’innovazione sociale, e che dunque le “armi della critica” devono essere
utilizzate sempre, sia in attacco che in difesa.
Il “di più” consiste nel fatto che rispetto al “valore incondizionato” del
sapere come seconda natura dell’uomo, il “costituirsi in sistema” e il
“costruire una organizzazione”, il costituire una “funzione sociale”
specializzata nella riproduzione del sapere (e per quanto riguarda la Storia
dell’Occidente, processo connesso alla costruzione degli Stati nazionali..),
rappresenta sempre (quanto meno) una lacerazione dialettica che “trasferisce un
valore in potere” (devo citare Foucault?).
Forte e inevitabile il rischio dunque che il richiamo al fondamento filosofico
(il valore incondizionato del sapere) finisca per assumere il ruolo che spesso è
assegnato alle affermazioni filosofiche: fornire “copertura” ideologica alla
realtà per scongiurarne la necessità di cambiamento e consolidare il potere
connesso ai “sistemi”..
Se affermo con forza il principio che l’istruzione, la scuola, rappresentano il
cuore fondamentale del percorso di ciascun soggetto verso l’adultità,
l’autonomia, la potestà deliberativa “il dare il nome alle cose”, devo sapere,
da docente, che il fatto che ciò avvenga entro un “sistema” organizzato
dialettizza permanentemente il processo e necessita di non confondere
l’autenticità e non riducibilità del processo stesso con i caratteri e le regole
del “contenitore organizzato”.
Più volte ho (più o meno garbatamente) polemizzato con chi giudiziosamente e
ottimamente si impegna nelle definizioni curricolari, nelle indicazioni,
ecc…indicando ilo rischio della deriva di “cosalizzazione” della relazione
pedagogica che entro tale impegno definitorio è in agguato.
Non voglio radicalizzare: sia sufficiente il mantenere aperto lo spazio, il
tempo e l’agibilità di tale dialettica. Il valore del sapere, dell’istruzione,
nella loro dimensione “incondizionata”, nel loro essere “valore d’uso”, non
coincidono con le ragioni del “sistema”, con le “tecniche” del curricolo, con il
dettato delle enciclopedie. Questi ultimi hanno senso solo come strumenti
rispetto al valore, che non può dunque identificarsi con essi. Il livello del
rispetto e dell’ospitalità che il “contenitore” istituzionale e organizzato
saprà dare al processo irriducibile dalla formazione del soggetto, sarà un buon
indicatore del carattere democratico e istituzionale del contenitore stesso. Ma
non può ne deve esserci identificazione.
Tuttavia la storia delle due
rivoluzioni industriali e della terza che è in atto, stanno ad indicarci la
progressiva integrazione di scienza e conoscenza (e non solo “tecnica”) nei
processi di trasformazione della natura e di produzione della ricchezza.
E’ dunque necessario misurarsi con un “altro valore” del sapere e della
conoscenza, che si proietta sul piano economico e dunque è valore
“condizionato”.
Il sapere, la conoscenza, la cultura hanno in altre parole anche un “valore di
scambio”.
(Per la verità lo hanno sempre avuto: la concezione della cultura come otium
contrapposta al negotium era infatti fondata sullo “scambio sociale
ineguale” che vedeva schiavi o semiliberi provvedere al buon vivere dei cultori
del sapere “incondizionato”.. Ma con la progressione delle due rivoluzioni
industriali la “critica della storia” ha rimesso il mondo sui piedi, o almeno in
parte ha reso evidente la dimensione ideologica connessa alla pretesa
universalità del sapere, detenuto da di quei pochi).
Gramsci (In Quaderni dal Carcere, “Gli intellettuali e l’organizzazione della
cultura”) ricordava che le classi popolari, osservando il successo scolastico
dei ricchi e la fatica e esclusione dei propri figli, finivano per considerare
la scuola e la cultura come “un trucco”. Altro che “valore assoluto”.
Uso il costrutto “valore d’uso” e “valore di scambio” per ragioni di
abbreviazione di argomentazione: il lettore avveduto saprà come recuperare i
riferimenti, anche se si tratta di un vecchio “cane morto” il cui pensiero e la
cui opera, però, sembrano rivivere una stagione di ripresa di attenzione, in
piena crisi economica.
I due “valori” rappresentano le polarità di una dialettica essenziale.
Perciò, se guardiamo al “valore di scambio” e tale assunzione di sguardo ci
rende criticamente avvertiti del non confonderlo con l’altro valore, non solo
si può, ma si deve parlare e discutere di “economia dell’istruzione”, superando
ogni timore di possibile subalternità culturale, di condizionamento e
riduzionismo.
Ma tale avvertenza critica deve operare anche sull’altro sguardo, all’altra
polarità dialettica, il “valore d’uso”, per consentirci di non cadere nel
tranello della “cosalizzazione” pedagogica che ci fa confondere la relazione
educativa che è il cuore del lavoro docente, con quello che ho chiamato il
“manuale operativo” del sistema (dalle cattedre, alle classi di concorso, agli
orari, agli organici: ciò è oggetto di economia, di valore di scambio e non
“valore incondizionato” del sapere. Non mortifichiamo quest’ultimo come orpello
ideologico che ci risparmia il bisturi della critica alla realtà, anche se il
“manuale operativo” contiene qualche “convenienza” e autodifesa).
L’approccio economico (economia dell’istruzione) è dunque fondato sul consistere del “valore di scambio” del sapere, della conoscenza e dell’istruzione, e l’avvertenza critica precedente deve consentirci di ovviare ai rischi che normalmente sono segnalati dagli –ismi con i quali si tenta di scongiurare tale analisi. L’economic-ismo, l’aziendal-ismo, il produttiv-ismo… Vacciniamoci, invece che segregarci nel lazzaretto.
Anche perché l’analisi
concreta della realtà rischia di mostrare palesemente il carattere di orpello
ideologico che assumono molte argomentazioni: la scuola pubblica preda di
affamati interessi privati che vogliono impossessarsene; Presidi (quelli
democratici) che a fatica sfuggono alle mire di imprese ansiose di investire
nella scuola e assumerne la gestione; modelli di gestione “aziendalista” (che
mai vorrà dire?) che stravolgono diritti, collegialità, libertà di insegnamento;
concorrenza spietata tra scuole che rincorrono finanziamenti differenziali;
concorrenza interna tra docenti sollecitata da gestioni discrezionali di premi e
merito... Ammesso che tali disegni stiano nella mente di qualcuno (e
provvederemo con fermezza a fagli intendere ragioni o a indicargli l’uscita) la
realtà è ben diversa.
E purtroppo non consente schieramenti “a difesa” che non siano difese parziali,
di gruppo e corporazione, di interessi che per piccoli che siano sono incrostati
e sedimentati… Il “sistema”, anche (ma non solo) attraverso tali sedimentazioni,
si sta avviando ad essere “indifendibile”. Ne basta, per questo, appiccicarci
l’etichetta di “ scuola Istituzione della Repubblica”. A quella etichetta deve
corrispondere la realtà. Non è “ontologia” è battaglia “politica e culturale” è
“obiettivo da raggiungere” e per raggiungerlo occorre “ trasformare”.
Per stare all’osso delle
cose, l’economia è il sapere della miglior corrispondenza tra mezzi e fini.
Quali obiettivi sono sensati con i mezzi a disposizione; quali mezzi sono
necessari e come utilizzarli al meglio rispetto agli obiettivi. Il termine
viene, non a caso, dal greco oikos (casa) e nemein (distribuire,
ripartire, suddividere, ordinare..). l’economia è il “sistemare casa al meglio”.
Per una impresa che abbia come obiettivo il “profitto” le cose sono
(apparentemente) più semplici.
Per una azienda che ha altri obiettivi che non il profitto (una azienda
ospedaliera, una impresa di servizi alla persona, una cooperativa, e perché mai
una scuola non dovrebbe essere considerata una “impresa”: una combinazione di
lavoro e risorse collettive per raggiungere un risultato comune?), le
definizioni e le pratiche economiche sono più complicate.
Ma anche nel primo caso qualunque docente di economia sa che certi “automatismi”
e riduzionismi sono in realtà caricature del pensiero economico (che sembra
latitare in grado direttamente proporzionale al numero di “tecnici” che ne
discettano).
Il “vantaggio” dell’avere il profitto come finalità consiste nel fatto che se, a
parità di ogni altra condizione (prodotto, condizioni di mercato, regole)
realizzo la massimizzazione del profitto ho la certezza di avere minimizzato i
costi e dunque ho usato al meglio la “scienza” economica. (Naturalmente la
condizione ceteris paribus è nodale: riguarda l’obiettivo di prodotto, ma
anche il rispetto delle regole. Massimizzare il profitto rubando o evadendo le
tasse o truccando il mercato, non ha a che fare con l’economia ma con il codice
e i giudici).
Ma scientificamente non vale il reciproco, anche se qualche pseudo economista lo
sostiene: se minimizzo i costi non è detto che ciò corrisponda alla
massimizzazione del profitto. Ciò vale per una impresa che opera per il
profitto, ma, per estensione, vale anche e soprattutto per ogni impresa che
abbia altre finalità e scopi.
Per una scuola, per un ospedale, per una azienda di servizio pubblico,
minimizzare i costi, a parità di altre condizioni (finalità, prodotti ecc..) è
un impegno fondamentale (dare conto dell’uso appropriato di risorse pubbliche)
ma non è automaticamente corrispondente alla massimizzazione degli obiettivi.
Teorizzarlo significa fare “cattiva economia” prima ancora che cattiva politica.
Ma ciò vale in ogni buona gestione aziendale: occorre misurarsi con la congruità
degli obiettivi, con le condizioni del mercato (la domanda: gli utenti, i
consumatori, i cittadini, i bisogni; e l’offerta: le alternative produttive, lo
stato dell’arte della tecnologia..ecc..) E poi costruire “sensate
corrispondenze” tra efficienza dei costi e tenuta degli obiettivi, in vista
della massimizzazione del rapporto tra valore del prodotto e costi.
Sto dicendo, scusandomi
della pedanteria, che ciò di cui abbiamo bisogno è più pensiero e migliore
scienza economica. Ci sono due iatture da scongiurare. La prima è che chi “sa di
scuola” si ritragga in scongiuri e censure di fronte ad un approccio economico,
in nome del “valore incondizionato” del sapere e della cultura, ergendosi a suo
custode e sentendosi minacciato da condizionamenti e riduzionismi. La seconda,
speculare, che ad occuparsi di ottimizzazione di costi, e del rapporto tra costi
e “prodotti” e “obiettivi” sia qualche (cattivo) economista che considera
automatico il rapporto tra minimizzazione dei costi ottimizzazione del profitto,
e che, soprattutto nulla sappia “dell’azienda scuola”.
Il risultato, purtroppo devastante, è quello misurato in questi anni (almeno
quindici) nei quali sempre più chiara fu l’esigenza di misurarsi con
l’ottimizzazione dei costi; ma non avendo “scienza economica” sufficiente in chi
poteva sensatamente assumerne tale responsabilità (penso a una intera
generazione di dirigenti pubblici dell’amministrazione scolastica), la mano
passò a “economisti” che espressero ciò che sapevan fare attraverso i tagli
lineari (altro che corrispondenza tra mezzi e fini e scienza economica..). Cosa
c’è di più semplice che effettuare tagli lineari? Che competenza amministrativa
richiede mai l’applicazione di una percentuale? Quale responsabilità
dirigenziale?
E oggi non è dissimile la situazione con la spending review. Nulla può
sostituire la “scienza e coscienza” di un dirigente o di un lavoratore che
“dentro” i processi produttivi della sua “impresa” (una scuola, un ospedale, un
servizio pubblico) ne conosce la composizione dei costi e sa dove si può agire
in termini di minimizzazione di essi e massimizzazione del risultato.
Se questo impegno (culturale, civile, professionale, sindacale..) e, per quanto
attiene ai dirigenti pubblici, essenziale al loro ruolo, viene meno, se si
preferisce lamentare, in forma di scongiuro, che l’economia sia sempre incapace
di comprendere il “ben altro” che motiva il produrre pubblico, il risultato sarà
quello che abbiamo di fronte.
Da un lato il radicalizzarsi degli interessi affluenti di chi lucra da posizioni
di comando (confrontare il rapporto dirigenti/addetti tra il settore pubblico e
quello privato, con la sprioporzione del primo; e confrontare il monte
stipendiale dirigenti tra pubblico e privato: ci si renderà conto di quanto
accaduto negli ultimi vent’anni. Le punte scandalose del privato non possono
occultare il fatto che le cifre complessive mostrano la netta crescita del
pubblico. Si comprenderà il motivo, non solo etico, per cui è stata necessaria
una legge per limitare il massimo delle retribuzioni dirigenziali pubbliche).
Dall’altro la resistenza di un insieme stratificato di piccole convenienze,
alleate alle prime e ad esse agganciate, che temono ogni innovazione e “non si
fidano” delle promesse. Un insieme di piccole dislocazioni che resistono
all’istanza riformatrice più di quanto faccia una grande faglia oppositiva,
perché in realtà sono organiche a chi le riforme, immaginate dai politici, le
dovrebbe materialmente mettere in opera (l’amministrazione) e ricomporrà invece
il tradizionale compromesso conservativo tra politica e amministrazione che
segna la storia nazionale.
E l’ideologia anti economica, anti aziendale, anti produttivistica copre il
tutto di una coltre “benaltrista” che invoca valori incondizionati e assoluti,
non riducibili a prosaica economia.
Ma la dialettica valore
d’uso/valore di scambio che articola il rapporto tra valore incondizionato della
cultura, dell’istruzione, del il sapere e il loro valore economico e
condizionato, non investe solamente la dimensione del sistema e della
organizzazione complessiva, bensì la dinamica ravvicinata della relazione
educativa.
Le “competenze” rappresentano esattamente, sul piano dei processi personali,
individuali di formazione ed istruzione, il “valore di scambio” di ciò che in
termini di valore d’uso abbiamo ascritto al percorso di adultità, di
acquisizione di sapere critico, di capacità di deliberazione, di autonomia del
soggetto irriducibile a standard, e dunque del valore del sapere e
dell’istruzione di carattere assoluto, incondizionato, dis-economico.
La problematica delle competenze (se ne veda l’origine nei documenti dell’Unione
europea) è esattamente il frutto della opzione economica nell’approccio alla
“società della conoscenza”.
Lo sostengo da tempo in una sottile e meno sottile polemica con chi presenta la
problematica delle competenze (valutazione, certificazione, didattica per..)
come un nuovo e rivoluzionario orizzonte della pratica scolastica. Non voglio
citarmi: con opportune ricerche si trovano in rete sia le mie polemiche con
l’amico Tiriticco, sia i contributi a “Scuola Democratica”, oltre che articoli
vari che leggono le competenze in questa chiave.
So che per qualcuno ciò può suonare come conferma del sospetto di una opzione
egemonica della cultura economica, produttivistica, manageriale, aziendalistica,
sulla scuola. Rimando per ogni confutazione a quanto espresso in precedenza.
Aggiungo solamente che, nella chiarezza della ispirazione economica della stessa
categorizzazione di “competenze”, si ritrova la necessità richiamata di una
approfondimento della cultura economica applicata all’istruzione, piuttosto che
un confinamento di quella problematica in un isolamento motivato dai pericoli di
“inquinamento” culturale.
Certo le “competenze” sono ciò che viene scambiato sul mercato del lavoro. Sono
il “valore di scambio” dei livelli culturali e di istruzione raggiunti dal
soggetto. In un colloquio di lavoro su questo verrà “interrogato” il soggetto e
di questo darà conto. Parzialità e condizionamento dell’impresa? Sia pure. Ma la
scuola che fa? Se ne ritrae inorridita a salvaguardare il valore incondizionato
della cultura o dà al soggetto strumenti per esercitare padronanza e autonomia
anche in quel contesto?
Ma c’è di più e di coerente con l’affermazione precedente della necessità di
misurarsi con cultura e valori “altri” ( o altrimenti supposti) come quelli
economici.
Invito a consultare qualche pubblicazione che si occupa di valutazione delle
competenze in contesto aziendale, di esperienze e metodologie di assesment
center. Si scoprirà che in tali esperienze assume sempre grande rilevanza
l’uso di strumentazioni di carattere psicodiagnostico, apparentemente assai
lontane non solo dalla cultura economica, ma anche da quella mediamente
disponibile ed esercitata in contesto scolastico, che pure vorrebbe avere il
soggetto come proprio “centro”..
E, a ben guardare, non può che essere così. Se la competenza (un tratto
individuale e personale) descrive l’implementazione sul substrato psico
antropologico del soggetto dell’integrazione tra conoscenze (acquisite con la
formazione e l’istruzione), l’esercizio e l’esperienza che coltivano l’abilità
(ah… la scuola dell’esperienza… Ma Dewey nella scuola italiana dove è?) le
capacità e le attitudini (che per le età scolari sono un “dato” che il soggetto
ha acquisito spesso altrove e di cui si tratta semmai di “scoprire” e
valorizzare l’esistenza), allora l’uso di una strumentazione di tipo
psicodiagnostico per scoprire valutare, promuovere la competenza è inevitabile…
Vedo invece grande attenzione definitoria e nella costruzione di schede
sperimentali, più o meno sensate (per esempio declinate per discipline!!). E
spesso di grande valore cosmetico (basta cambiare le etichette alle colonne e
righe delle schede di valutazione…).
Ho grande vicinanza e comprensione verso ogni tentativo di trovare le mediazioni
operative possibili entro una pratica di lavoro che deve “arrangiarsi” tra
vincoli di risorse, sfide culturali e psicologiche sempre rinnovate,
inquietudine intrinseca alla sfida della relazione educativa e … tutto il resto
del vivere quotidiano.
Ma proprio in nome di tale comprensione, considero inaccettabile coprire il
tutto con la maschera ideologica del “valore assoluto” della cultura e
dell’istruzione.
Solo per questo ricordo che una categorizzazione economica (le competenze) sfida
proprio la cultura psicologica, diagnostica, di attenzione al soggetto e al suo
sviluppo, che avviene anche fuori dal rapporto scolastico (la cultura e
l’istruzione non sono un monopolio). Esattamente quella cultura e sensibilità di
cui si rivendica il primato da parte chi teme la deriva economica.
Non c’è da esorcizzare
l’approccio economico. C’è da approfondirlo.
E più in generale: non si fa opposizione matura, consapevole, responsabile di
costruire alternative, agendo paradigmi come quello “vittimario” o quello delle
“congiure” e del “disegno occulto”. Non che tutto ciò non esista nella storia.
Ma pensare che quest’ultima sia determinata da quei paradigmi è il modo per
esentarsi dalla fatica e dall’impegno di smentirli, ridimensionarli, e
dall’impegno di riportare l’accento sul protagonismo delle istanze collettive e
della deliberazione consapevole. La cittadinanza è poi questo, non una etichetta
appiccicata ad una procedura.