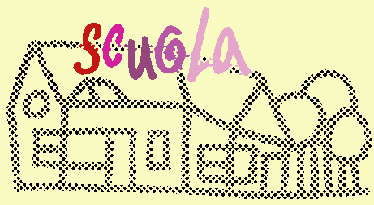 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
(11.10.2009)
Storie
di teorie e di pratiche di insegnamento della storia
Prima parte: fino alla fine dell’Ottocento
Oggi in Italia la didattica della storia è un settore di
ricerca autonomo.
Esistono, cioè, nelle università, cattedre di didattica della storia, ed
esistono ricercatori che se ne occupano a tempo pieno.
Questo era impensabile almeno fino a non molto tempo fa, in cui era già tanto
che esistessero cattedre di pedagogia o didattica generale separatamente dalle
varie cattedre di filosofia.
Volendo andare all’indietro su chi per primo, in Italia o nel mondo, si sia
occupato di problematiche riguardanti l’insegnamento della storia, che tipo di
storia insegnare, in che modo insegnarla, perché insegnarla, e così via,
possiamo risalire alle prime testimonianze scritte. Testimonianze molto note si
possono già trovare, ad esempio, in età antica, all’Ippia Maggiore di
Platone, in cui Socrate dialoga con un sofista che, di fatto, è anche un
insegnante di storia del suo tempo, oppure alle opere di Aristotele, sia in
passi espliciti, come nella Poetica, che in altri che si possono leggere
tra le righe, come quelli di carattere politico o etico. Chiaramente, sia
Platone che Aristotele, quando parlano di storia, di poesia, di politica, di
filosofia, hanno in mente qualcosa di diverso da quello che oggi diamo a quei
termini.
In età moderna, la storia ancora nel Seicento non era
prevista come materia d’insegnamento.
Infatti sappiamo che la storia ha incominciato ad essere una materia
d’insegnamento, sia universitario che scolastico, autonoma dalle altre solo
negli ultimi due o tre secoli al massimo, dato che prima era sempre stata
inclusa nella letteratura, nella politica o nella teologia.
I manuali, come è noto, sono invenzioni legate alla nascita della stampa e
dell’istituzione scolastica, per cui in Francia risalgono grossomodo al XVII
secolo.
Rollin, all’inizio del XVIII secolo, scrive che “sarebbe auspicabile […] che vi
fosse un’opera espressamente composta per i giovani”. Evidentemente, prima non
ce n’erano, o non erano note all’autore. E continua dicendo: “Quest’opera non
dovrebbe essere né un semplice compendio, costellato quasi esclusivamente di
date e di nomi –ciò che non può essere di molta utilità se non a coloro che
sanno già la storia – né troppo lunga, perché dei giovani occupati anche nello
studio di molte altre materie non possono dedicare un tempo eccessivo a quello
della storia”. Più tardi La Chalotais chiedeva “che non vi si lasciasse nulla da
aggiungere ai maestri”.
Voltaire a partire almeno dal 1742 e fino almeno al 1763 si occupa di teoria della storia, in qualche modo teorizzandola in un modo che molti storici ancora oggi continuano a riconoscere come loro. Rousseau in quegli anni, e precisamente nel 1762, pubblica un libro, l’Emilio, in cui scrive che, se dipendesse da lui, la storia non si dovrebbe insegnare ai bambini perché loro non ne sono capaci. In quello stesso anno pubblica anche il Contratto Sociale. Entrambi sono subito condannati, a Parigi e a Ginevra. Rousseau, nato nel 1712, al momento di dare alle stampe quel libro aveva cinquant’anni e morirà sedici anni dopo, nel 1778, all’età di sessantasei. Nell’Emilio troviamo, quindi, il suo pensiero dell’età matura.
L’Ottocento
Tolstoj: rinunciare a insegnare la storia ai bambini.
È nel 1849 che Tolstoj (1828-1910) apre la sua scuola per i
figli dei contadini, alla quale si dedicherà di nuovo nel biennio 1859-60
scrivendo anche il suo primo saggio di pedagogia, Osservazioni e materiali
pedagogici.
Per quanto riguarda la didattica della storia, scriveva che i racconti sui
faraoni dell’antico Egitto o sui principi della Russia medievale non interessava
i bambini. Quello che li interessava, secondo lui, era la storia di Napoleone,
respinto dal popolo russo.
È da ricordare che Tolstoj non è stato solo un romanziere di successo, ma anche
un teorico della storia, come si ricava dalla lettura dei suoi romanzi, in modo
particolare nel lungo Epilogo di Guerra e pace (1868).
A Tolstoj la storia di Napoleone piace, soprattutto perché vi vede un esempio
della sua interpretazione della storia e della psicologia, secondo la quale chi,
come Napoleone, confida solo nella ragione è prigioniero della necessità,
ovvero, tanto nella storia quanto nella psicologia (e, aggiungiamo noi, nella
pedagogia e nella didattica), non possono esserci né determinismo assoluto né
libertà assoluta.
Ai suoi bambini la storia di Napoleone probabilmente piace (sarà piaciuta
davvero?) semplicemente perché è la storia di un conflitto, e i conflitti in
quanto tali possono attirare curiosità e interesse, e per il modo appassionato
con cui Tolstoj la narra loro, cioè per le sue doti di narratore, e in questo
senso storia, fiaba e favola sono una cosa sola.
Tolstoj pedagogista e didatta ritiene che la conoscenza deve nascere dalla
soluzione dei problemi proposti dall’esperienza, che l’anarchia scolastica è
utile e insostituibile e che il metodo migliore è l’assenza di metodo.
La didattica della storia, e della geografia, è per Tolstoj un problema così
grande che rinucia a risolverlo. Si arrende di fronte alle difficoltà che
presentano, dicendo che secondo lui i bambini non possono capire la storia né la
geografia, non sono adatte a loro, non possono interessarsi di queste cose, che
sono del tutto inutili e insignificanti per loro.
Queste considerazioni di Tolstoj sono interessanti sia perché dette da lui,
grande intellettuale che si abbassa per sua iniziativa e volontà a fare il
maestro elementare per due anni; ma anche perché negli anni tra il 1857 e il
1859, viaggiando in Francia, Svizzera, Germania, Italia, osserva cosa si fa in
quei paesi nelle scuole elementari e cosa si insegna nelle università a
proposito di pedagogia e didattica, per cui sono considerazioni che vanno al di
là delle particolarità locali in cui lui insegna.
Lui stesso si sente superiore a tutti i maestri e i pedagogisti europei che ha
conosciuto direttamente o di cui ha letto, convincendosi che, quando non fanno
danno, le scuole “valgono zero”.
Quale storia nell’Ottocento. L’illusione della
razionalità e la verità dei miti
Nella seconda metà del XIX secolo, sia in Francia che in
Italia, i bambini usavano per i loro apprendimenti un libro dove trovavano
informazioni sulla storia nazionale del loro paese di appartenenza.
Ancora nel primo trentennio del Nocevento il manuale è l’unico strumento di
lavoro sia per il maestro che per l’alunno, e la storia, come pure la geografia,
sono solo ciò che gli scolari ripetono a memoria per averlo letto su quel
manuale o detto dall’insegnante, il quale a sua volta lo trova scritto in un
manuale. In questo periodo, le funzioni del manuale scolastico di storia sono le
stesse di quelle dell’insegnamento storico in generale: sono quella morale,
quella patriottica, quella politica e, raramente, quella di studio scientifico
della storia, con riferimento a un ideale di scientificità e di verità che
consisterebbe nel liberarsi dalla mitologia o dalla leggenda.
A questo proposito posso osservare che questa presunzione di superiorità
rispetto al mito è stata, fin dalla filosofia greca antica, una posizione
ingenua. Al contrario di quello che Nestle continuava a ripetere nel 1942 (Dal
mito al logos), cioè che ci sarebbe un’evoluzione dal mito alla razionalità,
un progresso; noi sappiamo che, da sempre, il mito non è finzione né favola, ma
storia vera.
L’invito a non sottovalutare il mito, nelle sue varie forme, è stato ripetuto
recentemente, in modi diversi, da autori come R. Otto, G. Van der Deeuw, M.
Eliade, K. Kerényi, Dumézil. Io qui sto parlando di mito in senso molto
generale, come tipo di narrazione metaforica. In un senso largo, anche il libro
della Genesi può essere considerato un mito (anche se è una dottrina
sacerdotale).
Il mito, inteso come metafora, è un genere letterario particolare, non una
documentazione storica; è una narrazione che dice il vero. Allora non bisogna
dire: il mito non è che un mito, cioè meno di una storia, ma: il mito ha più
senso di una storia vera. È un modo di parlare della realtà di sempre attraverso
dei miti che, dal di fuori della storia, ne mostrano l’interno.
Si tratta di una interpretazione della totalità della storia, di narrazioni che
vorrebbero indicare per via metaforica perché il mondo è così come è, con
l’intento di far riflettere sull’essenziale dell’esistente e sul senso della sua
condizione. Ma, in genere, considerazioni come queste non vengono fatte nella
manualistica scolastica di metà Ottocento, che di solito piuttosto preferisce
ridicolizzare ogni forma di narrazione mitologica e sostituirla con una
idealizzata forma scientifica di spiegazione della realtà, oppure la lascia ai
bambini come favoletta più o meno moralmente edificante. In ogni caso, in questo
periodo l’insegnamento della storia è l’esposizione del manuale di storia e
l’apprendimento di storia è la memorizzazione del manuale di storia. In Francia,
alcuni studi sui manuali di storia dalla seconda metà dell’Ottocento a tutti gli
anni Cinquanta del Novecento, che quindi finivano con l’essere di fatto studi
sulla didattica della storia in quanto tale di quel periodo, sono già stati
fatti a partire dalla fine degli anni Sessanta.
Darwin, ovvero tornare alle illusioni di Protagora e Democrito
Nel 1859 esce L’origine delle specie di Darwin
(1809-1882), a cui nel 1971 seguirà L’origine dell’uomo, che
influenzeranno una certa manualistica scolastica fino ad oggi, la quale spesso
fa un’enorme confusione tra le teorie scientifiche (biologiche, geologiche,
ecc.) con quelle storiografiche e le mette insieme come se fossero un tutt’uno,
senza distinzioni di ambiti, metodi, contenuti.
Ancora oggi c’è chi continua a non vedere nella storia nient’altro che uno
sviluppo biologico evoluzionistico, come Richard Dawkins con Il gene egoista
del 1977.
L’atteggiamento mentale di fondo è lo stesso di molti antichi, di cui abbiamo
testimonianze scritte almeno a partire da Protagora e Democrito, che si
illudevano di poter spiegare ogni cosa in termini di progresso naturalistico e
tecnico, confidando in un sapere tecnico della natura sufficiente a spiegare
tutto.
Proudhon: didattica della guerra?
Nel 1861 Proudhon (1809-1865) pubblica La guerra e la
pace, in cui, tra l’altro, sostiene l’inevitabilità della guerra dato
l’equilibrio instabile, precario della società, andando oltre alla visione
romantica della Francia di metà Ottocento in cui la forza e la violenza
vorrebbero essere orientate alla pace e alla civiltà.
Questo tipo di interpretazione della storia potrebbe avere trasposizioni
didattiche di un certo tipo, per esempio tali per cui insegnare la storia non
può essere che insegnare le guerre, cioè non è possibile rinunciare a questo
elemento conflittuale essenziale per la storia in nome di ipotetici quadri
statici di civiltà pacifica.
La scuola dell’obbligo
In Europa, nella seconda metà dell’Ottocento, la questione
dell’obbligo scolastico si sviluppa, di pari passo con l’affermazione
dell’istruzione pubblica.
L’obbligo formale nasce probabilmente in Austria, e successivamente in Gran
Bretagna tra il 1870 e il 1880, in Francia nel 1881-1882, in Olanda, Svizzera,
in molti paesi coloniali e non dell’area anglosassone, nella Scozia, in Canada,
in quattrordici stati degli USA, in molte parti dell’Australia e in Nuova
Zelanda, tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, in Giappone, che aveva un
ordinamento scolastico di ispirazione europea, nel 1875. Ma già la parola
“obbligo”, che in quel contesto avrebbe voluto dire qualcosa di buono, deve
richiamare l’attenzione. Si è “obbligati”, “costretti” a studiare.
È un’imposizione di forza, violenta, autoritaria. Non dico che sia sbagliato far
andare i bambini in una scuola. Dico solo che questa parola “obbligo”, che si
continua a usare ancora oggi quando parliamo di scuola “dell’obbligo”, di
materie “obbligatorie” o di presenze “obbligatorie”, non mi sembra la più
felice.
È una scuola del dolore.
Già Eschilo nell’Agamennone (176-183) scrive di un apprendimento che
viene dal dolore patito, dal soffrire; ma chi nella seconda metà dell’Ottocento
ha deciso che ci doveva essere una scuola dell’obbligo probabilmente aveva in
mente qualcosa di più banale. Quello che non si capisce è come si possa
“obbligare” un pensiero creativo e libero. Il concetto di obbligo può convivere
con quello di libertà?
1861: Sulla carta esiste l’Italia, quindi
inventiamoci gli italiani
Nel 1861 si costituisce il primo Regno d’Italia. Fino a
quel momento era divisa, com’è noto, nel regno delle due Sicilie, nel regno di
Sardegna, nello stato della Chiesa, nel granducato di Toscana, in quelli di
Lucca, di Massa, di Modena, di Parma, nel regno Lombardo Veneto (e c’erano la
contea di Nizza e il territorio dei Savoia, alla Francia nel 1860); ora, a parte
lo stato Pontificio e l’impero d’Austria che occupava territori corrispondenti
al Veneto, l’Italia era per la prima volta politicamente unita.
È del 1859 la legge Casati del Regno di Sardegna, che nel 1861 viene estesa a
tutta l’Italia, ad essere quella istitutiva della scuola italiana, apparendo
all’epoca all’avanguardia in Europa. Emanata dal governo piemontese, in regime
di pieni poteri concessi dal parlamento, in occasione della seconda guerra
d’indipendenza, di fatto è la legge che costituisce l’intelaiatura del sistema
scolastico italiano fino alla riforma Gentile del 1923. La scuola ora è
obbligatoria e gratuita per bambini di età fra i sei e i nove anni. In quel
contesto la didattica della storia è però ridotta a storia nazionale all’interno
delle attività di lettura, se e quando possibile.
Infatti ancora nel Regno d’Italia ancora non esisteva una lingua comune parlata:
andava inventata e insegnata. Quello era l’obiettivo principale: creare gli
italiani.
Creare buoni sudditi, italiani.
Anche gli insegnanti dovevano imparare questa nuova lingua, in quanto pochi di
loro sapevano parlarlo correttamente. Nell’Italia dialettofona del 1861
l’analfabetismo dichiarato, che aveva profonde radici economiche e sociali, è
del 78%, ma stime più attendibili fanno pensare al 2,5% di alfabeti o, al
massimo, al 9%.
Di quegli anni è stato detto che il mestiere di maestro elementare è
generalmente rifugio di chi non riesce in modo migliore a guadagnarsi il
necessario per vivere, o di sacerdoti che trovano nell’insegnamento un modo per
arrotondare il reddito.
Sono gli stessi anni in cui Nietzsche scrive che l’educazione dipende dalla
grandezza morale o dal carattere degli insegnanti e non deve far intravedere
come fine o compimento un impiego o un guadagno materiale, anzi che dovrebbe
sollevare gli studenti dall’insoddisfazione figlia dell’epoca della fretta e del
guadagno!
L’obbligo scolastico c’era. L’obbligo. Ma veniva spesso e volentieri
evaso.
I programmi scolastici ministeriali Gabelli del 1888 prevedono una didattica
della storia in terza e quarta elementare: in terza i bambini dovevano sentir
parlare l’insegnante di alcuni fatti dell’unificazione d’Italia, e memorizzarli.
In quarta e quinta fare la stessa cosa, meglio. In prima e in seconda, a
discrezione dell’insegnante, si poteva far cenno a qualche aneddoto sulla storia
degli ebrei, dei greci e dei romani.
Era prevista anche la possibilità, per i maestri, di far riferimento a qualunque
fatto che potesse inculcare nei bambini il senso patriottico, sempre con la
finalità di costruire la coscienza nazionale, come elemento necessario alla
coesione sociale attorno all’egemonia esistente.
Nel 1852 esce il Catechismo positivistico di Comte. A livello di
riferimento teorico, tutta la didattica dal 1859 almeno fino al periodo
giolittiano, cioè alla legge Daneo-Credaro del 1911, nella quale permane una
didattica della storia intesa come finalizzata a formare il senso nazionale e
patriottico (“il secolo si chiude con l’assassinio di Re Umberto: tristissima
fine di secolo, segnata dal più vile e mostruoso dei delitti. L’ultima pagina di
quella storia, macchiata del sangue innocente del più buono, del più leale dei
Re, sia letta con orrorre e raccoglimento, e ricordi a tutti il dovere di
fedeltà e di onore”), si ispirava al positivismo.
Labriola: la storia degli adulti non è la stessa dei
bambini
Nel 1876, esce il libro Dell’insegnamento della storia
del trentatreenne Antonio Labriola (Cassino 1943-Roma 1904), che dal 1974 è
professore di filosofia morale e di pedagogia all’università di Roma, dopo aver
pubblicato uno studio su Spinoza, uno su Socrate e due sulla morale (Origine
e natura delle passioni secondo l’Etica di Spinoza, 1866, La dottrina di
Socrate secondo Senofonte Platone e Aristotele, 1871; Della libertà
morale, Morale e religione, 1873).
In quel libro sulla didattica della storia Labriola sostiene che la storia che
si fa nelle scuole deve essere diversa da quella che si fa nelle università.
Cioè i manuali di storia usati nelle scuole non devono essere dei riassunti dei
manuali di storia usati dagli studenti universitari, ma soprattutto la storia,
come tutte le altre discipline, sono soltanto mezzi dell’educazione, non fini a
se stesse ma in vista dell’aspetto della formazione del cittadino e del
lavoratore.
La Bertoni Jovine, nel commentare questo libro, ha scritto che per Labriola la
storia non è la stessa che si faceva prima, cioè la storia “delle classi
dirigenti, dei grandi personaggi, delle guerre, delle paci e delle dinastie che
hanno impresso il loro segno ai tempi, com’era stato insegnato fino a quel
momento: ma la storia della fatica di tutti, del lavoro, delle cause e degli
effetti considerati nel concreto svolgimento della civiltà al quale tutti gli
uomini portano, sia pure anonimamente, il loro contributo”. Ma quella è una
interpretazione che fa dire a Labriola quello che lui stesso non abbia detto,
che è semplicemente contenuto in queste parole: “La storia che importa
d’insegnare pei fini dell’educazione non consiste nella disposizione metodica
dei fatti e delle date, né è da considerare quale ordinamento sistematico delle
cause generatrici degli avvenimenti umani”.
L’illusione della neutralità
A Londra nel 1890 viene posto il problema dei manuali
scolastici di storia, inteso come ricerca di neutralità didattica, come sforzo
di superamento di elementi faziosi o pregiudiziali che potessero in qualche modo
ostacolare i buoni rapporti tra le nazioni.
Questo accade durante un congresso dell’Unione internazionale delle società
della pace, nell’ambito quindi di quel movimento pacifista sorto negli Stati
Uniti all’inizio dell’Ottocento diffondendosi poi in Europa negli anni centrali
del secolo, ispirandosi sia a un certo umanitarismo anglosassone, sia ad un
ideale di cosmopolitismo, come pure a un certo internazionalismo di origine in
qualche modo illuministica.