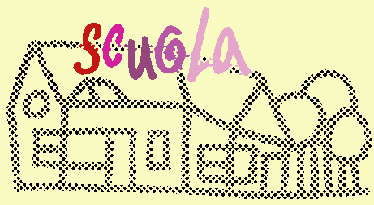 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
(24.09.2009)
Straniero a scuola
Dov’è la povertà e perché nessuno la vuole
Da qualche anno mi trovo incaricato in una scuola serale a insegnare lingua e cultura italiana ad adulti stranieri immigrati in Italia. Ogni anno in questa scuola dividiamo le lezioni in tre trimestri, che corrispondono grossomodo a questi periodi: da ottobre a dicembre, da gennaio a marzo, da aprile a giugno. In ciascun trimestre mi trovo a tenere tre o quattro classi di circa venticinque studenti ciascuna, provenienti dalle località geografiche più disparate e con una storia personale estremamente diversa l’uno dall’altro. Ogni nuovo trimestre alcune persone continuano con me o con altri insegnanti, mentre altre, per vari motivi, non continuano e cedono il posto ad altre.
Si ritrovano fianco a fianco il ragazzetto di diciassette anni con la persona anziana di sessantacinque, l’ingegnere in carriera con la domestica, il ricercatore universitario con l’operaio generico, l’ex avvocato in pensione con la giovanissima studentessa delle scuole superiori o dell’università, il rifugiato politico con l’ex detenuto. In questi ultimi quattro anni, quante persone ho conosciuto, e quante storie di vita!
Come loro insegnante, mi chiedo perché vengono da me. Qualcuno si accontenta di rispondere: “per imparare la lingua italiana”, e completa questa risposta dicendo: “e vuole imparare la lingua italiana perché gli serve per lavorare, per trovare un lavoro o, se già ce l’ha, per lavorare meglio”. Risposte facili, veloci, sbrigative. Non tutti vengono per lo stesso motivo. Ogni persona viene con una storia diversa da ogni altra e, per quanto alcuni possano avere una storia con delle somiglianze, nessuna storia è uguale a un’altra. Per rispondere alla domanda del perché vengano da me, mi chiedo perché vengano in Italia, perché se ne siano andati via dai loro rispettivi luoghi di partenza. Qualcuno dice che vengono per scappare dalla povertà o dalla miseria.
A me viene il dubbio che qualcuno si porti dietro una povertà e una miseria che non è solo relativa ai beni materiali, ma è prima di tutto una povertà e una miseria interiore, una povertà e una miseria dell’io, del cuore, di se stesso. E non c’è ricchezza materiale che possa dissetare questa sete. Qualcun altro sembra portarsi dietro una ricchezza interiore, ad esempio una voglia di fare tutto il possibile per realizzarsi come persona o per aiutare altre persone a valorizzare la propria umanità, a viverla meglio.
So che tanti vengono per mettere da parte dei soldi con i quali permettere ai propri figli di studiare nelle scuole e nelle università nei loro paesi, oppure con i quali consentire a qualche familiare di pagare dei debiti, oppure per costruire, sempre a qualcuno della propria famiglia, una casa o semplicemente per permettergli di pagarsi l’affitto o il mutuo, oppure ancora per pagare le spese mediche a questo o a quello, al genitore o al figlio, al fratello o al nipote, allo zio o al cugino. A quanto mi raccontano, la maggior parte viene con questa idea in testa, con questa generosità nel cuore. Sacrificarsi per altri. Cercare di sbrigare il tutto nel tempo più breve possibile, stringere i denti e restare qua uno, due, tre anni, anche cinque o dieci se proprio è necessario, e poi fare di nuovo le valigie per tornare indietro, contenti di aver fatto del bene a qualcuno.
In altri casi, qualcuno si sacrifica (perché di sacrificio si tratta, rinuncia, sofferenza, difficoltà, a volte dolore e nostalgia di quello che si è lasciato) non tanto per altri, quanto piuttosto per se stesso: cercare, nel più breve tempo possibile, di mettersi da parte quei soldi che gli dovrebbero permettere di costruirsi una casa, di capitalizzare per il proprio futuro. In ogni caso, prendere per portar via, venire per tornarsene via.
Altri ancora vengono per restare. Sono quelli che, di solito, fanno di tutto per chiedere la cittadinanza italiana e per adattarsi a questo mondo che pure sono consapevoli di non essere il loro mondo, ma un mondo altro dal proprio. Sì, perché non siamo soltanto noi ad accogliere loro, ma anche, e forse soprattutto, loro ad accogliere noi, nella propria vita. Come lo accolgono? Cosa significa, per questa persona o per quest’altra, accoglierlo? Qual è il prezzo, il costo di questo scambio del proprio con l’altro? Sì, perché non sempre si verifica una integrazione, non sempre l’integrazione è desiderata, anzi spesso è una finzione, una maschera, uno stare al gioco.
Questi, che vengono per restare, magari sono quelli che non stavano bene dove stavano e per cui qualunque cosa, per quanto triste, per quanto difficile o brutta, è meglio di prima. Ad esempio alcuni rifugiati politici, persone che scappano alla guerra, alla miseria, alla morte. Oppure sono persone che hanno litigato in famiglia, oppure che per qualunque ragione hanno dei vissuti negativi nei loro luoghi di origine, ricordi che vogliono dimenticare, lasciarsi alle spalle. Oppure quelli che non si accontentano del poco che hanno e che vogliono avere di più o meglio.
In quest’ultimo caso, il discorso è centrato sull’“avere”, non sull’“essere”, oppure sull’identificazione del proprio “essere” con il proprio “avere”: “io sono quello che ho”. È questa la situazione esistenziale, tristissima e tragica, che ci si trascina dietro fino alla morte. Sì, perché prima di tutto la rincorsa all’ “avere di più o meglio” è una corsa senza fine e senza fondo verso la propria stessa fine e verso il proprio stesso fondo che sprofonda sempre più, una corsa allo sprofondamento, una gola spalancata che urla o che tace e non è mai possibile soddisfare. In secondo luogo perché, finché “io sono quello che ho” e “vivo per quello che ho”, non sarò mai felice da nessuna parte, mai felice di niente e con niente. Non sono le cose, i luoghi, le persone, le situazioni a darmi la felicità. La fame di cose, la sete di beni, la tristezza per la mancanza del di più o migliore o la rabbia per qualunque, reale o immaginaria, privazioni materiale, sono un veleno interiore che io stesso produco e che mi porterò dietro dovunque vada.
Mi rendo conto che ho semplificato parecchio la complessa realtà dell’emigrazione. E lascio aperta la questione tenendo ferme alcune domande. Tu perché te ne sei andato? Perché sei venuto? Perché vuoi tornare da dove sei venuto? Oppure perché vuoi rimanere qui? Cosa cerchi? Sei felice? Dove cerchi la tua felicità, in chi o in cosa?
Ripenso alla storia del leone e della lepre che ci racconta Esopo.
Un leone trovò una lepre addormentata e stava già per divorarsela, quando vide passar di là un cervo, e lasciò la lepre per corrergli dietro. La lepre, svegliata da quel tramestio, balzò su e se la diede a gambe. Dopo una lunga corsa dietro il cervo, non essendo riuscito a raggiungerlo, il leone ritornò alla sua lepre, ma trovò che se l’era svignata. “Be’! Me lo son meritato”, disse, “perché ho lasciato andare il boccone che avevo già in mano, preferendo correr dietro alla speranza di un boccone più grosso. (Riporto da Esopo, Favole, tr. it. di E. Ceva Valla, Rizzoli, collana bur classici greci e latini, Milano 2001 (15), pp. 229-230).
Esopo era vissuto nel vi sec. a.C., e questa sua storia, che ha avuto successo nel v e nel iv sec. a.C, fa da specchio a una delle modalità in cui si espressa la cultura degli antichi greci, in particolare di quella stessa cultura che ha condotto all’autodistruzione degli antichi greci nel corso della guerra del Peloponneso narrata da Tucidide. A volerci guardare dentro, si può trovare una rappresentazione di molte e molte cose, tra cui il vivere mangiandosi a vicenda, gareggiando a chi è più furbo, facendo della legge del più forte e del più intelligente la propria tomba. Poi c’è stato qualcuno che ha capovolto questo pensiero dicendo: “beati i poveri in spirito”. Ma oggi, come sempre, qui come dappertutto, non sembra molto ascoltato. A guardarsi intorno e ad ascoltare i giornalisti, sembra piuttosto estremamente attuale la storia del Piccolo principe:
“L’essenziale è invisibile agli occhi”. […] “Hanno tutti fretta […]. Che cosa cercano?”. […] “Gli uomini […] non sanno più che cosa cercano. Allora si agitano, e girano intorno a se stessi…” […]. “Hai del buon veleno? Sei sicuro di non farmi soffrire troppo tempo?” […] “Sono contento che tu abbia trovato quello che mancava al tuo motore. Puoi ritornare a casa tua…” […]. “Anch’io, oggi, ritorno a casa…” […]. “È molto più lontano… è molto più difficile…” […]. “Quello che è importante, non lo si vede…”. (Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince, Paris, Gallimard 1943; Il piccolo principe, tr. it. di N. Bompiani Bregoli, Bompiani, Milano 2005, passi tolti da p. 98 a p. 115).
Questa mi sembra un’occasione anche per invitare chi si sente ormai troppo adulto per abbassarsi alle cose da bambini a riprendere sul serio anche queste cose da bambini. Forse quello che qualche adulto disdegna dei bambini è la loro povertà. Si sente troppo ricco di sé, si sente un “io” troppo pieno, troppo grande, troppo gonfio, troppo serio e importante per rimetterlo in discussione con qualche semplice metafora di qualche povera storiella. Qualche adulto che finisce col ritrovarsi straniero a se stesso e ad avere paura, orrore di vedersi, allo specchio, il proprio castello dorato dell’“io” non più un castello dorato, ma un “io” povero, scheletrito, zoppicante, sfigurato, deforme, ferito, lì lì per morire. Ecco perché, forse, a volte abbiamo compassione, e cura, dello straniero: perché preferiamo la compassione, e la cura, all’orrore, quello stesso orrore che a volte conduce alla violenza. Ecco perché, forse, ci prendiamo cura dei poveri e delle povertà degli altri: per non accorgerci che noi stessi siamo poveri, all’interno dei nostri bellissimi “io”, e per non prenderci cura delle nostre povertà. Ecco perché, forse, arroccati nei nostri meravigliosi “io”, continuiamo a non ascoltare chi continua a dire “beati i poveri in spirito”, a ridergli addosso o a far finta di niente.