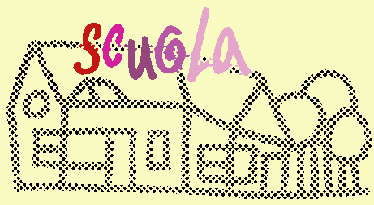 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
(24.09.2009)
Una
passeggiata nel teatro della scuola
Presupposti antropologici, etici e politici delle teorie e delle pratiche
scolastiche
E se no cosa ci
guadagno io a farlo studiare?
Strepsiade, in Aristofane, Le Nuvole, v. 1231
Il carteggio tra Georg Friedrich Creuzer (1771-1858) e Gottfried Hermann (1772-1848), che era già ben noto ed apprezzato da Arnaldo Momigliano, è stato recentemente riproposto (Sotera 2009). Rappresenta un modo in cui nell’Ottocento si sono contrapposte due modalità di approccio alla mitologia e, in generale, all’antichità greca. Oggi, una psicologia, una pedagogia e una didattica con sempre più affanno di aggiornamento, ansia di sperimentazione, presunzione di scientificità e di novità tendono a snobbare i testi antichi, come se fossero cosa non solo antica, ma vecchia, anzi, passata, morta, che non ha più nulla da dirci. Basti pensare a quanto si stiano riempiendo le nostre scuole di un nuovo lessico fatto di pof, curricoli, programmi, progetti, crediti, debiti, finanziamenti, documentazioni fatte di tabelle e grafici matematici e statistici d’ogni tipo. Nelle nostre scuole non parliamo più con la mente e col cuore, ma con la calcolatrice e il portafoglio alla mano; il nostro linguaggio, sempre più ubriaco di una buffissima cultura della sicurezza, della produttività e dell’efficienza, si riempie di numeri e immagini bancarie, assicurative, mediche o ingegneristiche.
Così facendo fanno come l’adolescente, il ragazzetto ribelle che non vuole ascoltare chi ha qualche anno più di lui né leggere cose scritte l’altro giorno, sempre ansioso di seguire le novità in televisione o su internet, di seguire le novità e di appiccicarcisi sopra con tutto il proprio essere. Ci sono cose antiche che possono continuamente essere non dico rivissute, ma riattualizzate, riviste, reinterpretate. Testi, e temi, non chiusi una volta per tutte, ma sempre aperti. Ancora oggi continuiamo a vivere, e a viverci, in relazione all’antico in modi differenti, a confrontarci con testi, e con temi, classici. Ad esempio i temi del potere, o del padrone, o del soggetto, o della saggezza, o della democrazia (cf. Muni 2009b).
Un insegnante può essere un saggio, cioè, come vorrebbe Zenone, uno che “oute despozei oute despozetai”, uno che non esercita né subisce il potere? Può essere uno “che esca dalla spirale perversa dell’asservimento di sé agli altri, o di altri a sé, e quindi dall’universalità dell’assoggettamento” (Vegetti 2008, p. 160)? Nelle scuole, le relazioni tra soggetti, ad esempio quelle tra insegnanti e studenti, possono uscire dal “discorso del padrone”, dal “Soggetto-padrone” (Rovatti 2008, p. 217)? La cultura greca classica che leggiamo nei testi che ci sono rimasti è prevalentemente una cultura del confronto, del conflitto e della guerra, in cui ciascuno deve necessariamente prevalere su rivali, una competizione senza fine e senza pace fatta di emulazioni, rivalità, rivendicazioni e vendette, ma soprattutto del calcolo dei profitti e dal desiderio di avere di più e goderne. Quella cultura, dominante nell’Atene democratica, sta continuando a dominarci?
“Nella Grecia antica […] la condizione dei genitori era essenziale per decidere chi poteva e chi non poteva diventare veramente uomo”; “in linea di massima l’unica istruzione che uno schiavo poteva ricevere era legata al tipo di lavoro e di servizio che egli svolgeva per il padrone” (Cambiano 1991, p. 89-90). Per noi le cose sono davvero cambiate? Fino a che punto? Non sono forse cambiate solo fino a un certo punto? Gli insegnanti guadagnavano poco. “I figli dei ricchi entravano prima a scuola e ne uscivano più tardi”, “come nel caso degli schiavi o dei meteci, l’apprendistato precoce tendeva a staccare i figli dei cittadini poveri dai coetanei” (Ivi, p. 91). I genitori che potevano permetterselo, i più ricchi, pagavano insegnanti privati, i Sofisti, perché i propri figli potessero diventare le élite di governo. Per questi figli di ricchi tutti gli apprendimenti venivano per quanto possibile anticipati, bruciando le tappe.
In altra forma e in altro contesto, da qualche anno i Ministri dell’Istruzione ci stanno ricominciando a schitarrare questa vecchia storia degli “anticipi” prematuri, non solo parlando delle scuole elementari, ma perfino delle scuole dell’infanzia. “L’educazione antica era fondata sul riconoscimento delle differenze sociali […], indirizzando i più disagiati al lavoro dei campi e al commercio”; “pienamente integrata nell’orizzonte dei ceti più abbienti” (Ivi, p. 118). Alcuni si prendono il diritto di proprietà della conoscenza, di proprietà intellettuale, e costruiscono recinzioni, barriere, muri: i ricchi dentro, gli altri fuori; ai ricchi il meglio, agli altri le briciole da leccare per terra. Scuole per ricchi, scuole per poveri. Insegnanti per ricchi, insegnanti per poveri. Libri per ricchi, libri per poveri. Qualcosa di quello che cade dalla tavola dei ricchi, se lo possono contendere a morsi e graffi gli altri, se ci riescono. D’altra parte, questo non meraviglia. Platone non dice cose straordinarie quando dice che i ricchi sono superiori e che hanno diritto a governare e a comandare proprio in quanto ricchi (p. es. Platone, Lettera VII, 3 34 B-C; cf. Aristotele, Pol., 1280 A 25 e 1316 B 1). Per ricchi, superiori agli altri in ogni campo, era inaccettabile “che i poveri, inferiori in tutto, esprimessero da pari la loro opinione politica” (Veyne 2005, p. 86; cf. Platone, Leggi, 744 B-D e E; ma cf. anche Polibio, II, 38, 6; IV, 31, 4; V, 26,6; VI, 8, 4 e 9,4; VII, 10, 1; XXIII, 12,9 –sull’isegoria-; Eschine, Contro Ctesifonte, 6 –sulla parresia-). Per noi sarebbe come dire che un insegnante di scuola dell’infanzia, elementare, media o superiore (oggi si dice “primaria” e “secondaria”) o un precario docente universitario, insomma una massa confusa e disordinata di insegnanti da quattro soldi, si mettessero a esprimere ognuno le proprie opinioni politiche turbando la sacrosanta tranquillità della classe politica e dirigente. Sarebbe come dire che ciascuno “vive come vuole” (p. es. Aristotele, Pol., 1310 A 30 e 1317 B 10; Isocrate, Areopagitico, 37 e 20; Platone, Repubblica, 557 B): un disastro. Sarebbe come una democrazia estrema, “come se noi ammettessimo al voto i bambini che hanno appena l’età della ragione o dessimo la cittadinanza ai buoi da lavoro” (Veyne 2005, p. 95, nota n. 28).
In più, ci ritroviamo ad avere a che fare con quell’omogeneizzazione culturale, quell’appiattimento culturale che ci viene sempre da là, da chi ha più soldi per costruirsi una qualche “cultura” e imporla. Vale a dire: chi li scrive, i libri (i migliori, non le versioni “economiche”, “ridotte”), chi insegna nelle scuole più prestigiose e influenti, chi e a chi? Chi stabilisce i parametri culturali legittimi? I criteri culturali egemoni sarebbero funzionali a chi, a cosa? Questa cultura che ci vien data come pacifica, da quali lotte culturali salta fuori, e quali continua a mantenere all’interno della sua maschera di pace? Le ingiustizie, le rivalità e i disordini sociali non sono forse frutto della ricchezza, della cultura dei ricchi e della ricchezza (cf. p. es. Platone, Leggi, 678 B-C), che è una cultura imposta con la forza delle armi e dei mezzi economici? “Il nemico numero uno è la cupidigia, ossia la ricchezza” (Veyne 2005, p. 86, in commento a Platone, Leggi, e ad Aristotele, Pol.); “non bisogna dipendere dall’economia, perché il commercio è solo cupidigia e lusso. E lusso significa decadenza” (Ib.). “La ricchezza genera gelosie e lotte” (cf. Polibio VI, 57); “i ricchi si adagiano nel lusso”, “il denaro dissolve la virtù” e, “quando si allenta la tensione etica, tutti i vizi si accalcano in massa alle porte della città” (Veyne 2005, p. 86, in commento a Platone, Leggi, e ad Aristotele, Pol.). “Tutto il male viene dalla cupidigia dei ricchi” (Ib.; cf. Platone, Leggi, 832 A); “essere ricco significava credere che tutto fosse permesso […,] luxuria” (Ivi, p. 99, nota n. 69, in cf. a Aristotele, Pol., 1259 B 5-20 e Isocrate, Areopagitico, 4).
Oggi la maggioranza degli insegnanti, soprattutto di scuola dell’infanzia ed elementare, sono donne. Il Pericle di Tucidide osserva che, per una donna ateniese, era un merito che nessuno ne sapesse niente, in quanto normalmente sono, e devono essere, nascoste, non viste. Adesso il Ministro dell’Istruzione è donna, come pure molte Dirigenti Scolastiche o docenti di materie psicologiche, pedagogiche e didattiche. Ah, questi ateniesi! Che ci hanno lasciato commedie e tragedie, testi di storia e di filosofia, ma non ci hanno lasciato neanche una storia d’amore! Il “primo, incerto tentativo di storia d’amore” (Redfield 1991, p. 159) è il Dyskolos di Menandro (316 a.C.), sette anni dopo la morte di Alessandro Magno.
D’altra parte, l’“amore” di cui si parla nei testi di lingua greca antica (precristiana) è “eros” o “philia”, quasi mai “agape”. È un “eros”, bramoso e possessivo, che va e viene, che si consuma in qualche manciata di istanti, oppure una “philia” fondata o su una “virtù”, o su un “utile”, o su un “piacevole” (cf. p. es. Aristotele, Eth. Nic. VIII 2; cf. Eth. Eud. VII 4: 1239a). In ogni caso non è un’esperienza che ci conduce al di là di noi stessi, non è una condizione di felicità o una via alla felicità (“beatitudo”), non ha a che fare con l’infinità, l’eternità, il totalmente altro rispetto alla quotidianità strisciante e graffiante del nostro esistere. Insomma, a questi ateniesi l’amore interessava solo quando poteva servire alle cose della politica, dell’economia, dell’esercito; l’amore era una merce da comprare o da vendere, e sulla quale fare calcoli ed investimenti; l’amore era un esercizio delle politiche patrimoniali e del diritto di proprietà; l’amore, in un modo o nell’altro, mirava solo al loro tornaconto dei maschi. Aristotele ci vorrebbe far capire “che i greci sono superiori ai barbari e che sono il capolavoro dell’umanità” (Veyne 2005, p. 77, con riferimento a Defourny 1932, p. 383). Ma non ce ne convince affatto. Cosa diversa è dire che qualcuno (pochi o molti) dei greci si è voluto sentire tale, e ha finito col sentirsi effettivamente tale. Ancora una volta, continuiamo a non sentirci più “ateniesi”, a non volerlo essere e ad esserne orgogliosi. Ma davvero non lo siamo più fino in fondo, oppure ci rimane ancora addosso qualcosa di appiccicoso che facciamo proprio fatica a lavar via?
Oggi c’è tutto un gran parlare di “progresso”. Ma un progresso tutto rinchiuso dentro la storia naturale, un progresso affidato alla sola tecnica umana, alla fin fine è solo un progresso relativo all’aumento dell’avere, da parte di alcuni in contrapposizione ad altri. Cresce la ricchezza, aumentano le disparità, le disuguaglianze, gli squilibri, gli sprechi, i rischi, le nuove forme di sfruttamento, di colonialismo, di dipendenza e di schiavitù. La tecnica, in quanto tale, ogni tecnica, quale che sia, non è cattiva ma neanche buona, ma ambivalente, non può che esserlo. In effetti, l’educazione non dovrebbe solo formare “alle attività strumentali, pratiche o tecniche, ma anche e soprattutto alle attività fini a se stesse, con cui l’uomo si dedica nel tempo libero, perché in queste egli realizza pienamente la propria umanità” (Berti 1979, p. 316; il riferimento è ad Aristotele, Pol. VII 14s.).
C’è tutto un chiacchierare di “sviluppo”. Sotto sotto mi sembra che la parola “sviluppo”, così come viene usata, lasci trasparire l’idea, tutta edonistica, speculativa e consumistica, consegnata alla cultura economica e tecnica, di “efficienza” e “profitto”, di “utilità” economica o materiale misurabile. All’interno di quadri di forze, ciascuno cerca vantaggi competitivi nel mercato, quale che sia, compreso il mercato culturale, là dove c’è una scuola, un istituto o un ente di formazione o ricerca, un qualunque “centro culturale”. Lo scambio culturale può essere una forma di scambio commerciale, la cultura può essere una merce da vendere o comprare e con la quale arricchirsi e mettersi al di sopra di altri. Tutto questo all’interno di una interpretazione utilitaristica e produttivistica della vita umana, egoisticamente chiusa in se stessa con l’arroganza dell’autosufficienza, la presunzione di bastare a se stessa. Il “progresso”, lo “sviluppo” vengono intesi come crescita nel “benessere”, e il “benessere” viene visto come “felicità”. Attratti da questa illusione, si va come zanzare a farsi bruciare nelle tante luminosissime trappole messe qua e là.
Che dire degli insegnanti? Non sono forse “lavoratori”? Come tutti i “lavoratori”, non corre il rischio di adattarsi a meccanismi automatici, non liberi e non liberanti, non creativi ma da catena di montaggio? Certo, se un insegnante si accontentasse di essere un insegnante “giusto”, di agire con giustizia, obbediente alle leggi e con senso del dovere, sarebbe destinato a essere un pezzo di ingranaggio dell’industria scolastica. Potrebbe ritrovarsi a dire, con Edipo: “I miei atti li ho subiti piuttosto che fatti” (ta g’era mou / peponthot’esti mallon e dedrakota) (Sofocle, Edipo a Colono, vv. 266-267); potrebbe cioè ridursi ad a fare atti comandati, contrattati, non voluti, involontari (erga akonta). Per uscirne fuori, ci occorre sostituire alla logica mercantile competitiva, dello scambio e del profitto fine a se stesso, teatro delle sopraffazioni dei più forti sui più deboli, dei più ricchi sui più poveri, considerati come “pesi” per gli altri, limoni da spremere o asini da caricare, la logica della “gratuità”, della “generosità”, del “dono”, logica che per sua stessa natura supera il merito, eccede la sufficienza, oltrepassa le leggi, va aldilà da una parte del “dovere”, dall’altra del “diritto”. Che, detto tra parentesi, nelle famiglie agiate a volte sembra un diritto “al superfluo”, sputato in faccia con indifferenza a chi non si vede riconosciuto nemmeno il diritto al cibo, all’acqua, alla casa, al lavoro.
Ci occorre lasciar stare la vecchia logica del “dare per avere” e del “dare per dovere”, per lasciar spazio alla logica del “dare per amore”. Per buttare a mare queste vecchie logiche ci occorre prima di tutto accorgerci di essere schiacciati e imbarattolati da interpretazioni individualistiche e utilitaristiche che ci usano tutti come prodotti da (e del) mercato, come (s)oggetti da misurare e calcolare ai fini di sistema chiuso in se stesso, fine a se stesso e autolegittimato, accorgercene e averne disgusto. Ci occorre prender atto del fatto che alla fin fine alcuni ci dicono che noi siamo quello che siamo solo per processi casuali o causali (deterministici), per cui alla fini fine sei ricco o povero per caso o per necessità (causale). L’io diventa la stessa cosa della psiche, della mente, e la mente la stessa cosa delle molecole che compongono il cervello raccogliendo un input di qua e uno di là. Tu come insegnante non ci puoi far niente, non puoi illuderti di uscir fuori da questo meccanismo spietato dell’universo dove non c’è proprio spazio per far qualcosa d’altro che non sia dettato del caso e della necessità. Le varie tecniche che ci ritroviamo fra le mani ci aiutano a dominare la natura, a diminuire i rischi, a far meno fatica nelle cose della vita e a vivere con maggio benessere. E allora? Tutto questo può forse aiutarci a essere diversi, migliori, più giusti, buoni, felici, amabili; a trasformarci in angeli? Che ce ne facciamo di rapporti “corretti”, “giusti”, “legali”, ma tutti fatti per interesse, per tornaconto, senza amore, senza cuore (cf. p. es. Lodovici 2009)?
Tutto questo ha a che fare con la politica. Politica scolastica, politica culturale, politica generale. Non è vero, come vorrebbe il Ministro Gelmini, che la politica deve stare fuori dalla scuola e che, se un insegnante vuol fare politica, deve lasciare la scuola; è una stupidaggine che "chi fa politica deve farlo fuori dagli edifici scolatici”, fa ridere (e piangere) sentirsi dire che “se un insegnante vuol far politica deve uscire dalla scuola e farsi eleggere; quella è la sede per le sue battaglie, non la cattedra” (conferenza stampa pubblicata dalla stampa il 14 settembre 2009). È vero il contrario. Ciascun insegnante è, o può essere, con modalità particolarissima, un filosofo (Muni 2009a; 2009c) e un soggetto politico; ha una funzione e una responsabilità sostanzialmente etica e politica, deve fare fondamentalmente politica, il suo stesso mestiere è un mestiere essenzialmente politico.
D’altra parte, se non fosse così, sarebbe uno che lavora “per bisogno” (cf. Veyne 2005, p. 81), uno che si preoccupa “soprattutto di guadagnarsi da vivere e lascia volentieri la politica ai ricchi” (Ivi, p. 82; con riferimento ad Aristotele, Pol. 1318 B 10 e 1319 A 30 e cf. Polibio, IV, 73, 7-8), a una classe dominante che detiene da sola “il potere, la ricchezza, la cultura” (Veyne 2005, p. 82, riprendendo un’idea di Robert Dahl già sviluppata in Veyne 1976, p. 117). Una classe dominante che non è fatta da insegnanti ma li usa, li sfrutta, gli impone di eseguire le proprie direttive, di fare sostanzialmente ciò che è il proprio interesse particolare, o almeno di non andarci contro, in quanto la cupidigia dei ricchi, dei potenti, dei colti, che sono la classe dominante, “non lascia alcun momento libero per occuparsi di altre cose che non siano i possessi privati [… e] deride tutto il resto” [Platone, Leggi, 831 C]. È vero che i buoni cittadini sono “rispettosi delle leggi” (cf. p. es. Senofonte, Memorabili, I 2, 41; Aristotele, Eth. Nic., I, 13, 1102 a 8; II, 1, 1103 b 5); è vero che “si chiede al buon cittadino di non cambiare nulla […] e di non rendere vane le disposizioni non obbedendovi, in quanto non obbedire a una legge è distruggerla” (Critone, 50 A-B). Ma è altrettanto vero che, come dice un ateniese, “un uomo che non fa politica non passa per un uomo pacifico ma per un cattivo cittadino” (Tucidide, II 40, 2; cfr. Meier 1980, p. 248 ss.).
Ci occorre recuperare tutto il colore politico della scuola, della cultura, della società, fatto di lotte e conflitti mai finiti, sempre presenti. Il possidente Demostene ha successo davanti al popolo quando, contro Eschine (Per la corona, 10 e 256-258), dice:
Io valgo più di Eschine e sono nato meglio di lui; non vorrei che il mio sembrasse un insulto alla povertà, ma bisogna proprio che io dica che il mio destino, da bambino, è stato di frequentare delle buone scuole, di avere abbastanza fortuna da non essere costretto dal bisogno a compiti disonorevoli. Quanto a te, Eschine, la tua sorte da bambino è stata di spazzare come uno schiavo la classe dove insegnava tuo padre.
Ecco la coloritura politica delle scuole, di quelle antiche e di quelle di oggi. Non possiamo chiudere gli occhi. Non possiamo essere indifferenti. Non come insegnanti, non come cittadini, non come persone di passaggio in questo mondo. Essere genitore (avere figli) è già diventato un lusso, e lo sta diventando sempre più. Essere insegnante (anche nelle poche scuole di eccellenza, aristocratiche, di élite) è da sempre una modalità dell’essere servo (o schiavo) di famiglie o gruppi politici economicamente, militarmente o culturalmente forti, dell’essere servo (o schiavo) senza essere chiamato tale. Essere persona umana è sempre dover decidere momento per momento se fare come il laico e razionale Edipo o come il religioso Tiresia, che rinuncia all’orgoglio della ragione, “e forse per questo Apollo ora è più clemente” con lui (Guidorizzi 2008, p. XXIII, in commento all’Edipo a Colono). Il “che devo fare?” (tì draso), tanto dell’insegnante quanto dello studente, è l’essenza stessa del dilemma tragico (p. es. Snell 1928, pp. 157 ss). Essere persona umana è essere momento per momento tentati di restarsene “prigionieri della smania d’affermare il proprio minuscolo io” (Del Corno, p. XIX) barcollando nella “macina spietata della storia” drogati della “chimera del progresso” (Ivi, p. XVIII).
Bibliografia
Berti E.,
Profilo di Aristotele, Studium, Roma 1979.
Cambiano G., Diventare uomo, in Vernant J.-P., a cura di, L’uomo greco,
Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 87-120.
Defourny M., Aristote: études sur la “Politique”, Paris
1932.
Del Corno D., Introduzione a Aristofane, Gli Uccelli, a
cura di Zanetto G., Fondazione Lorenzo Valla – Arnoldo Mondadori, Cuneo 1987
(1), 2005 (VI),
Galzigna M., a cura di, Foucault, oggi, Feltrinelli, Milano 2008.
Guidorizzi G., Introduzione a Sofocle, Edipo a Colono, a cura di
Avezzù G. e Guidorizzi G. e tr. it. di Cerri G., Fondazione Lorenzo Valla –
Arnoldo Mondadori, Padova 2008.
Lodovici G. S., Il ritorno delle Virtù. Temi salienti della Virtue Ethics,
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2009.
Meier C., Die Entstehung des Politischen bei den Griechen,
Frankfurt 1980, tr. it. La nascita della categoria del politico in
Grecia, Il Mulino, Bologna 1988.
Muni A., Cose che gli insegnanti non dicono, Armando, Roma 2009 (a).
Muni A., Essere maestro, in Cooperazione Educativa, rivista
pedagogica e culturale del Movimento di Cooperazione Educativa, vol. 58, n. 3,
settembre 2009 (c), pp. 57-58.
Muni A., recensione a Domenico Musti, Erodoto, Tucidide e la storiografia
greca. Introduzione a Erodoto, Storie, Milano, Rizzoli, 2008, in Ivo
Mattozzi (cura), Il Bollettino di Clio, periodico dell’Associazione di
insegnanti e ricercatori in Didattica della Storia “Clio ‘92”, anno X, n. 28,
Venezia, luglio 2009 (b), pp. 5-7.
Redfield J., L’uomo e la vita domestica, in Vernant Jean-Pierre, a cura
di, L’uomo greco, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 153-185.
Rovatti P. A., Il soggetto che non c’è, in Galzigna Mario, Foucalt,
oggi, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 216-225.
Snell B., (1928), Eschilo e l’azione drammatica, tr. it. Milano 1969.
Sotera F., a cura di, Lettere sulla mitologia, ETS, Pisa 2009.
Vegetti M., Foucault, gli antichi e noi, in Galzigna Mario, Foucalt,
oggi, Feltrinelli, Milano 2008, pp. 150-162.
Vernant J.-P., a cura di, L’uomo greco, Laterza, Roma-Bari 1991.
Veyne P., L’empire gréco-roman,
éditions du Seuil, 2005 ; tr. it.
L’impero greco romano, Rizzoli 2007.
Veyne P., Le Pain et le Cirque, Paris 1976, tr. it.
Il pane e il circo, Il Mulino, Bologna 1984.