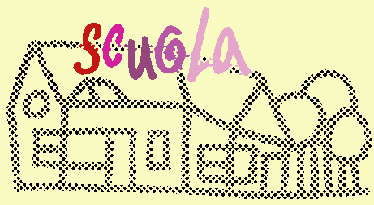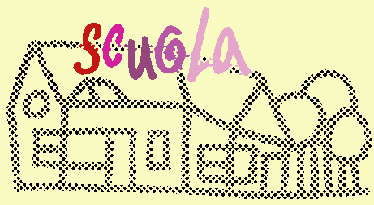 |
Direzione didattica di
Pavone Canavese |
(02.11.01)
Case comuni
sul fiume, grandi
Ma la guerra è una cosa
"normale" ?
di Andrea Bagni
Per i ragazzi e le ragazze che
abitano le scuole temo la guerra sia tornata ad essere qualcosa di tutto sommato
"normale". Il risultato è per tutti una estrema desertificazione del discorso:
la lotta del bene contro il male, l’ennesima incarnazione del male in un diavolo da
eliminare, si è con l’occidente o con il terrorismo, o si fa la guerra o non si fa
niente e la prossima volta chissà cosa ci faranno; ce l’abbiamo le palle oppure
no? E mai espressione, così insopportabile ormai, mi è sembrata più azzeccata,
appartenendo in pieno a questo immaginario maschile della sfida, pedagogia della forza che
dà lezioni e insegna – lascia segni – l’ordine. Chi non si schiera in armi
fa la parte degli scienziati nella fantascienza anni 50, che pretendevano di proteggere e
studiare la cosa-venuta-da-un-altro-mondo ed erano regolarmente salvati dai militari eroi
consapevoli del pericolo.
Scompare dalla scena lo spazio del discorso; scompare la politica del fare società,
tessere fili, intrecciare relazioni – o meglio resta affidata all’invisibilità
delle "donne in nero", delle reti e associazioni di aiuto alla popolazione
afgana. Roba di donne, comunque. Che non fa spettacolo.
Proprio la tragedia delle Torri e del Pentagono avrebbe dovuto segnalare come non
c’è difesa possibile per questa guerra negli scudi spaziali, nella superiorità
degli eserciti e degli apparati statali. Non è questione di eserciti e stati, di chi
perde e muore e di chi vince e resta vivo, quando si è disposti a morire pur di dare
morte e tutti i confini sono saltati – ma si vorrebbero riprodurre nelle anime
(le mie studentesse arabe e cinesi, che hanno capito bene cosa sono le guerre di
religione, si definiscono serenamente atee, penso anche per non giocare più al gioco
crudele di chi ha dalla sua parte il dio maggiore).
Nelle scuole abbiamo imparato che si vive (quando si vive) di parole, di sguardi, di
racconti, in un tessuto simbolico di rappresentazioni del mondo; sento ancora più triste
qui questa spoliazione del discorso, dello spazio politico, di costruzione della polis.
Ma esiste anche, l’abbiamo visto a Genova, una politica come pratica di relazioni
sociali che attraversa il mondo dei ragazzi e delle ragazze, restando invisibile ai media
e alle istituzioni. Mi pare sia una questione proprio di esistenze politiche,
liberazione di socialità, spostamenti molecolari ma capaci di contagio e produzione di
senso. Forse anche di felicità, per quanto nello sfacelo della violenza e della miseria
del mondo: una felicità sovversiva, non lo scavarsi una nicchia, piuttosto
sottrarsi e spostarsi per costruire altrove.
Perché il punto è che la normalità della guerra è anche l’altra faccia e la
garanzia di un ordine, la sua affermazione in termini di civiltà superiore del
valore di scambio, da liberare (come sa il WTO) e difendere (come sa la NATO);
occidentalizzazione del mondo nella forma d’equivalente universale della merce.
Mercificazione di qualunque bene comune, materiale o immateriale, acqua terra e pensiero,
nella privatizzazione dell’esistenza e nella globalizzazione della solitudine.
Nella società del rischio e dell’insicurezza, il sapere diventa "capitale
conoscitivo" da acquistare individualmente e da spendere sul mercato del lavoro come
opportunità di affermazione personale: risorsa formativa delle "risorse umane"
nella competizione sociale. Anche nelle socialdemocrazie.
È un insieme un modello del sapere e del suo processo produttivo.
Una costruzione di conoscenza che ha carattere qualitativo e relazionale, legato a
contesti significativi e a un senso condiviso, al rapporto fra generazioni diverse che
s’incontrano (e si scontrano) intorno a un progetto collettivo di vita, diventa un
bene quantificabile, da tradurre in segmenti componibili, modularizzati, certificabili in
un libretto formativo che mette a valore tutta la propria vita, tradotta in crediti,
conoscenze ridotte ad una misura astratta e dunque universalmente riconoscibile,
scambiabile in ogni luogo del mercato del lavoro. Astratta, impersonale, intercambiabile,
proprio come la moderna prestazione di lavoro, povera precaria intermittente - per questo
paradossalmente da porre al centro della propria biografia, in una subalternità assoluta
alla radicale incapacità di dare senso, identità, fondazione di diritti, del nuovo
lavoro.
Allora ecco l’autonomia scolastica ridotta ad organizzazione verticale,
aziendalistica e insieme neofeudale (fondata su vincoli di fedeltà personale al signore
dirigente); la diffusione di una mera sommatoria di progetti e progettini client
oriented: come in un fast food del sapere, supermercato della formazione dove ogni
famiglia è "autonoma" nel comprare il suo pacchetto componibile a piacere di
moduli integrati (compresa beninteso l’educazione ai valori d’appartenenza)
– la scuola altrettanto nello stare sul mercato dell’offerta di micro saperi. E
l’apprendimento scambiato dovrà essere oggettivamente misurabile, prestazionale,
meccanicistico. Orrendamente "scientifico" (naturalmente un’altra scienza
esiste).
Ecco anche la nuova finanziaria che sposta risorse dalla scuola agli apparati militari, fa
decidere tutto all’esecutivo, riduce insegnanti e stipendi, togliendo spazio a tutto
ciò che nell’orario dei docenti non è lezione, interrogazione, voto, sostituzione
di colleghi: anzi non considera neppure lavoro (dentro le 18 ore) ciò che non è calcolabile
come ora di lezione frontale, quantità di tempo speso per. E naturalmente premia le
scuole private – così come l’uso privatistico delle scuole pubbliche (ma anche
le tre date di sciopero delle tre sigle dell’autorganizzazione, più quelle dei
concertativi, hanno l’aria paradossale di una triste privatizzazione del conflitto).
Però il pensiero unico del sapere come bene privato delle nuove risorse umane, da
acquistare in aziende-scuole tecnicamente organizzate per la produzione di nuovi
lavoratori-consumatori, senza limite adattabili alla flessibilità della domanda, non è
privo di crepe. Chiede alla formazione – anche universitaria – maggiore
curvatura verso il lavoro e contemporaneamente informa che non esiste più il posto di
lavoro sicuro, ma si dovrà abituarsi a cambiarne tanti nella vita – come fosse una
grande occasione di creatività sociale e non l’incubo della precarietà ricorrente.
E poi proprio la crisi della società del lavoro dà senso (come mai prima d’oggi
forse) a un sapere di base, critico e problematico, gratuito : formazione alla
società, saltati i tradizionali canali (maschili) della trasmissione sociale - diploma,
lavoro, sindacato, partito, pensione - più che alle prestazioni professionali.
A Firenze il 20 e 21 ottobre i ragazzi e le ragazze che hanno discusso della conoscenza
nell’epoca del sapere messo al lavoro, mi pare che avessero molto forte il bisogno di
fare del sapere un bene comune universalmente accessibile, senza le recinzioni dei
vari copyright ; il desiderio di fare degli spazi in cui si costruisce e si
scambia, luoghi pubblici riconosciuti nella loro specificità, da sottrarre alla
trasmissione spenta di un sapere blindato e arruolato in qualche industria militare;
territori liberati dal paradigma quantitativo ed economicistico delle conoscenze, spazi
pubblici dove la società educhi se stessa e si riconosca come in sue istituzioni
di autoformazione, reti di un mondo comune tessuto dalla molteplicità dei punti di vista:
né colonizzato dalla domanda (familistica) di mercato, né ridotto a trasmissione
burocratica di una pedagogia di stato, né polverizzato in territori dove ognuno si fa le
sue scuole, del quartiere o della ditta.
Il movimento che si è incontrato a Genova e cerca adesso un nuovo patto di lavoro, può
anche sbagliare strada naturalmente; può decidere di "farsi del male"
riconducendo il largo fiume di Genova e Assisi al torrente consueto e rassicurante dei
pochi ma illuminati, dotati di tutti i contenuti e delle analisi giuste. Ma può anche
provarsi ancora a costruire case comuni sul fiume più grandi, per le diversità da
abitare. Forse potrebbe imparare da quel pezzo di novecento non organizzativistico né
innamorato delle linee e delle piattaforme, rappresentato dal movimento delle donne; dalla
sua capacità di ascolto, di cura del discorso e delle relazioni. A me, almeno, sembra di
avere imparato molto.
Può ripartire credo anche dai ragazzi e dalle ragazze che hanno parlato e si sono
ascoltati a Firenze. Non era scontato e non è stato un lavoro da poco.