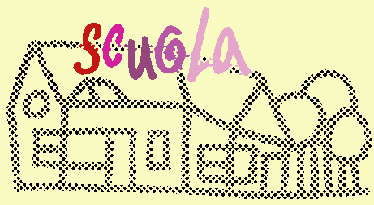 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
02.10.2010
Il sistema
di istruzione nazionale tra federalismo e localismo
di Franco De Anna
Di fronte ai timori di vedere
investito il carattere unitario del sistema di istruzione da ventate di
localismo capaci di corroderne il valore “istituzionale” e nazionale ho
sempre reagito con sconcerto: la disomogeneità reale del sistema è sotto gli
occhi di tutti, ben prima dei dati INVALSI o di quelli delle ricerche
internazionali.
L’uniformità amministrativa, il carattere nazionale della legislazione, le
regole di funzionamento assolutamente codificate sul piano nazionale non
hanno impedito (anzi) di aprire voragini di incomparabilità reale tra la
scuola di certe regioni e di altre; e, all’interno della medesima regione
tra scuole di certe zone e scuole di altre zone…
Invocare “lo Stato” serve a poco, se è proprio il funzionamento concreto
dello Stato-ordinamento a produrre tale incomparabilità e “l’ingiustizia”
(l’incapacità di garantire diritti “eguali”) che è ad essa connessa.
D’altra parte la stessa comparazione internazionale dovrebbe dirci qualche
cosa in proposito: il sistema di istruzione francese con il suo centralismo
statale, (ma si veda la consistenza della scuola privata in Francia, molto
più elevata che in Italia) non è “meno sistema” di quello dei paesi
anglosassoni caratterizzati da un “decentramento” che ad alcuni di noi
farebbe rizzare i capelli ben più che non le “battute” provocatorie di
qualche esponente del peggior federalismo dichiaratamente anti statale
nostrano.
La Francia alleva i suoi dirigenti pubblici con le grandi scuole o con l’ENA.
Il Regno Unito forma i suoi dirigenti in modo assolutamente diverso
attraverso un paio di università. Ciò che rende il sistema pubblico
“sistema” non è (o non solo o non principalmente) l’uniformità
amministrativa e giuridica (il Regno Unito non ha neppure un “diritto
amministrativo”). E’ invece il livello di “socializzazione” professionale,
omogeneità culturale e formativa, la comune deontologia, dei public
servant che si acquisisce attraverso la comune formazione, in qualunque
modalità sia organizzata concretamente nelle forme organizzative e
giuridiche.
Dall’ENA escono, con la comune formazione, i dirigenti pubblici francesi che
poi, politicamente, possono stare a sinistra come a destra (e non per caso
Sarkò è storicamente una eccezione: non viene dall’ENA)… e da quel paio di
università inglesi si ottiene il medesimo prodotto. Si consideri inoltre che
mentre il centralismo francese si è corretto negli anni scorsi attraverso
alcuni strumenti di “deconcentrazione del potere” (da sinistra), il
decentramento anglosassone ha acquisito alcuni elementi di “centralismo”
(per esempio il sistema centrale di valutazione delle scuole) con
provvedimenti “da destra” (l’Education Act della Thacher..).
Insomma certe “analisi” nostrane sembrano costruite sulle sabbie mobili….
Per sintetizzare: l’unitarietà del
“sistema”, anche e soprattutto nel caso della scuola è affidata non alla
uniformità giuridica e amministrativa (che smentisce nei fatti il risultato
“eguale”) ma sulla comune deontologia, formazione professionale, “costume”
culturale, impegno civile degli operatori della scuola, docenti e non.
Togliete tale cemento e collante di sistema e nessun “sistema” sarà tale,
quale che sia la “forma organizzativa” o il codice giuridico che pretenda di
governarlo unitariamente. Se ne può discutere, ma rivendico il fatto che
tale affermazione riposi su un set di “dati e risultati” che molto
difficilmente possono essere negati. Si può tentare di spiegarli
diversamente. Ma negarli mi sembra impossibile.
Voglio provare un approccio
autobiografico, piuttosto che analitico, e me ne scuso con i miei men di 24
lettori.
Un paio di mesi fa, come ispettore, sono stato inviato a verificare i
risultati dei PON (finanziati dai fondi UE) in alcune scuole del primo ciclo
in Campania e Calabria.
Sono partito in un giro di qualche migliaio di chilometri con il mio corredo
di dati (rilevazioni INVALSI, esiti delle prove degli esami di terza media,
dati della dispersione ecc…) che “dicevano” delle differenze più che
significative, negli esiti di apprendimento, sia rispetto ai valori delle
medie territoriali sia dei valori della singola scuola rispetto ai primi.
L’ipotesi era dunque di verificare sul terreno quelle differenziazioni nella
comparazione e di verificare se i Fondi UE migliorassero o meno la
situazione.
Dico subito che ho trovato sempre Dirigenti e gruppi di docenti più che
impegnati: in quelle condizioni operative tutti quelli incontrati “davano
l’anima”.
Non poteva né può essere questa la variabile causale della disomogeneità di
risultati.
Ma…
1.
I differenziali, più che significativi ripeto, nei
risultati di apprendimento non costituivano, in generale, uno spunto
analitico comune per guardare e analizzare il proprio lavoro.
Non fa parte della realtà e dell’immaginario professionale (per la verità né
in quelle realtà, né in quelle di migliori risultati, per esempio nel Nord)
il costume di misurarsi con i risultati comparati.
Tutti rifiutano l’ipotesi di “graduatorie” tra le scuole o di rating al
quale traguardare processi di valutazione, e ciò è assolutamente giusto e
condivisibile.
Ma non guardare ai dati come “sintomi”, per ricostruire diagnosi, prognosi e
predisporre cure di miglioramento è davvero rifiutare la realtà e qualunque
approccio razionale ad essa. Significa sostituire l’analisi della realtà con
“apparati di giustificazione” (che siano fondati o meno, dal punto di vista
dell’atteggiamento professionale, la cosa non cambia) che possono sortire
due esiti apparentemente contrapposti: il rancore e la rabbia frustrata o
l’opportunismo consolatorio.
Nell’un caso come nell’altro si traducono in immobilismo, che sia
“protestatorio” o all’opposto “rassegnato” fa certamente una differenza
“soggettiva”, ma conduce al medesimo risultato rispetto alla possibilità di
agire per “cambiare la realtà”.
2.
L’INVALSI, per il quale ho fatto questo lavoro,
aveva (ha) predisposto una serie di indicatori per “guidare” l’indagine e
rispondere, in termini di rendicontazione, alla UE che fornisce i fondi PON.
Non sono oggetto di questo mio articolo. Voglio solo ricordare che, ad un
certo punto, ho trovato un “indicatore personale” assai più significativo:
dopo avere analizzato in comune con i docenti e i dirigenti i “dati” in
comune possesso, ho cominciato a chiedere di “visitare i bagni” delle
scuole, sia quelli dei docenti e del personale che quelli riservati agli
studenti.
Provocazione? No. Semplicemente ho realizzato che, a parità di impegno del
personale della scuola, di spirito di sacrificio e di abnegazione di docenti
e dirigenti, la variabile che poteva influire in modo determinante sui
risultati di apprendimento (a meno di considerare derive genetiche che
farebbero piacere a qualche rozzo federalista nostrano) aveva a che fare con
“l’ambiente di apprendimento”.
Badate, non tanto con i laboratori. Ho trovato splendidi laboratori di
informatica soprattutto (e qui bisognerebbe sviluppare un buono e
sensatamente critico ragionamento sul fatto che l’informatica finisca per
“sequestrare” ogni idea di laboratorio), ben attrezzati, lindi e senza un
granello di polvere, acquistati con i fondi UE.
Ma prima di tutto con gli spazi e le strutture “ambientali” nei quali si
sviluppano i tempi della scuola e la vita dei “corpi” che la occupano. I
“bagni” erano un buon indicatore.
Devo raccontare cosa ho trovato?
La domanda è cruciale: se “l’ambiente pubblico” non garantisce una
vivibilità ed un conforto almeno confrontabile con quello che ciascuno trova
nella sua casa, dove mai potrò fondare il “primato” del pubblico, il senso
di comuni “proprietà, possesso, cura”? Come convincerò gli studenti, e le
loro famiglie, che “stare a scuola” è diritto e dovere necessari, fondati, e
che la fatica che comunque implicano è “ben riposta” e in grado di dare
risultati e “benessere”?
Non sono tra quelli che pensano che l’apprendimento sia tout court
una “gioia”. Dico spesso che l’apprendimento avviene per stretching…
un “trascinamento” doloroso da dove sei a dove devi andare… Ma, come con lo
stretching, i doloretti che impone producono benessere successivo.
3.
Ma quale benessere in strutture fatiscenti, in
muri grigi e scrostati, in aule che sono scatole di un ambiente (quando va
bene) più simile ad un ufficio amministrativo, fatto di una sequenza di
stanzette nelle quali passare sei sette ore di vita mettendo in fila
Matematica, Italiano, Scienze, ecc… scandite dal suono di una campanella.. I
bagni diventano allora un “paradigma” ambientale.. luoghi nei quali la pena
della loro frequentazione lascia una sola soluzione: scrivere invettive più
o meno fantasiose e scurrili sulla loro porta sconnessa e sbrecciata…
Comunque la scuola diventa un luogo da quale fuggire il più in fretta
possibile al suono dell’ultima campanella. E ciò vale sia per gli studenti
che per i docenti.
Fino a prova contraria io sono convinto che questo insieme di variabili che
raggruppo sotto l’etichetta di “ambiente di formazione” rappresenti il vero
elemento discriminante rispetto ai risultati di apprendimento. (Guardato con
gli occhi di chi vi lavora significa “organizzazione del lavoro”: classi,
classi di concorso, ore di lezione, orari, tempi, durate, scansioni. Se
lasciamo inalterato tutto ciò, a filtrare gli investimenti che a gran voce
si chiedono, la loro scarsa produttività e la differenziazione dei risultati
sono un prodotto inevitabile)
E la situazione “media” (non “generale”, vedi oltre) osservata in quelle
regioni era di assoluto sconforto anche coltivando l’ipotesi di possibili
processi di miglioramento. La tentazione di affermare che forse era meglio
“chiudere” e ricominciare con altre regole è stata sempre assai forte.
4.
Ma se è così, dove rintracciare le responsabilità,
dove identificare il fulcro per piantare la leva del cambiamento?
Le regole amministrative (per esempio il calcolo degli organici, le classi
di concorso, i programmi, il contratto di lavoro, gli orari..) sono le
medesime. Le norme statali sono le stesse.
Inutile fare giri di parole: la prima responsabilità è nei poteri locali,
nelle municipalità, nelle Provincie, nelle Regioni. Non “a causa” del
cosiddetto federalismo, ma “senza” il cosiddetto federalismo.
Detto in buona approssimazione, quello che ho avuto sotto gli occhi in quel
giro di qualche migliaio di chilometri (inutile parlare di “mezzi pubblici”
ovviamente) era il fatto, “misurabile con i mezzi delle scienze naturali”
(avrebbe detto un vecchio cane morto) che i fondi UE servivano a fare ciò
che non facevano Comuni, Provincie, Regioni in quelle realtà, e che sarebbe
stato loro compito istituzionale fare, ben prima di, e non ostante Tremonti
e la Gelmini.
Se la scuola non è vissuta come “capitale sociale” della comunità locale non
c’è norma statale che possa garantire la sua qualità ed i suoi risultati.
Se la comunità locale non fa della scuola un “investimento sensato”, un
luogo di suo riconoscimento, la prima e originaria fonte della cittadinanza,
del legame comune verso il ”bene comune” a partire da ciò che
prioritariamente compete (gli ambienti, gli spazi, i tempi
dell’apprendimento), non saranno i livelli superiori dell’ordinamento a
sopperire al “capitale sociale” in difetto, applicando regole nome per
definizione “erga omnes”.
5.
Ma non si tratta solo, anche se ciò è essenziale,
delle responsabilità nei luoghi “amministrativi e politici” più prossimi ai
cittadini, quelli che più direttamente sono (sarebbero) sottoposti al loro
controllo democratico. (Se il federalismo servisse anche solo a fare
“pulizia democratica” mettendo le classi dirigenti locali di fronte alle
responsabilità dei loro risultati, sarebbe già buona cosa…).
Lavoro in una Regione, le Marche, dove un famoso industriale locale ha
appena donato una splendida scuola al Comune dove risiede e dove è collocata
la sede centrale della sua fabbrica di scarpe, per altro nota e
delocalizzata in tutto il mondo.
Ha ovviamente scatenato dissensi e consensi. Ma uso ciò come esempio
eclatante per dire che il termine “comunità locale” implica anche la
“società civile”, il tessuto produttivo e quello degli “interessi locali”
che muovono l’economia, il mercato, gli scambi.
So che per alcuni, pregiudizialmente, il mondo dell’impresa sarebbe popolato
da “tagliagole”. Ma basterebbe leggere “davvero” Adam Smith, il “teorico
fondamentale” del mercato, per rendersi conto che, per “il filosofo morale”
che egli era, il mercato stesso funziona solo “a partire” da un comune
riconoscimento di regole condivise, di valori comuni, di etica unificante, a
monte del mercato stesso.
Il noto industriale marchigiano ha i suoi “interessi” che lo muovono ad
offrire una nuova scuola alla cittadinanza? Ovvio. Ma diamo credito che egli
possa muovere da quel set di valori che il teorico del mercato riteneva
essenziali per lo stesso funzionamento del mercato, e diamo fiducia ai
cittadini non solo di comprendere ciò, ma anche di sapere come “ricomporre”
gli interessi loro e del “capitalista” locale.
All’impresa, come parte essenziale della società civile e della sua dinamica
non dobbiamo chiedere di astenersi di intervenire su questioni che
riguardano il “bene comune”, ma al contrario è necessario chiedere di
intervenire e dedicare ad esso risorse corrispondenti a ciò che “prelevano”
dall’ambiente circostante (risorse ambientali, umane, culturali, il“capitale
sociale” appunto). Sarà la “politica” (quella vera) a ricomporre
sensatamente gli interessi ed i conflitti che tali interventi suscitano.
Non si può lasciare l’impresa nella comoda condizione di considerare il
livello di istruzione come una “esternalità” positiva rispetto ai suoi
interessi, lasciando che i costi di tale esternalità siano delegati alla
collettività, in nome di una (supposta) superiorità e “indipendenza”
dell’interesse pubblico.
Anche l’impresa e la società civile concorrono alla formazione del “capitale
sociale” che costituisce la “ricchezza collettiva” di una comunità locale e
nel quale la scuola ha tanta parte (si pensi alla esperienza storica di
Olivetti).
Se è così dove sta lo scandalo a pensare di “coinvolgere” questi “interessi”
nella vita della scuola? Non si tratta di “consigli di amministrazione” come
vorrebbe qualcuno (che è “privatista e statalista” insieme), ma neppure di
elevare muri di protezione da interessi considerati aprioristicamente come
deteriori e “dominanti”, da tenere lontani perché “inquinanti”. La società
civile è l’acqua dove nuota il cittadino e esprime interessi e bisogni e
valori comuni (diritti); lo Stato è “l’intelaiatura” che ricompone tali
interessi, non il soggetto “etico” che si sovrappone ad essi.
6.
Nel mio “racconto” ho una riprova di ciò che sto
sostenendo. I tanti chilometri percorsi mi hanno portato, in Calabria, in
una scuola collocata nel centro dell’area “albanese”. (I protagonisti si
riconosceranno, ma non ho prudenze da privacy, perché ho solo notazioni
positive). Pochi chilometri di distanza da una situazione di degrado
ambientale come quelle descritte più sopra.
Un piccolo paese con il monumento a Scandenberg nella piazza centrale e con
tanto di dedica di Henver Hocha (?!). Per la verità e per fortuna in parte
occultata dai fiori dell’aiuola che vi cresce intorno. (Anche questa è
l’Italia).
Bene, a pochi chilometri dal degrado ho trovato una scuola con la massima
cura per gli ambienti, le pareti colorate, in un pomeriggio “fuori orario”
la docente di arte che affrescava una parete insieme ai suoi studenti, una
comunità che tra feste in piazza, pubblicazioni dei ragazzini in “albanese”
(lo parlano tutti, insieme all’italiano, dagli insegnanti ai bambini e ai
loro genitori), guarda alla “sua” scuola come ad un elemento essenziale del
“suo” patrimonio comune.
Comune ai vecchi che chiacchierano in piazza nella loro variante dialettale
di “albanesi”, e comune ai nuovi immigrati (numerosissimi) dalla pelle di
diverso colore. Un bene “proprio” ed universale insieme.
Pochi chilometri ma una radicale diversità di collocazione della scuola
nella società civile e nella preoccupazione delle classi politiche locali.
Una scuola “di Stato” comunque. E i “numeri” dei risultati rilevati stanno
lì a supportare le notazioni empiriche con il conforto di una “quasi”
dimostrazione.
Ovviamente non scambio il “cannocchiale” con il “microscopio”. Non voglio
generalizzare il valore di esperienze “specifiche”. Ma credo che serva
ribadire il concetto: tra le tante variabili che danno conto della
disomogeneità dei dati relativi ai risultati della scuola, a fronte della
omogeneità delle regole e delle norme, quella fondamentale è la cura che la
comunità locale dedica alla costruzione di ambienti adeguati
all’apprendimento, al loro miglioramento, alla efficacia del loro uso,
all’investimento necessario a farla considerare “bene comune”, “bene
pubblico” del quale tutti debbono prendersi cura, prima di tutto non perché
sono “buoni cittadini” ma perché è loro interesse farlo, diventando, per
questa via, anche buoni cittadini. E questo non tocca allo “Stato lontano”
cui spettano le regole generali e “uguali per tutti”. Ma tocca alla
“democrazia vicina” quella che è direttamente controllabile dai cittadini
che esercitano i loro diritti, lì dove essi diventano “bisogni e interessi
determinati” e quotidiani.
Racconto infine
un’ultima esperienza, già raccontata altrove, lasciando al lettore di
completare il senso del link.
Ultimi esami di Stato, come sempre soggetti al controllo dell’ispettore. Una
commissione in un Istituto Tecnico dei servizi turistici. Un candidato che
aveva appena risposto positivamente al compito di illustrare una possibile
campagna di marketing per una ipotetica agenzia turistica. Fatica nel
colloquio di Italiano. La Commissaria, un poco esasperata gli chiede
recisamente: “Ma insomma che fine ha fatto Fra Cristoforo?”. Il
candidato esita e poi conclude la faticosa riflessione con un “Beh,
speriamo che se la sia cavata bene…”. Ho faticato non poco a non
scoppiare a ridere per (l’involontaria?) ironia della risposta.
La Commissaria, a parte e dopo il colloquio, si sfoga con me “Così
finiscono per perdere anche la loro identità culturale!!”. Ho faticato
non poco a non risponderle “L’identità di chi?”.