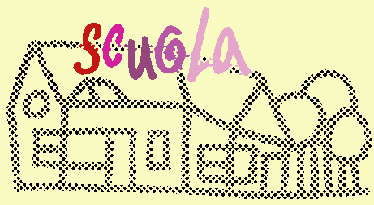 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
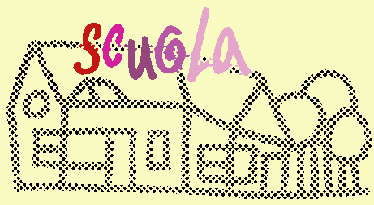 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
(07.02.2009)
Sofferenza teletrasmessa
Quando ero alle medie inferiori - tanti, troppi anni fa - mi insegnavano quotidianamente i meccanismi della democrazia, le prerogative del Presidente e del Governo, le differenze tra Camera e Senato, l'iter di una legge e, soprattutto, leggevamo la Costituzione con attenzione, non mancando di notare come tutti i suoi principi fossero stati sistematicamente disattesi. Era qualcosa di più di una lezione di Educazione Civica: si trattava di una sfida, quella di una scuola di periferia molto problematica impegnata otto ore al giorno nel formare i cittadini di domani. Una scuola sperimentale, che sicuramente ha penalizzato i suoi utenti sul piano dello studio tradizionale, promuovendoli tuttavia su quello della maturità personale. E così, quando sono passato al liceo, sapevo tutto sui meccanismi della politica, sulla forza dei sindacati, sulla divisione dei poteri, sulla laicità delle istituzioni, sulla Resistenza, la strategia della tensione, la ristrutturazione capitalistica, ma molto poco sui minimi comuni denominatori, l'analisi logica e la storia antica. L'educazione civica era lo sfondo sul quale si stagliavano le lezioni tradizionali, che spesso si trasformavano in discussioni. Conoscevamo tutti a memoria il testo della canzone di Giorgio Gaber, La libertà: “libertà non è star sopra un albero, non è neanche un volo di un moscone; la libertà non è uno spazio libero: libertà è partecipazione!”.
Fare politica, per una schiera di giovani destinati a seguire le orme dei loro padri, e dunque a divenire presto, troppo presto, operai generici, sottoproletari o disoccupati, faceva sentire grandi, pronti al grande salto nella società. Nel nostro piccolo “parlamento”, la IIIA, si discuteva di tutto: dalla questione operaia (erano gli anni delle prime ristrutturazioni) al terrorismo (il nostro quartiere era uno dei più colpiti di Milano: l'anno prima era stato ucciso il gioielliere Torregiani), passando per la crisi economica (il secondo shock petrolifero) e la rivoluzione nicaraguense. E poi l'aborto. Si era alla vigilia di una consultazione che divideva profondamente la società. Ricordo gli inviti del professore di religione - sacerdote della vicina parrocchia, area di aggregazione per la generazione ribelle degli anni passati e futuro parcheggio per quella disperata degli anni seguenti - i suoi inviti a ragionare “secondo coscienza”, senza farsi prendere troppo dalle passioni, non mancando mai di ricordare ai suoi giovani uditori come dovere di uno Stato fosse quello di tutelare la salute dei propri cittadini. Molti di noi interpretarono quelle parole come una implicita difesa della legge sull'aborto, dunque una sconfessione del Vaticano, e la cosa ci colpì molto. E tuttavia, grazie alla formazione ricevuta, sapevamo anche che sui diritti civili gli schieramenti politici hanno poco senso: si ragiona secondo una coscienza che dovrebbe impedire a chi ha una propria morale di imporla ad altri, men che meno per legge. E poi - ci chiedevamo - che cosa accadeva quando l'aborto era illegale?
I giornali degli anni passati, ben conservati nella biblioteca della scuola, ci fornivano la risposta: chi se lo poteva permettere andava all'estero o in cliniche private, mentre per le altre, la maggioranza, non rimanevano che i vecchi ferri del mestiere. Fu in quella occasione che venimmo a conoscenza dello stupro di gruppo subito da Franca Rame (molto conosciuta da tutti noi: erano gli anni di “Mistero Buffo” in prima serata Rai): i colpevoli erano i fascisti, da sempre fautori della pena di morte eppure ora schierati con il Vaticano per la difesa dell'embrione.
Discutere di queste problematiche era cosa molto delicata. Guardando negli occhi alcuni compagni e compagne si capiva che si stava parlando di cose che li riguardavano direttamente: le mammane, il prezzemolo e il cucchiaio erano termini che per loro assumevano un particolare significato. Ma nessuno di noi, nemmeno i più accesi difensori della vita, si sarebbe mai sognato di mettere in piazza le proprie esperienze o di sfruttare drammi personali a fini politici. La sofferenza era un fatto privato, non qualcosa da sbattere in faccia all'avversario per conquistare il plauso dell'auditorio. E nessuno, nemmeno i fautori di un governo forte, che pure non mancavano in quel piccolo parlamento, si sarebbe mai sognato di proporre l'emanazione di un decreto, men che meno di appellarsi alle masse, che sapeva tanto di regime sudamericano (il nostro professore di matematica era un esule argentino).
Che il mondo stesse cambiando lo capimmo poche settimane dopo, con l'agonia di un bambino finito in un pozzo a Vermicino, Alfredino Rampi. La Rai organizzò una diretta di quasi ventiquattro ore: un dramma privato trasformato in spettacolo ad uso e consumo dei telespettatori, con ripetute incursioni nei meandri più nascosti della vita della famiglia, dubbi, domande senza risposta, un macabro voyerismo. La mattina, di fronte agli occhi stanchi ed arrossati dei suoi studenti, il prof di religione pronunciò più o meno queste parole (sono passati molti anni, troppi per ricordare tutto il discorso): “Apprezzo la vostra vicinanza al dramma che si è consumato. E tuttavia non posso fare a meno di notare come non avete versato una lacrima la scorsa settimana per i bambini morti durante un bombardamento in Libano. D'altro canto, non c'erano telecamere a riprendere l'avvenimento. Ma sapete sicuramente quanti bambini muoiono di fame ogni giorno nell'indifferenza generale eppure non versate lacrime quotidiane. Attenzione, perché dietro la cortina fumogena della sofferenza teletrasmessa - disse proprio così: sofferenza teletrasmessa! - c'è sempre qualcuno che ha altri obiettivi. Vi invito al silenzio, l'unico modo per riunire in un solo abbraccio tutti coloro che soffrono e sfuggire alle sollecitazioni di chi specula”.