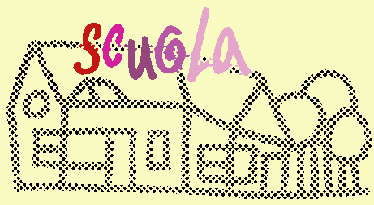(10.05.2009)
Siccome (im)mobile... - di Marina Boscaino
Quello
dell’insegnante è un lavoro che brucia i tempi, che scansiona i mesi e li
contrae, li rattrappisce in scadenze obbligate; che strizza la dimensione del
tempo, nell’eterna proiezione verso un futuro, più o meno immediato: la prossima
verifica, il prossimo collegio, la fine del quadrimestre, ce la faccio ad
arrivare al fratello Giovanni (quello di Foscolo)? Manca meno di un mese alla
fine delle lezioni, e devo ancora iniziare Alfieri, lì
Lucrezio, lì ho letto poche novelle di Boccaccio, ma sarebbe opportuno
cominciare già l’umanesimo latino; altrimenti, in terza, con il Novecento, come
la mettiamo?
Si tratta
di una corsa irrefrenabile, che consuma giorni, mesi, stagioni; che vede –
comunque – il traguardo (traguardo?) raggiunto sempre in affanno. Misurata sulla
ciclicità degli impegni - episodi di una liturgia immutabile - e sulla scansione
dei contenuti: dove stai in terza con letteratura italiana? È la domanda più
ricorrente tra colleghi (non “come te la passi, come va la vita”), in quella
sorta di linguaggio cifrato-lessico familiare che rappresenta spesso l’unica
reale condivisione nelle spire di un’autoreferenzialità sempre più triste e
disorientata. E la speranza è quasi sempre quella di sentirsi dare una risposta
che metta a tacere i tuoi dubbi, le perplessità – che aumentano di anno in anno
– su quello che stai facendo. E
su
come lo stai facendo. Sul senso.
Ogni volta
a settembre ti pare di avere avanti un tempo infinito, infinite potenzialità,
infinito disagio da macerare; una montagna insormontabile o un progetto
stimolante (a seconda degli stati d’animo). Poi tutto scorre rapidissimo: si
sale su una giostra che in un batter d’occhio ti sbalza all’estate, nuovi
scrutini, nuovi esami, altri alunni da salutare.
Tra
sollievo e perplessità – a volte dispiacere -
li
accompagni con lo sguardo fuori dalla porta dell’ultimo colloquio, a luglio,
e
non saprai mai, veramente, fino a che punto sia servito. Se ne è valsa realmente
la pena. Persone che per tre anni hai visto ogni giorno, che per tre anni ti
hanno dovuto considerare – nel bene e nel male – una parte importante della
propria vita, disperse in un momento, assieme al voto che le accompagnerà come
un bollino di marca. Tentare di lasciare una traccia realmente significativa è
sempre più un gioco d’azzardo. Verificare il senso di ciò che è significativo –
i mille rivoli in cui può disperdersi questo significato – un esercizio ricco di
incognite. E a volte di sorprese sgradevoli.
Metà maggio: documento del consiglio di classe. Questo nome non dirà niente ai più, anche tra gli insegnanti. Ma per coloro che lavorano nel triennio della scuola superiore, si tratta di uno dei momenti-clou del percorso intrapreso con la classe terminale. È il documento attraverso il quale si esplicitano “i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”, come recita il DPR 232/98 che lo norma. Attraverso il documento, inoltre, si creano per la Commissione esaminatrice dell’Esame di Stato un orientamento e un vincolo, definendosi in quella sede “struttura” e “testo” della terza prova scritta e i criteri per la conduzione del colloquio.
Ogni volta
stesse facce, stesse procedure, ripetute stancamente di anno in anno: la
“storia” della classe, dal IV ginnasio al III liceo. Le
pratiche
didattiche, i criteri di valutazione, le esperienze. Il giudizio sulla classe.
Ricordate il
film “La scuola” di Daniele Luchetti oppure
"Auguri
professore" di Riccardo Milani? Buoni e cattivi di una speciale recita
a soggetto, dove ciascuno cerca una sua collocazione, una propria identità, una
propria essenza decifrabile in quella dimensione particolarissima che inizia e
finisce varcando il portone di un edificio familiare: la scuola, appunto. Fuori
la vita; dentro la scuola. La frattura, ormai, è tanto più netta quanto più la
ritualità, la burocrazia, la reiterazione di gesti, atti, dichiarazioni si
ripetono, in una sorta di pedissequo eterno ritorno. Che tende alla
spersonalizzazione, all’immobilità, alla ripetizione: come se quelli di cui
dovessimo raccontare la “storia”, quei visi di diciannovenni che ci passano
davanti agli occhi tutti gli anni
a gruppi di 24-25, fossero
le
facce di un’identica medaglia. Da comprimere, etichettare, racchiudere nelle
scabre formule del “documento del consiglio di classe”. Il paradosso è quello
dell’identikit spersonalizzato: una classe è un’entità del tutto teorica. Nel
tentativo di definirla si perdono fisiologicamente identità, sorrisi,
fallimenti, bronci, progressi, maleducazioni, simpatie; l’intuizione del perché,
il barlume di genialità, curiosità, apatia, la sigaretta fumata prima di
entrare. Si perdono loro. Rimangono fogli, testimonianza della mortificazione
del senso, soppiantato dalla costrizione a un destino sconsolato e imposto
da superficiali amanuensi.
Non
c’è la classe, in quel documento. Non esistono mai lì dentro indicazioni che
possano essere realmente utili per i nuovi esaminatori. Esiste solo lo stanco
esercizio della burocrazia che congela anno dopo anno il nostro lavoro.
Ognuno di noi si presenta
all’appuntamento obbligato con la propria vocazione “a prescindere”:
l’indulgente, il severo, il disinteressato, il frettoloso, il puntiglioso, il
giusto - ricordate Vivaldi, Sperone, Mortillaro, Majello? in chi vi
identificate?. Con un occhio al coordinatore che legge la sua relazione e uno
all’orologio, tra la battuta di qualcuno, il richiamo all’ordine di qualcun
altro, lo sbadiglio trattenuto, l’intransigenza sulla pregnanza di ogni singola
parola. Riunioni, riunioni, riunioni, nella perdita progressiva del rapporto di
necessità tra la realtà – quella della classe, delle classi; e quella fuori – e
la loro liturgica scansione, le loro rituali procedure. Una settimana dopo,
consigli di classe per l’adozione dei libri di testo.
Strano
modo di interpretare la collegialità, quello della nostra scuola superiore. La
collegialità: una parola bella e nobile, che sa di democrazia, che sa di
partecipazione, di responsabilità; mortificata ad una dimensione imposta, non
desiderata, non auspicata. Localizzata negli spazi asfittici di riunioni
obbligate da
un calendario svincolato dall’accoglienza di esigenze che – qualora alla scuola
fosse stato realmente concesso di rappresentare un luogo di ricerca, sviluppo e
sperimentazione – sarebbero state ben più pressanti e incomprimibili
nell’insensato recinto di un rituale burocratico. Un affaccendamento inoperoso
che sottrae buonumore, energie, passione. Stiamo diligentemente portando a
compimento un altro anno di lavoro: compilando, con pazienza certosina, le
sudate carte (non quelle
di Leopardi!) . Imperturbata, identica a se stessa, sempre più
autoreferenziale, immobilizzata nelle sterili pratiche di un falso movimento: la
scuola è morta. Viva la scuola!