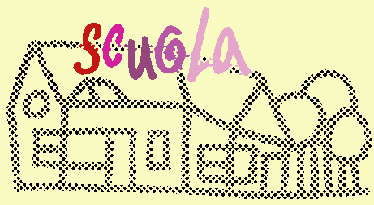(27.04.2009)
Gli indifferenti - di Marina Boscaino
Una sorta di forza inerziale – senza un volto preciso, ma dalle tante facce
note; senza una finalità espressa, ma con scopi che sotto sotto sono evidenti –
ha prima trasformato un’operazione importante e civilmente significativa (che
aveva connotato la campagna elettorale del centro sinistra) come l’innalzamento
dell’obbligo scolastico a 16 anni in una sorta di commedia all’italiana, con
tanto di equivoci, ambiguità, colpi
di scena, risate amare sui vizi e le virtù del nostro Paese. Poi ha consentito
al governo attuale di mettere una definitiva pietra tombale sul provvedimento.
Partiamo da una constatazione abbastanza banale, eppure non irrilevante: nessuno
– nemmeno gli insegnanti per certi versi – in questo paese si è realmente reso
conto di cosa potessero significare 2 anni di istruzione in più per tutti.
Aggiungiamone un’altra: tra alcuni insegnanti, l’operazione è stata considerata
con una certa vena di sospetto: lavoro in più, gatte da pelare, programmi
rallentati, sforzo per il potenziamento della relazione educativa. Insomma, una
gran fatica. Mettiamoci poi gli insegnanti dei bienni del liceo: caratterizzati
spesso da un elitarismo che ha fatto loro erroneamente ritenere di essere esenti
da qualunque impegno in questo senso. Il risultato di un’operazione condotta
politicamente in modo pedestre è stata l’indifferenza.
Nessuno si è impegnato a preparare gli insegnanti (e la società) rispetto alle
ricadute in termini di civiltà che avrebbe potuto avere. Non si sarebbe
semplicemente trattato della necessità di omologazione dell’Italia, fanalino di
coda – per quanto ragionevole e necessaria - ai parametri europei (quasi tutti i
paesi hanno l’obbligo a 16, se non a 18 anni); ma avrebbe significato
innanzitutto innalzare mediamente standard di coscienza critica, di senso di
cittadinanza, di autonomia ed emancipazione nei futuri cittadini; in secondo
luogo, fatto non meno importante, avrebbe potuto significare liberare la scuola
media dalla cavezza della "terminalità", che ne ha compresso didattica,
funzione, efficacia e l’ha resa l’anello più debole della catena del sistema
dell’istruzione italiano.
In un paese normale, che avesse davvero a cuore progresso e futuro, tutto ciò
avrebbe rappresentato motivo di orgogliosa e diffusa partecipazione civile e
politica ad un progetto che sarebbe stato percepito come riguardante –
direttamente o indirettamente -
tutta la cittadinanza attiva. Invece, una stupefacente sordina. Nonostante la
legge del 27 dicembre 2006 (la Finanziaria) ai commi 622 e 624 prevedesse
l’innalzamento dell’obbligo di istruzione fino a 16 anni, solo all’inizio dello
scorso anno scolastico dal ministero si sono ricordati di divulgare la novità:
furono giorni di fanfare medianiche, di annunci che non hanno spiegato nulla, se
non dato la notizia, peraltro parziale. Perché uno dei motivi della resistenza e
della reticenza a divulgare in maniera ragionevolmente diffusa e capillare la
notizia fu l’enorme dissenso su una parte non irrilevante della legge: si
parlava di obbligo di istruzione e non scolastico perché quell’obbligo poteva
essere assolto anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale; in via transitoria e “per prevenire” il fenomeno della
dispersione. E questa “soluzione” - da sola - parlava chiaramente di quanto
l’emergenza della dispersione fosse chiaramente sottostimata. E parlava della
disinvoltura con cui si rubricavano cittadini di serie A e cittadini di serie B,
nonostante l’art. 3 della Costituzione.
Chiunque è in grado di capire la differenza tra l’andare a scuola e andare ad
imparare un mestiere. Si tratta di due modalità ben diverse di vivere quei due
anni e di presentarsi alla vita futura. Il dissenso all’interno dell’allora
maggioranza, e poi nel sindacato e tra le associazioni professionali, rispetto a
quella grave deviazione al criterio di obbligo scolastico è stato grande.
Comunque, fu tutto un affare di famiglia. Riservato non agli addetti ai lavori
in senso stretto (che sarebbero stati gli insegnanti); ma alla politica, che
riduceva a merce di scambio un principio di civiltà altrove – quasi ovunque -
inattaccabile, indiscutibile e sancito da decenni.
Si dovette fare i conti con il fatto che con quei percorsi mangiano tanti
lavoratori (che avrebbero potuto, però, essere riconvertiti); e che sul
mantenimento della loro esistenza avevano e hanno precisi interessi partiti e
sindacati stessi, anche all’interno della maggioranza. Dire “il re è nudo” è
oggi un inutile esercizio di senso civico – che non scandalizza né preoccupa più
nessuno - tanto consolidati ormai
sono meccanismi e automatismi. Il braccio di ferro si è concluso con un nulla di
fatto: il decreto sull’innalzamento dell’obbligo ha previsto che (art.5,
“possono essere realizzati, per gli anni 2007-8 e 2008-9 percorsi e progetti
sperimentali per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché per
favorire il successo formativo dei giovani (…)”.
È cambiato il governo e le cose sono ulteriormente peggiorate: un emendamento al
decreto 112 (luglio 2008) ha deliberato che “si può assolvere l'obbligo
scolastico anche nel sistema regionale della formazione professionale e nei
percorsi triennali” istituiti dal ministro Moratti, che escono dalla
sperimentalismo per diventare definitivi. Dunque il nostro Paese ha deciso che
scuola o non scuola è lo stesso, istituzionalizzando una sinonimia pericolosa e
ambigua: scolastico e di istruzione (che prevede la formazione professionale).
Inutile insistere su argomentazioni ormai demodé: il dettato costituzionale
contempera l'assolvimento dell'obbligo scolastico nel solo sistema scolastico,
che comprende le scuole statali e
paritarie. Di questi tempi, si sa, la Costituzione è un optional.
Insomma, è passata definitivamente l’idea che, come nel caso del
recupero, la scuola deve alzare le mani e arrendersi:
non è quello il luogo deputato a provvedere al recupero delle criticità
di apprendimento, comportamento, relazione ecc; un vero e proprio paradosso.
Quando Fioroni diceva di non poter tenere i ragazzi a scuola “con le catene”, in
fondo, aveva ragione: perché non basta dire “innalzamento dell’obbligo” per
inverare le condizioni affinché questo provvedimento spieghi i suoi effetti. La
scuola così com’è non è in grado di gestire l’esistente; figuriamoci di
assorbire, motivare e mantenere in sé la dispersione.
L’operazione veramente criminale è stata linguistica, prima ancora che politica:
inflazionando la formula si è resa di fatto impraticabile la sostanza. Imponendo
il provvedimento in maniera rocambolesca e improvvisata, si è lusingata la
coscienza democratica e inclusiva di alcuni; ma al contempo si è provveduto a
dimostrare definitivamente l’impraticabilità dell’iniziativa. L’improvvisazione,
la mancanza di professionalità nel preparare il terreno ad un provvedimento
rivoluzionario, il dilettantismo nella proposizione, nella gestione,
nell’abbandono del progetto hanno ad una prima lettura dimostrato
l’impossibilità dell’innalzamento. Più realisticamente e analiticamente hanno
consentito l’affermarsi permanente di un progetto di scuola di selezione, di
disinvestimento trasversale sulla possibilità di costruzione di modelli
didattico-relazionali-organizzativi nuovi, in grado veramente di tenere a scuola
tutti, e non con le catene; preparando l’indisturbata castrazione da parte del
centro destra di qualsiasi velleità di realizzazione.
E pensare che ancora qualcuno parla di biennio unitario. Basta dare uno sguardo
alle bozze relative alle superiori di Gelmini: bienni schizofrenici, in cui ogni
possibilità di passerella, di ri-orientamento è programmaticamente annullata;
un’istruzione professionale sempre più ghettizzata, dove la scuola è sempre più
assente, sempre più destino obbligato per gli sfigati. Degli insegnanti che ci
hanno creduto non ha parlato nessuno. Sono tra quelli che
in molti collegi docenti del nostro paese tirano avanti la
carretta, per puro senso di responsabilità, spirito civico, cultura politica.
Dei quali i nostri governanti continuano ad approfittare in maniera
spregiudicata, non ponendo seriamente il problema sostanziale di una
riqualificazione della professione docente. Gli altri hanno continuato a
galleggiare, tra scetticismi e imboscate, dando agio a Brunetta e company di
continuare a formulare fantasiosi identikit dell’insegnante fannullone.
Favorendo la peggiore conclusione di tutta questa storia: che un’innovazione di
progresso e crescita culturale, etica e civile del paese come l’innalzamento
dell’obbligo sia diventata definitivamente una scommessa persa. E alimentando
sempre più quel circolo vizioso che continua a farci chiedere se nasca prima
l’uovo o la gallina: ossia se la scuola sia quella che è perché questo è il
livello degli insegnanti; o viceversa. E se gli insegnanti sono così perché il
mondo è cambiato o viceversa. Ma in fondo sono questioni di lana caprina.
Quello che conta, ancora una volta, è il motto
araldico che dovrebbe essere scritto a caratteri inconfondibili sul portone di
ogni scuola: “Bambole, non c’è una lira”. Vedete un po’ come riuscite a
organizzarvi. Vi diamo una mano noi, con il voto in condotta, la finta serietà,
il randello nelle mani di chi ne aveva bisogno per ribadire autorità, non avendo
autorevolezza. Nulla è cambiato, dunque. Casomai, si sono rafforzate delle
certezze; prima tra tutti la rassicurante (per molti) conferma che la scuola
deve selezionare non emancipare.