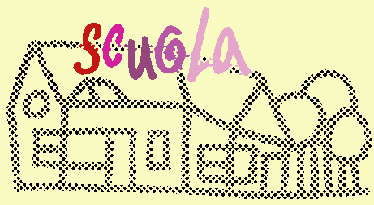 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |

01.08.2003
I bienni integrati
istruzione/formazione professionale
Le intenzioni sono buone, ma la scuola reale è altra cosa....
di Andrea Bagni
La strada indicata dal recente accordo fra stato e regioni riguardo la realizzazione di un biennio integrato di istruzione e formazione professionale e liceale, è senz'altro costellata di buone intenzioni. Prima fra tutte, quella di ovviare alla scomparsa di un anno di obbligo scolastico indotta dall'improvvisata abrogazione della legge 30. Tuttavia l'obiettivo più significativo politicamente è rendere meno drastica la separazione a 14 anni fra i due canali dell'istruzione liceale e professionale. Si potrebbe dire meno "classista". L'intreccio fra i percorsi dovrebbe garantire riduzione degli insuccerssi e una funzione orientativa al biennio della secondaria, offrendo una serie di "assaggi" di esperienze diverse. Si costruisce, infatti, a questo fine un sistema coerente di titoli, crediti, certificazioni (con le procedure di attribuzione, gli enti accreditati ecc.), per permettere rientri riconoscimenti Competence-card ecc.
C'è anche consapevolezza dell'importanza di evitare che il secondo canale diventi una serie B per lo scarico degli studenti indesiderati nelle stanze buone dei licei... Allora si discute di come definire con precisione competenze, crediti corrispondenti ed equivalenti (certi, sottratti all'arbitrio di giudizi scolastici) fra i percorsi professionalizzanti e quelli scolastici tradizionali. Insomma la "parità di valore" fra i diversi percorsi deve essere garantita a priori, istituzionalmente.
Solo che non funziona. Nella scuola reale un progetto del genere è destinato a restare del tutto astratto, un mondo a parte. E delle buone intenzioni, peraltro, è lastricato l'inferno... Infatti un tale impianto d'intervento non solo rischia di essere assolutamente "virtuale", dotato di senso solo per chi della scuola vera e propria non sa quasi niente, ma addirittura può facilmente portare ad un "aggravamento del danno".
Anche nel documento Bertagna si afferma con forza che non c'è nessuna intenzione di costruire una scuola di serie B: anzi si spendono belle parole per affermare la "pari dignità" fra i diversi rami scolastici (esaltando la cultura del lavoro e l'apprendimento attraverso l'esperienza e la pratica). Ma il punto è proprio la qualità del sapere che attraversa la scuola, non le dichiarazioni di principio o le carte d'intenti. È la questione del sapere che andrebbe posta – ma di nuovo, non a livello astratto. Il sapere nasce in una interazione fra soggetti che s'incontrano con le loro storie e i loro desideri, le attese e i progetti; non è un prodotto già confezionato da trasmettere (e non lo è comunque: lo scambio, materiale immaginario e simbolico, fra coloro che vivono la scuola lo segna e lo qualifica); il discorso sulla qualità del sapere è allora discorso sulle relazioni che lo qualificano.
Di questa riflessione di epistemologia e di scuola non si vede alcuna traccia e questo rischia di vanificare ogni buona intenzione. Che cosa significa per la scuola parlare di un sapere di base; di una formazione comune e di cittadinanza; di una costruzione di autonomia critica personale (senza la quale le scelte succesisve di vita non sono tali, ma solo destini sociali mascherati da attitudini naturali)? Sembra che l'integrazione fra percorsi diversi per alcuni studenti salvi di per sé dal rischio della discriminazione, come tutto il problema fosse di separazione fisica di istituti e giovani e non soprattutto di qualità dei saperi e dei percorsi che li connotano. Insomma se la questione di una gerarchia (non solo separazione) dei saperi non è risolta, il rischio dell'esclusione (in mezzo agli altri/e magari) si può addirittura aggravare.
Perché la questione del sapere non è solo organizzativa o epistemologica, ha a che vedere con le attese, le rappresentazioni simboliche, gli orizzonti di senso, che istituzione e "abitanti" della scuola producono.
In altri termini, come viene vissuto (oltre che progettato) e dunque "agito", un percorso formativo incontrato a 14 anni, che non è aperto gratuito disinteressato, ma finalizzato (magari "in subordine") a consegnare una qualifica immediatamente spendibile sul mercato del lavoro? La dimensione pratica ed operativa del conoscere quanta possibilità ha in questo contesto di essere davvero teorica, una forma dell'apprendimento per ipotesi e verifiche, tentativi ed errori; di essere formativa della persona (del suo "progetto di vita") o del cittadino/a, e quanto invece non sarà – proprio dal quadro complessivo e dalle attese soggettive (autorelizzantesi) - piegata ad una dimensione più o meno addestrativa?
C'è una questione di relazionalità del fare scuola.
Non solo i progetti "democratici" di integrazione sono condannati ad operare a partire da un paradigma teorico di tipo ingegneristico (moduli, progettazione di competenze predefinite, crediti, certificazioni, componibilità dei percorsi ecc.) ma non vedono la dimensione interpersonale del fare scuola. Nel gruppo classe, magari del prestigioso liceo, l'essere avviati a un persorso integrato – con l'obiettivo "subordinato" di imparare un mestiere - rischia di etichettare definitivamente un ragazzo o una ragazza, e in un momento delicatissimo della sua formazione e della sua vita; la sua scuola cesserebbe di rappresentare una storia comune di costruzione di sapere su di sé e sul mondo, per essere (anche se solo parzialmente) separata, simbolicamente separante: altri i ritmi, i luoghi e le relazioni personali di una formazione che allargherebbe l'area (spesso drammatica dentro) dei "non fatti per studiare", di quelli e quelle che avrebbero dalla nascita la vocazionea al lavoro....
(Forse il discorso andrebbe rovesciato: dopo il biennio comune – orientante ma non prefigurante – nel quale l'esperienza, l'esperimento, la pratica sono altre forme ed approcci della conoscenza, non un'altra prospettiva di percorso cioè di vita, gli scambi e i passaggi integrativi potrebbero risultare consapevoli e non predestinati...).
Una formazione che avrà da subito un altro orizzonte di senso e una diversa "strumentalità" delle conoscenze (l'uscire con una "qualifica", un sapere da usare subito, spendibile sul mercato); che rischia di avere un altro vissuto soggettivo e intersoggettivo (quello l'hanno già classificato, piano piano lo mandano a fare qualcos'altro), è di fatto già di un altro livello, subordinato, fatto per i "sommersi", quelli che escono con sufficiente dalle medie e della "classe dirigente" non faranno parte mai (ma i riformatori gli spiegheranno che non ci sono più classi dirigenti...).
Che fare dunque ?
Intanto difendere il ruolo degli organi collegiali e dell'autonomia scolastica, non per moltiplicare ingegnerie organizzative e modelli di scuola, ma per ricondurre una materia - tutta sotttratta a chi ha davvero esperienza della scuola reale - alle questioni delicate, teoriche e relazionali, del fare scuola quotidiano. Cioè rivendicare le procedure politiche e culturali della democrazia degli organi collegiali (per quanto in crisi, da non avvilire con un compito di mera ratifica di decisioni prese altrove da altri, per altre ragioni che la didattica).
E certo limitare il danno della riforma Moratti. Fare il meglio possibile tutti i percorsi di scuola, con l'obiettivo di non allontanare nessuno da nessuna aula, da nessuna forma del conoscere (scriveva un alunno di don Milani dall'Inghilterra: qui non bocciano nessuno, semplicemente a qualcuno insegnano l'inglese a qualcun altro il cockney). E allora riportare al centro della riflessione il tema della motivazione, dei desideri e del "piacere" del sapere, non come una vocazione biologica ma come costruzione sociale e culturale; personalizzare e articolare il più possibile il fare scuola (per tutti/e: non solo libresco, non solo astratto, non solo trasmissivo), ma non nel senso di dare "a ogni piede la sua scarpa": le teste (e i cuori) vivono dinamiche e seguono mappe un po' più ricche e articolate delle piante dei piedi...
Per cominciare sarebbe bene non "raccontarsi" come risolto attraverso la parola magica dell'integrazione il chiaro disegno di esclusione del governo Berlusconi, che resta tale per la scuola anche se svolto in condizioni di contiguità, in ambienti ravvicinati e intrecciati. Alla fine altrimenti il problema – negato, dunque reso invisibile – potrebbe davvero risultare irrisolvibile: tratto culturale comune tragicamente bipartisan, di un pensare la scuola immiserito, tecnicizzato e rassegnato rispetto a precondizioni sociali tornate destino naturale.
Invece la formazione, in particolare fino a sedici anni, ha senso democratico e perfino economico (nella società della conoscenza messa al lavoro e in continua trasformazione del postfordismo) solo se è costruzione di un sapere comune, di base, di autonomia e creatività, non immediatamente professionalizzante (su cui articolare il conoscere successivo di tutta la vita); soprattutto in questo mondo di biografie aperte e di lavoro incerto, mobile, precario. Postmoderno.
È bene che almeno la sinistra continui a dirlo con forza.