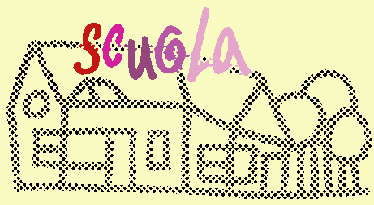 |
PavoneRisorse |
07.02.2015
Il "buon senso" (o il pressapochismo?) del voto
numerico
Perché aderisco all’iniziativa per l’abolizione del
voto numerico nel primo ciclo
di Franco De Anna
Mi sarei volentieri limitato alla adesione. Ma gli amici di Pavonerisorse mi chiedono con grande gentilezza di dare un contributo ulteriore dichiarando le motivazioni della adesione. E qui cominciano i problemi (i guai?).
Quando una assai poco rimpianta ministra
della pubblica istruzione decise di “tornare” al voto numerico, mi colpirono,
guardando ai provvedimenti presi, alle loro “ragioni” ed alle reazioni
suscitate, tre cose sostanziali.
La prima era il corredo di motivazioni “di senso comune”che li accompagnava. In
buona sostanza un generale richiamo alla “serietà”, alla necessaria “severità”
del valutare, alla “significatività sintetica” del numerico, alla chiarezza e
semplicità di comunicazione con le famiglie. “Almeno ci faremo capire senza
equivoci: un cinque è un cinque, un sette è un sette…”.
A tale repertorio di senso comune si allinearono allora e prestamente molti
degli strumenti della comunicazione di massa: il messaggio generalizzato fu che
si tornava ad “essere seri e giustamente rigorosi…”. Basta con il lassismo del
“tutti promossi”.
La seconda (silenziosa e perplessa) notazione fu che, in particolare nei documenti di accompagnamento ai provvedimenti normativi (circolari applicative, linee guida ecc… a “carico” più della dirigenza amministrativa che della “normazione politica”) venisse fatto disinvolto e spregiudicato uso della legge generale di riferimento (la Legge 517: per altro una delle migliori leggi scolastiche, dal punto di vista sia della forma che dei contenuti), anche attraverso veri e propri “copia incolla” (gli esegeti volenterosi vadano a verificare. Non temo contraddittori..) . Come dire? Il provvedimento che reintroduceva la valutazione numerica, non negava esplicitamente la filosofia della “valutazione formativa” che improntava al Legge 517. Si limitava (!?) invece a proporre “strumenti” diversi da usarsi entro la cornice della medesima “filosofia”. Un classico del paradigma amministrativo pubblico nazionale: la continuità prima di tutto. Dunque formulare documenti e provvedimenti ad uso plurimo e semantica “adattabile”. Chi si riconosca in predicazione riformatrice (di qualunque segno…) lo faccia. E parimenti chi voglia conservare le “buone intenzioni” della “buona innovazione” passata. Non si nega nulla, perché tutto era già compreso. La “politica” trovi le sue affermazioni “innovative” anche radicali; il quotidiano “funzionare” della macchina organizzativa, dell’interpretazione e della pratica professionale, trovi il suo “adattamento” all’insegna della continuità, (meglio: il continuismo…) anche sotto altra veste. D’altra parte, ormai, siamo “tutti riformatori”. Anche i “conservatori”.
La terza notazione fu la (stupita?)
constatazione della esiguità delle reazioni negative. Non vidi barricate erette
a difesa di principi o anche solo di prerogative professionali consolidate, e
tanto meno di “pratiche” educative il cui valore fosse minacciato e/o
compromesso. Tutto sommato una reazione contenuta e sotto traccia.
Un ceto professionale veniva investito da una modificazione formalmente radicale
di una componente strutturale fondamentale del proprio lavoro e dei propri
compiti, ma reagiva in sostanza borbottando… Non ci fu bisogno di “carri
armati”..
Allora, ricordo, per tentare di farmene una ragione, coniai il costrutto di
“vendetta pedagogica”.
In una stagione storica caratterizzata da forti istanze innovative (buona parte
degli anni ’70 e ’80) una “minoranza ciarliera” e impegnata aveva
convinto/costretto una maggioranza silenziosa e rassegnata ad adottare paradigmi
e strumenti “innovativi” (un esempio per tutti quello di cui qui si parla: il
significato formativo e non sanzionatorio/classificatorio della valutazione).
Una importante stagione innovativa (basti pensare ad una sensibilità rispetto ai
problemi dell’integrazione che è esemplare anche nel confronto
internazionale..). Con aspetti di conquista progressiva ( la generalizzazione di
una sensibilità) e aspetti negativi: il velleitarismo di pensare acquisita tale
conquista, per tutti, senza dedicare “cura e investimento” per consolidarla
(fare i conti con costanza e paziente investimento in formazione professionale
dei docenti).
Sicchè: a lungo andare la fase storica cambia, e la “maggioranza silenziosa” si rivela come tale e si prende la rivincita. Il numerico, la sintesi quantitativa, restituiscono (finalmente) nettezza, semplicità, serietà e severità necessaria, alla valutazione.
L’aspetto inquietante di tutto ciò sta
nel fatto che, adottando “criteri di serietà e chiarezza” la possibilità di
discrimine tra lo strumento numerico e quello delle “schede di valutazione” è
ridotta all’insignificanza.
E’ ben vero che la sintesi estrema del “numerico” fa a pugni con la complessità
della valutazione formativa; ma è altrettanto vero che “i giudizi di
valutazione” nei quali è stata trasferita una sorta di “scienza dell’avverbio”
(quantunque …non ostante …raggiunge tuttavia.. ) non sono certo
rappresentazione adeguata della acquisizione generalizzata di quelle sensibilità
valutativa nel modello professionale prevalentemente interpretato dai docenti
italiani.
Vero semmai il contrario: la cultura valutativa è uno degli elementi deboli
della cultura professionale dei docenti italiani, di ogni ordine a grado. Con la
specificazione che essa è tanto più carente e discutibile quanto più si avanzi
nel grado di scolarità..
Sotto questo profilo, la strategia di quella non rimpianta ministra ebbe la
strada spianata dai suoi stessi oppositori: come costruire davvero un discrimine
politico (e tecnico) comprensibile e condiviso tra una valutazione netta e
inequivoca espressa in numeri decimali, e una raccolta ingegnosa di
argomentazioni avverbiali? Le due cose si tengono, e alimentano reciprocamente,
nell’essere entrambe inadeguate e figlie di una cultura valutativa rudimentale.…
Da qui quella che ho chiamato la “vendetta pedagogica”…. Si ridiede fiato allora
ad una precedentemente silenziata “maggioranza silenziosa”: approssimata e
discutibile che sia una valutazione che esita da una cultura valutativa
approssimativa e rudimentale, l’espressione numerica ha almeno il vantaggio di
semplificare il lavoro, le procedure, la trasmissione, la comunicazione verso
l’esterno (famiglie, amministrazione ecc…), rispetto all’arzigogolo del
montaggio avverbiale… Questo il ragionare, esplicito e latente, che fece in modo
che la reazione all’intervento ministeriale non fosse proprio “rivoluzionaria”…
Si tenga inoltre conto che tra la Legge 517 e i valori che essa interpretava, e
i provvedimenti ministeriali che ne negavano l’applicazione ma
opportunisticamente ribadendone alcune affermazioni (la valutazione formativa),
passa un turnover di docenti per il quale, accanto ai “maturi e sperimentati”
che avevano vissuto direttamente la fase innovativa di fine anni ’70 (come che
si schierassero se con la minoranza ciarliera o la maggioranza silenziosa)
entrano nella scuola alcuni giovani (si fa per dire: in realtà in lunga e
incerta attesa nei meccanismi di reclutamento) che a quella fase storica erano
estranei o l’avevano vissuta “a margine”.
Nel frattempo, in assenza di continuità dell’intervento formativo professionale,
la cultura valutativa, già incerta, lasciata a se stante, non ha potuto che
decadere ulteriormente, tra richiami all’inclusione ed al valore formativo che
rischiano di ridursi ad ideologia e buonismo, “scienza” dell’avverbio nella
formulazione dei “giudizi”, formalizzazione dei repertori codificati nelle
schede di valutazione, e l’apparente realismo e semplificazione del “ritorno al
numero”.
L’esito di tale mix nel quale anche posizioni apparentemente diverse, si
“tengono” e sovrappongono, è che il nostro sistema di istruzione, formalmente
aperto e senza barriere di accesso, “spiaggia”, come cetacei che han perso la
rotta, mediamente circa il 20% dei suoi studenti,e, in alcuni settori e negli
anni iniziali della superiore, quote che vanno oltre il 30%.
Inoltre, alla fine dell’istruzione
obbligatoria si continua a fornire agli “aventi diritto” come futuri cittadini,
dei “consigli orientativi” i cui effetti valutativo-discriminanti sono ben più
rilevanti di quanto, in altri sistemi di istruzione apparentemente più
selettivi, vengono esercitati da barriere di ingresso e selezioni di merito. “lo
studente Pierino, tuttavia… non ostante… raggiunge… quasi…Si consiglia perciò
la prosecuzione degli studi nell’istruzione professionale…”.
Poi qualcuno dirà cose anche molto interessanti e puntuali sul “doppio canale”
nel sistema italiano al confronto con quello tedesco. Ma il punto di partenza è
quella espressione finale della media cultura valutativa espressa dall’intero
ciclo scolastico che opera la dislocazione selettiva (e avvalora l’implicita
gerarchia di valori culturali, al cui gradino più basso sta la formazione al
lavoro) salvaguardando la formale “apertura” del sistema e la sua vocazione
“promozionale” e comprensiva ideologicamente riaffermata ad ogni occasione.. E
spedendo Pierino al suo destino formativo.
Si capirà dunque anche solo da queste considerazioni (amare) che la mia adesione alla campagna per l’abolizione del voto numerico nella scuola del primo ciclo, è in realtà motivata dalla speranza che ciò costituisca una occasione per riprendere una sensata riflessione sulla cultura valutativa della nostra scuola e dei nostri docenti, più che dalla convinzione della superiorità o della migliore adeguatezza di uno o dell’altro strumento di espressone utilizzato per la valutazione.
Se dovessi argomentare sul piano tecnico dovrei articolare la relazione in modo assai diverso. E ci provo in modo sintetico/schematico, del quale mi scuso in partenza.
In linea di principio ogni scala di
valutazione dovrebbe essere trasferibile in altra, attraverso strumenti di
conversione formalizzati e dichiarati. Il problema è che la scelta delle scale
non è “tecnica”, ma ha forte valore storico-evocativo e simbolico.
Per esempio: la più volte citata ministra che rivolle la scala numerica la
ripropose decimale, da 0 a 10. Vi sono scuole che, rispettando tale scelta,
hanno però deliberato che “meno di 4 non si valuta”. Dunque adottano in realtà
una scala numerica da 4 a 10. Ho provato (provocatoriamente) a spiegare a questi
docenti che, rispettando la loro scelta, avrebbero dovuto modificare “il
significato” dei voti intermedi assegnati. Un 6 nella scala 0-10 non può essere
equivalente ad un 6 nella scala 4-10. Reazioni attonite.
Provo sempre a spiegare che, in origine, la scala decimale è in realtà un
“ordinale” che genera una “graduatoria”, non una “misura”. Dunque, per esempio,
non ha senso né l’alchimia dei mezzi voti o dei quarti di voto, del “quasi sei
meno..” ne tanto meno le “medie”. Si potrà mai fare una media tra ordinali?
Reazioni attonite…
Mi stupisce che di tale attonito uditorio non sia consapevole, per esempio,
l’INVALSI, quando applica scrupolosamente la traduzione in scala decimale (0-10)
delle sue misurazioni “oggettive” nelle prove che accompagnano l’esame di Stato
alla fine del Primo Ciclo. I docenti, in genere non amano le “prove oggettive”
definite da un soggetto terzo; ma tale disamore viene rinforzato dall’esito di
una applicazione rigorosa di una scala di misura che svela invece la loro
applicazione approssimata ed inconsapevole, sia pure guidata dal buonismo che
“meno di 4 non si può..”. E sia, ma allora il 6 non è 6, ecc…Chi glielo spiega,
all’INVALSI che per me la scala va da 4 a 10?
Per evitare equivoci: sono, personalmente, per abolire l’esame di stato in
uscita dalla terza media. Sono per valorizzare il significato di prove standard
come rilevazioni (dunque “indicatori”) dei livelli generali di apprendimento, e
non come sostituzione della valutazione dei dicenti. Sono anche d’accordo nel
attribuire il giusto significato a “prove nazionali” (per esempio in uscita
dalla secondaria superiore), con l’avvertenza di formularle in modo corretto e
significativo.
Ma sono assolutamente e tristemente stupefatto della superficialità con la quale
si mescolano i diversi livelli e significati. Sia nei policy makers, sia
negli amministratori che dovrebbero tradurre in pratiche gli orientamenti
politici, sia nei “tecnici” che sono incaricati di definire la strumentazione
conseguente. Tutti gli errori o le inavvertenze che si accumulano lungo tale
filiera hanno effetto di “rinforzo e conforto” delle carenze della cultura
valutativa mediamente disponibile ai docenti della nostra scuola. Ne abilitano i
pregiudizi, le prese di posizione conservative, le reazioni difensive.
I “dati”, le misure, sono fondamentali
per accompagnare, sostenere, la catena inferenziale che produce, a partire dai
dati e dalle misure, la “elaborazione del giudizio”, che rappresenta la fase
finale, il coronamento, l’espressione compiuta del processo valutativo.
Per quanto accurate siano le misure e pertinenti i dati (le cose misurate e gli
strumenti di misura usati), non vi è “automatismo” tra i dati, le misure, e
l’elaborazione del giudizio. E vale anche la considerazione reciproca: tale
elaborazione può essere condotta anche con esile supporto di dati e misure, e
non è detto che, per questo, non raggiunga una buona significatività (Le misure
validanti la teoria generale della relatività vennero “dopo” l’elaborazione
einsteiniana..). Semplicemente occorre in chi valuta, la consapevolezza del
margine di rischio e di arbitrarietà che una valutazione con esile base di dati
comporta. (E certo, quando ad essere valutate sono persone, ciò implica una
doverosa dose di dubbio e di inquietante incertezza…)
Nel ragionamento “tecnico” applicato al contesto scolastico o comunque di
istruzione e formazione (dove qualcuno deve “imparare qualche cosa”) le cose si
complicano perché vi è una esigenza “sistemica” di avere non solo un indicatore
sintetico dell’esito finale della elaborazione del giudizio (può essere un
numero, come una parola o una lettera), ma anche una serie di “indicatori
intermedi” capaci cioè di contrassegnare le tappe di quel percorso inferenziale
che porta dai dati alla elaborazione del giudizio.
La questione “scala numerica oppure no” dunque andrebbe affrontata connettendo
tra loro tre problematiche: cosa misurare, quali strumenti di misura e scale
utilizzare, come aggregare dati e misure in indicatori di sintesi sia intermedia
che finale. E infine (ma è solo la conclusione e certo non la questione più
interessante) scegliere la rappresentazione simbolica più efficace della
sintesi finale. (Numeri, lettere, aggettivi… avverbi, imperfetto, condizionale o
indicativo….).
Si ripropone, anche per tale argomento
(la valutazione), una considerazione di fondo relativa al mestiere
dell’insegnare.
La valutazione è una dimensione ineliminabile della relazione educativa e della
sua clinica. Lo è in realtà in qualunque dimensione relazionale della nostra
vita: tutti siamo valutati e valutiamo. L’elaborazione del giudizio presiede lo
scambio interpersonale. Nella relazione pedagogica ed educativa però, data la
sua strutturale asimmetria, la clinica della “elaborazione del giudizio”
acquista dimensione cruciale.
Entrambi i protagonisti, il docente e il discente, “sanno” che la dimensione
valutativa è appropriata ed ineliminabile nello stessa relazione educativa. E
devono entrambi imparare ad elaborare tale dimensione (dolorosa). La paura, la
fuga, l’ansia da un lato; la deriva pigmalionica, sadica, connivente o
oppositiva dall’altro.
Sotto tale profilo è ovvio che la complessità della valutazione nella relazione
educativa non sia riducibile all’uso di una “scala di valutazione” piuttosto che
di un’altra. Ed è ancora più comprensibile che, a fronte di tale complessità
(drammatica e dolorosa nella sua più piena applicazione clinica) l’uso di un
numero appaia inaccettabilmente mortificante, e susciti reazioni di rifiuto in
coloro che avvertono con maggiore sensibilità la portata clinica della
questione.
Occorre distinguere però tra tale autentica sensibilità e la predicazione
ideologica della dimensione formativa della valutazione. Qui va posta
particolare attenzione. Perché proprio la dimensione formativa è posta sotto
scacco dalla necessaria rielaborazione di una dolorosa asimmetria della
relazione educativa. Non è sufficiente essere buoni, comprensivi, accoglienti,
non discriminanti, attenti alla complessità e unicità soggettiva. Sono tutte
condizioni necessarie (mancherebbe!!) ma non sufficienti. Valutare, parte così
integrante dell’insegnare ed educare, richiede comunque “elaborazione del
giudizio” e non solo accettazione dell’altro ( o al peggio, assimilazione
amicale..).
Per esempio non è possibile (come spesso ideologicamente sembrerebbe predicarsi)
esimersi dalle “prove” alle quali il soggetto deve sottostare e partecipare. Non
solo per la banale considerazione che “le prove” fan parte della vita. Se la
questione è portare i cuccioli nella foresta perché imparino a cacciare (sintesi
del compito educativo) allora non solo ci sono prove cui sottostare (la tribù ci
conta e si aspetta certe “prestazioni”…), ma c’è anche il necessario “riprova
finchè non riesci…”. (E se non riesci a cacciare con gli altri… magari prova a
fare lo sciamano ...appunto...)
Dunque è tutt’altro che soft la dimensione della valutazione nella
relazione educativa…
Il tutto va però commisurato e dialettizzato con l’altra dimensione: la
relazione educativa, e la sua componente valutativa, sono comunque poste entro
un sistema organizzato; vanno ricondotte a modelli codificati, collettivi,
necessariamente standardizzati. Addirittura sottoposte a “certificazione” (che,
con buona pace di molti, per esempio sostenitori del valore legale del titolo di
studio, è cosa assai diversa dal “rilasciare un certificato” da parte
dell’Amministrazione).
Il problema dunque è che i contenitori, i repertori, le tassonomie codificate e
standardizzate del “sistema” abbiano caratteri e dimensioni “accoglienti”,
ampie, flessibili, per ospitare e contenere processi “irriducibili” che animano
e rendono vitale la relazione educativa, che “muore” e si mummifica nel
“certificato”, ma che del certificato ha pure bisogno..
Se, dunque, sono profondamente d’accordo che tutto ciò non possa trovare sintesi significativa in un numero da 0 a 10 (e aderisco alla iniziativa di abolizione del voto numerico) con altrettanta convinzione ricordo che quella abolizione non è sufficiente. Anzi ha valore in quanto capace di rilanciare una profonda ed estesa riflessione circa “il valutare” entro la professionalità docente.
Una riflessione capace di superare i diversi riduzionismi cui la problematica è stata sottoposta in questi anni: dal tecnicismo docimologico, al primato del testing; dalla polemica sterile contro il testing alla vulgata “buonista e benaltrista” (la valutazione sempre è cosa assai più complessa…per tanti commentatori predicanti l’immobilismo.); dalla predicazione della “irriducibilità” della funzione valutativa del docente, al sequestro della valutazione come “cosa propria” del docente stesso, dentro o a fianco della quale nessun altro possa avere diritto di parola.
Ho un ricordo fotografico della mia
scuola elementare (quarto anno). Io e mia madre ai piedi della scala cha
dall’atrio della scuola saliva alle aule. Il maestro Rappa saliva e mia madre lo
richiamò dal basso… “Maestro, come va?” chiese, indicandomi…(vedi “colloqui con
le famiglie”…)
Il maestro si girò e protese il braccio, con la mano oscillante aperta e distesa
tra pollice e mignolo… il segno dell’equilibrio. Insomma la risposta, muta, ma
dal gesto eloquente, era “così/così, senza infamia e lode, se la cava…
quantunque… tuttavia… non ostante…”. Ma muto. Era un siciliano silenzioso e
ammiccante. Tocca all’interlocutore il capire. Quella fu tutta la elaborazione
della scienza valutativa del maestro Rappa (un grande maestro…)
Son passati sessanta anni e a volte mi sembra che non molto sia cambiato, se
non parole, schede, indicatori, circolari, dichiarazioni riformatrici. Il fatto
è che Rappa ci ha azzeccato (l’INVALSI direbbe “esiti a distanza”), senza
schede, indicatori, repertori, competenze codificate.
Cosa che per un verso mi conforta.
Ciò che me la rende inaccettabile è che io ero, sono, sono stato, un
privilegiato. Ero già selezionato tra i meglio nel momento in cui il maestro si
voltò verso mia madre con quel gesto.
Il “saper fare” di quel maestro rimane un simbolo della cura e del “naso”
necessari nel mestiere. Ma è anche il segno della inadeguatezza progressiva di
quel modello professionale lasciato a sè stante e non nutrito costantemente di
cura, formazione, rielaborazione culturale e professionale collettiva.
E senza cura si sprecano anche quelle risorse di acume, sensibilità, intuizione
artigianale che sono ineliminabili nel mestiere.