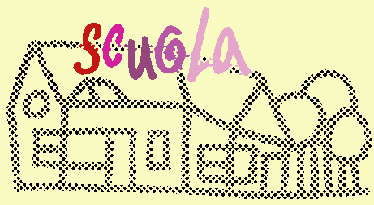 |
Direzione didattica di Pavone Canavese |
06.06.2007
Elogio
del pensiero riflessivo
di Cinzia Mion
I contributi, recentemente apparsi on-line, di Pasquale d’Avolio, di Gabriele Boselli, nonché l’ultimo di Fortunato Aprile e tutti gli altri vari testi sulle competenze mi hanno stimolato a rimettermi a rispondere per rilanciare il dibattito. Comincerò dall’amico D’Avolio perchè il suo testo parla di una mia presunta critica al documento di Ceruti. Ad aizzare le cosiddette frecciatine non è stato il documento di Ceruti sulla complessità, ma il riferimento alla "persona" che dato il clima di assedio allo stato laico, e di conseguenza anche alla laicità della scuola, da parte delle gerarchie ecclesiastiche, su cui avrei da dire e ridire abbondantemente ma su cui oggi non voglio soffermarmi, non mi sembrava il caso di lasciare passare, essendo questo un termine piuttosto pieno di evocazioni filosofiche incontrovertibili. Mi è stato spiegato che il termine persona è stato fatto ascrivere alla carta dei diritti dell’uomo, e che non era il caso di impuntarsi…Mi rimane qualche perplessità, ma accetto, in nome delle varie mediazioni del momento, questa giustificazione.
Mai però mi sarei sognata di criticare il riferimento alla complessità, cultura che io dalla lettura del bellissimo libro "Sfida della complessità" ho sempre ammirato e considerato indispensabile ad interpretare i tempi della postmodernità. Mi permetto un vezzo autobiografico: correva l’anno 1989, ad Acireale, all’interno di uno storico e bellissimo convegno dell’Andis, ho tenuto una relazione sulla valutazione, incominciando proprio con un elogio della cultura della complessità. Il problema è che la scuola, che è sempre rimasta ancorata ad un insegnamento delle risposte esatte e non problematiche, ha quasi sempre ignorato le stimolazioni raccolte in quel testo da Bocchi e Ceruti, infarcita com’era dalla cultura neobehavioristica della programmazione per obiettivi,"descrivibili in termini oggettivamente osservabili e misurabili"
Ha ragione Boselli, teorico della postprogrammazione, quando fa ironicamente riferimento alla colonizzazione da parte di quella cultura dura a morire. Ma la programmazione lineare, cosiddetta per obiettivi, realizzata lungo una concatenazione di prerequisiti ed obiettivi, naturalmente costruita a tavolino, non è sovrapponibile al pensiero lineare, come sembra fare qualcuno. Si tratta infatti di prendere in considerazione il concetto scientifico di paradigma.
Il paradigma della complessità ha appunto affossato quello della cultura della linearità, inteso nella sua logica binaria, che si materializza nella "o" esclusiva :o giusto o sbagliato, o questo o quello,o vero o falso, a fronte invece del pensiero complesso che coniuga logiche diverse, nel nostro caso "e" pensiero lineare , analitico ,sequenziale "e" pensiero globale, simultaneo, reticolare. Un conto è un paradigma, come ci ha insegnato bene Kuhn, ed un conto è un tipo di pensiero, di cui non si può ignorare l’esistenza.
Ma vorrei spostare il ragionamento dalla gara a chi dice le cose "più nuove", bollando sempre le altre come superate, datate, ecc. , trovando così un escamotage per svalutare l’argomento preso in esame, ad altre considerazioni perché , come sanno bene le persone di scuola, questa istituzione funziona all’insegna di una certa vischiosità intrinseca che rallenta o impedisce l’innovazione, per cui una teoria può essere datata ma non aver mai varcato le sue porte. Non è forse vero che il testo di P.Watzlawick "Pragmatica della comunicazione umana" , tradotto in Italia nel 1971, diffusissimo a livello teorico, con i suoi assiomi sulla comunicazione, può vantare a tutt’oggi poche applicazioni del principio della circolarità della comunicazione in classe? E lo stesso dicasi di quello di L. Cancrini "Bambini diversi a scuola" (1974) che credo non abbia ispirato molti spunti pratici di attenzione ad evitare l’avverarsi della profezia riguardante il "membro designato".
Non pensiamo che la scuola sia allineata con gli aspetti di novità della cultura. Naturalmente non intendo fare riferimento alle teorie ed alle conoscenze di cui sono portatori i docenti, intendo fare riferimento allo scarto che continua ad esserci tra teoria e prassi metodologica. Non abbiamo appena detto che la sfida della complessità, almeno nella sua divulgazione in Italia a livello interdisciplinare, è dell’85? Nella scuola però è nuova, intendo come rivoluzione culturale. Non possiamo bocciarla come superata se non si è ancora affacciata all’orizzonte del cambiamento per orientare la bussola dell’insegnamento.
Dopo queste precisazioni intendo riprendere il filo rosso che attraversa tutti e due i documenti ministeriali e che è soggiacente alla rivoluzione della complessità, che consiste nell’elogio implicito dell’insegnare a pensare.
Non mi richiamo ad una o più competenze, faccio riferimento allo sviluppo dell’intelligenza connettiva, ( Derrick de Kerchove ) intesa non solo come connessione interpersonale, che avviene tramite la famosa "rete" telematica, ma come connessione intrapersonale, come capacità di trovare nessi e relazioni tra i dati, le informazioni, le conoscenze, gli elementi anche quando questi appaiono sconnessi. La complessità infatti richiede operazioni mentali diverse da quelle della linearità, che in genere si possono ricondurre a operazioni logiche di inclusione o esclusione, sia pure importanti, ma sollecita invece soprattutto operazioni di "coniugazione" di logiche diverse, a volte contrapposte. Coniugare il valore freddo del diritto, che parla di uguaglianza con il valore caldo della appartenenza ed identità che parla di differenza, è un esempio stimolante offertoci da Alain Touraine che ci parla di intercultura: uno dei problemi più urgenti e difficili dei nostri tempi.
Diventa allora qui opportuno segnalare l’importanza assegnata dagli studiosi D.S.Rychen e L.Hersh Salganik alle key competencies, intese come le competenze fondamentali per vivere nella società odierna della complessità, e che sono appunto quelle che riguardano l’abilità ad aver a che fare con le differenze e le contraddizioni, come l’autonomia e la solidarietà, la diversità e l’universalità, la novità e la continuità "integrando finalità apparentemente contraddittorie o incompatibili come aspetti della stessa realtà"
Nell’insegnare perciò il pensiero, che significa soprattutto pensare in proprio, non restituire solo i pensieri di altri, sia pure se si tratta di personaggi di altissima statura, bisogna, secondo me fare la nota distinzione che fa Diego.Napolitani , tra pensiero riflettente e pensiero riflessivo.
Ricordando che la scuola è il luogo della conoscenza, cerchiamo di capire perché è fondamentale che la scuola insegni, oltre al pensiero riflettente, soprattutto il pensiero riflessivo.
Il pensiero cosiddetto riflettente, che Boselli, credo di aver capito chiama pensiero non-pensante, è il pensiero che "rimanda luce non propria", che riflette, ripete e riproduce quel tipo di conoscenza e di adattamento all’ambiente, suggerito da una istanza identificatoria, dettata dalle matrici culturali di appartenenza.
Il pensiero riflessivo, invece, si contrappone al primo e tenta di illuminare il mondo di una luce propria. Naturalmente questo non può fare a meno del primo: il nuovo non può non inserirsi nell’orizzonte del già noto, ma deve andare oltre, deve aprirsi allo stupore, alla curiosità, avendo a disposizione gli strumenti dell’ermeneutica per leggere ed interpretare il mondo.
D.Napolitani dice che la dicotomia tra identità fondata su identificazioni difensive (pensiero riflettente) e identità fondata sulla autonomia e progettualità del soggetto (pensiero riflessivo) può essere ricondotta alla dialettica tra "idem" e "autòs": dove l’idem secondo la sua radice etimologica (essere uguale a…) costituisce l’origine dell’identità identificatoria
e l’autòs invece l’apparire dell’autenticità e della individualità soggettiva.
Non vi viene in mente, di fronte a queste considerazioni, quanto siano pericolose le raccomandazioni che vengono da più parti a costruire delle "identità" in linea con le proprie radici? Essere uguali a modelli familiari e sociali, assunti in modo acritico e passivo, non costituisce forse l’emergere di quelle famose identità difensive? E questo non vi richiama alla mente la costruzione di identità collegate sul versante cognitivo-emozionale alla mentalità chiusa e dogmatica? In gioco c’è allora molto di più di ciò che appare, come cercherò di dimostrare argomentando più sottointorno ad un altro tema importante, in cui sembra diventare indispensabile addirittura una vera e propria "trasformazione antropologica" come afferma il professor Fasullo
Mi è piaciuto molto il riferimento che fa Boselli all’identikit del Maestro nonché al tema della cura, tema che da solo meriterebbe una serie di commenti.
Partiamo allora dalla cura dell’etica, tema rilanciato da F:Aprile. E’ vero che i docenti si ritengono le vestali dell’etica, solo per il fatto che sono insegnanti, ma sono d’accordo con i dubbi espressi da Aprile e affermo categoricamente che non è assolutamente vero comunque che stanno assumendo l’etica pubblica come parametro della loro pratica professionale. Se l’etica della cura meriterebbe un argomento a parte di discussione, insieme all’etica della responsabilità, proviamo a pensare cosa comporterebbe rilanciare il tema dell’etica pubblica nella scuola, partendo dalle derive collettive che stanno contrassegnando la nostra società. Cominciamo con la denuncia del clima di indifferenza sempre più diffusa, sottolineiamo la mancanza di ascolto reciproco e della categoria dell’alterità, soffermiamoci a cogliere e stigmatizzare lo sfrenato individualismo e "tornacontismo" legittimato a tutti i livelli, il "fare finta" da cui la scuola non è di sicuro esente, fino al famigerato familismo italiano da cui già E.Banfield, definendolo amorale, ci aveva messo in guardia fin dagli anni cinquanta. Un familismo che ci fa porre l’interesse del proprio particolare sempre e comunque prima di quello collettivo, nella diffidenza verso lo Stato, nella insofferenza alle regole.
Non vi sembra che debba essere la scuola a dover iniziare una seria riflessione ed un conseguente passaggio all’azione su questo argomento? Consideriamo che la scuola è l’istituzione che intenzionalmente e sistematicamente può intervenire e che inoltre culturalmente ha gli strumenti ed il dovere di cercare di imprimere una svolta pedagogica significativa in tal senso.
Cominciamo a chiederci in che cosa consiste il bene comune, cominciamo ad insegnare come fare per raggiungerlo e ad insegnare cosa vuol dire rinunciare a qualcosa per gli altri, all’interno di un clima sociale imbevuto di consumismo e conformismo. Lavoriamo prima di tutto sulla consapevolezza dei docenti e poi sul livello formativo degli allievi/e, cercando insieme i rimedi che non devono essere prediche ma pratiche, altrimenti corriamo il rischio di consolidare il già noto malcostume del doppio codice etico: quello esplicito e quello implicito…
Ecco perché, come avevo già segnalato al Ministro nel giorno dell’audizione, nel documento sulle indicazioni dovrebbe esserci un forte riferimento all’etica pubblica che invece manca del tutto.
Educare alla cittadinanza come etica pubblica ed educare al pensiero riflessivo dovrebbe essere l’assunzione rigorosa e puntuale di questo governo, se vogliamo che le future generazioni possano uscire da questa situazione così frustrante che stiamo vivendo oggi in cui la corruzione dilagante ci sta togliendo il respiro e la speranza.