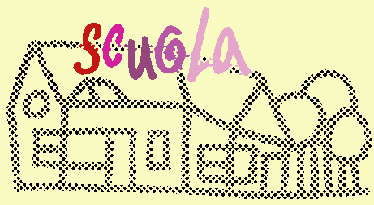 |
PavoneRisorse |
14.05.2013
La grande malattia
di Raffaele Iosa
1. L’algoritmo iatrogeno
Uno spettro s'aggira per le scuole d’Italia: lo spettro dei bambini e giovani come grande malattia. Tutte le potenze cliniche, dell’accademia, della psicologia cognitivista empirica, della meritocrazia darwiniana, delle competenze come competizione, si sono alleate in una santa battuta di caccia contro questo spettro: càmici, toghe e divise, magistrati e legislatori, radicali comportamentisti e poliziotti dell’omologazione sociale. Considerano ogni “problema” una malattia, e lo clinicizzano, come risposta allo spettro che s’aggira. Scompare la risposta pedagogica.
L’incipit para-marxiano descrive un processo di lunga iatrogenesi (malattie prodotte dai medici) che sta classificando in chiave “clinica” sempre più numerosi alunni, con ripercussioni sulla scuola fino alla sua stessa ragion d’essere, su gran parte della pedagogia progressista, sul destino dell’educazione come sviluppo individuale e collettivo della coscienza e della libertà.
La profezia di Ivan Illich su “Nemesi medica” si sta avverando: un dominio dell’algoritmo clinico che riduce le persone a “sintomo”, perdendone la complessiva identità. Per ogni sintomo c’è una medicina, una terapia, un santone. Siamo inoltre dominati dall’ideologia della salute omologata ad un’astratta vita senza mai dolori e fatiche. Sullo sfondo l’enorme potere, quasi senza limiti, della medicina attuale della “salute asintomatica”, effetto della consumistica ideologia del godimento senza limiti, della salute come “non malattia”.
In sostanza, è esplosa la manìa per cui tutti i “problemi” di ogni bambino o giovane (biologici, cognitivi, relazionali) vanno serializzati da uno sguardo scientista empirista che individua (cerca, trova, inventa) “sintomi” scissi dall’unitarietà e complessità di ogni singola persona. Questa teoria ha un metodo dominante, l’ EBM (evidence-based medicine) strutturato sulla statistica delle frequenze di singoli sintomi lungo scale (oggettive?) a gaussiana predittiva (test, soglie, prove, esami..diagnosi). Metodo che produce burocraticamente “disturbi, sindromi, spettri, ecc..” con linee guida cliniche in apparenza “dure” ma che variano spesso. La centralità mitica del “sintomo” giustifica norme, leggi, tecniche, terapie, farmaci, e una violenta pressione sull’agire pedagogico a diventare tecnicismo separativo. Con nuovi affari e nuovi specialisti. Suggerisco a tutti l’attenta lettura del libro di Marco Bobbio, famoso cardiologo figlio di Norberto, “Il malato immaginato, i rischi di una medicina senza limiti” Einaudi 2010. Una critica radicale alla teoria dell’EBM e la proposta di una medicina più umana, che accetti la vita come processo cui la medicina, come la pedagogia, debba guardare sempre con una visione olistica, ecologica, sistemica.
Qualche esempio per capirci, con casi inerenti la scuola.
1. Leggo dal Centro Studi Erikson la presentazione di un convegno con queste
parole: “…Le ricerche stimano che sempre più bambini e ragazzi nella
fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni manifestano disturbi specifici di
apprendimento e/o disturbi di attenzione, impulsività iperattività”.
Faccio notare agli amici Erickson, in genere studiosi seri, un lapsus
evidente:
“…sempre più bambini….manifestano…disturbi, ecc..”.
La questione è, ovviamente più complessa. Si tratta di un’epidemia? Ma non
c’é alcuna prova! O invece di una diversa attenzione (clinica? culturale?
ideologica?). Non potrebbe essere che si accelerino troppo le tappe
evolutive per l’idolatria del precocismo?
Insomma non potrebbe essere che queste “malattie” siano come l’obesità? Non
basterebbe fare la dieta? Quindi qual è la causa e quale l’effetto? Si
esaltano “sintomi” scissi dal resto con teorie incerte sull’eziologi.
Il sintomo diventa causa strutturale della crisi della persona (non una tra
altre), non fa emergere potenzialità alternative (come ci insegna Andrea
Canevaro) ed esalta ovviamente come soluzione la tecnica, lo specialismo, l’isolazione
dal resto e dagli altri.
2. Una signora bolognese, che non conosco, è oggi responsabile scuola del PD,
nonché senatrice capogruppo PD nella Commissione scuola del Senato. In un
suo testo “politico” sulla scuola media propone l’assunzione (in più dei
docenti disciplinari) di “insegnanti specialisti in psicopedagogia della
preadolescenza” perché l’età della scuola media è complicata.
Dunque: non una formazione iniziale di tutti i docenti sulla
preadolescenza, ma insegnanti “normali” di italiano, matematica, ecc…, e
poi esperti di paturnie adolescenziali, un mix tra commissario politico,
cappellano e terapeuta solitario.
Considerando, ovviamente, di per sé la preadolescenza “una malattia".
Suggerisco alla senatrice bolognese la lettura (anche questa attenta) del
libro dei francesi M. Benasayag e
G. Schmit “L'epoca delle passioni tristi” (ed. Feltrinelli).
I due francesi, riprendendo
anche approcci di tipo marxista (oh, yes!) sul rapporto tra persona e
società, pongono al centro la “tristezza delle società adulte” davanti alla
paura del futuro e la crisi adulta come origine-causa prima di una
qualsiasi preadolescenza faticosa. Il rischio di una qualsiasi terapia sui
giovani è evidente: lo psicologo e l’educatore come “bromuri-sedativi” di
una crisi che andrebbe invece esplosa in ben altre azioni economiche,
sociali, politiche. Riemergono gli studi di Faucault sulla “salute” come
omologazione ideologica. Curare gli effetti senza intervenire sulle cause è
sbagliato scientificamente, alla lunga dannoso. Dunque, è l’intera comunità
adulta di una scuola media (i professori, i genitori, le bidelle) che
dovrebbero farsi “saggi di preadolescenza”.
Saggi e non “sapienti”, cioè capaci di comprendere e di cercare con gli
alunni una fuoriuscita di libertà, che può/deve contenere anche elementi di
divergenza, non sedativi che attribuiscono al ragazzotto/otta le cause di
tutto il male. Magari accompagnato da “teorie genetiche” o
“neuro-specchiali”, che fanno da cornice scientista semplificatoria delle
contraddizioni umane e sociali.
3. Dal 2001 l’OMS propone come strumento di individuazione della condizione
umana (non di handicap o di disagio, ma di condizione “tout court”) il
cosiddetto ICF , interessante strumento diagnostico con caratteristiche
dette “bio-psico-sociali”. Insomma, uno strumento che interpreta la persona
nel suo insieme a partire dal suo “funzionare”. Uno strumento che va oltre
la semiotica classica, le diagnosi sintomatologiche, e ha per natura
scientifica quella di essere “interdisciplinare” (clinica, pedagogia,
sociale, psicologia, ecc..).
L’ ICF ha i suoi limiti, ma è una piccola svolta culturale che l’Italia non
ha acquisito. Le ragioni del no al suo uso nel mondo clinico e istituzionale
sono evidenti: si preferisce il vecchio ICD-10, strumento diagnostico
centrato sui sintomi e la loro esaltazione clinica. Tutto il mondo della
disabilità è calcolato in sigle alfanumeriche dall’ICD-10, ed è alla base
della burocrazia clinica, sociale e pedagogica (invalidità, pensioni,
prebende, sostegno fino al calcolo delle ore, protesi, ecc…). Quindi un
apparato concettuale che confonde la persona con la sindrome, di fortissimo
potere istituzionale, che produce nella scolarizzazione più ingiustizie che
equità. E infatti la ormai vecchia ma saggia Legge 104/92 pretendeva la
cosiddetta “diagnosi funzionale”, più articolata di una sigla e capace di
vedere deficit e potenziali, una specie di anticipo dell’ICF.
Ma il MIUR, il Ministero Salute, e quello del Welfare fanno più i conti con
la quantità che con la qualità. Rinchiudere la persona in “sintomi” dà
forza allo “specialista del settore”, che assume infiniti poteri terapeutici
e di indirizzo anche della scolarizzazione.
Non è un caso che l’epoca della “grande malattia” nei bambini e nei giovani sia aumentata via via che si sono concretizzate le politiche darwiniane della destra (ma non solo) con il mito del “merito”, la confusione sulle “competenze”, la mania della “competizione”, la valutazione INVALSI vissuta come perfomance, ma anche il ritorno dei voti nel primo ciclo, l’aumento degli alunni per classe, la riduzione della flessibilità, l’omicidio dell’autonomia scolastica sulla culla. Tutto questo ha alimentato un processo culturale di decadenza che bene ha descritto Dario Missaglia nel suo recente articolo “L’eredità contraddittoria del governo Monti sulla scuola” del 14 maggio scorso, quando evidenzia gli aspetti fondamentali dell’attuale crisi della scuola, che è ormai di identità e ruolo sociale, in due parole se domani se sarà un futuro trasformativo o un presente darwiniano.
Paradossalmente, oggi la rincorsa alla “certificazione” e di “giustificazioni cliniche” davanti a qualche presunto mal funzionamento di apprendimenti/comportamenti, sembra spesso una specie di “difesa” dei genitori davanti ad una scuola diventata dura e competitiva. Ma diventa anche una scusante per gli insegnanti (“Ah, allora non è per volontà che non capisce, ma per biologia! Quindi: io non ho colpe didattiche”).
La Grande Malattia semplifica molte cose, tutte brutte.
Per esempio riduce la responsabilità degli adulti, abbassa la fiducia verso
i ragazzi (se non ce la fanno non è colpa loro), deresponsabilizza la
relazione adulto-bambino. Prefigura anche nuovi cronicari scolastici di
finta integrazione, con una nuova subdola fenomenologia che ho chiamato “isolazione”,
cioè stare a scuola con gli altri per finta, perché il “sintomo” diventa
barriera, specialismo, calo della fiducia evolutiva. Accade quindi che ad
alcuni, davanti al mito selettivo, possa sembrare che le tecniche separative
(es. il compensativo e dispensativo dei DSA) sia comunque meglio. La recente
(confusa e pericolosa) nota MIUR sui cosiddetti BES, con l’estensione di
dispensativo e compensativo ai nuovi dolori, legittima una separazione
pedagogico-burocratica tra alunni, in cui l’insegnante ha poco spazio di
flessibilità e di esaltazione dei potenziali.
Si riduce anche il valore della resilienza, cioè la sana e normale risposta
alle sfortune della vita di cui spesso i ragazzi abbondano, e che i
sacerdoti della grande malattia negano con questo pensiero: ”Mica questi
ragazzotti vorranno curarsi da sé reagendo alle sfighe con la propria forza?
E io dove finisco con le mie tecniche perfette?”.
Qui la iatrogenesi algoritmica sfiora l’assurdo, ma è oggi potere seduttivo:
promette “una diagnosi per tutti. olè; la guarigione per tutti, olè; e
l‘eterno benessere, olè. Se seguite me”.
Davanti alle incertezza della scuola e alle passioni tristi del mondo, un
certificato per giustificarsi crea la fine della divergenza,
l’assistenzialismo come necessità. Un nuovo stuolo di specialisti pronti a
curarci.
La grande malattia dentro la scuola ha origine da fenomeni complessi che qui accenno come cornice entro cui collocare la fuga verso la “grande malattia certificata” come piccola salvezza individuale dalla selezione darwiniana, la separazione scientista tra “sani” e “disturbati”, l’invadenza della tecnica salvifica rispetto ad una pedagogia olistica e delle relazioni significanti. Approfondiamo.
1. La vita sociale è dura, altro che liquida come dice Baumann. E il mito della “salute” è uno dei più duri perché si è mescolato con il consumismo e l’edonismo, creando un “mercato della salute” seduttivo. Una medicina mitologica crea speranze e false vite. Non è questo, ad esempio, la scoperta del Viagra? Non si può vivere serenamente la vecchiaia ricordando i bei tempi?. Anche la prevenzione, mito della sinistra, va discusso. Leggete il libro “Amara medicina” dello statistico Roberto Volpi, critico con disarmante efficacia dei falsi positivi e falsi negativi in quantità. Eppure la medicina (e connessi) avrebbe vestito “scientifico”, il càmice vale molto di più del grembiule. Si pensi ancora all’uso ideologico delle ricerche genetiche (per ogni emozione una catena di acidi nucleici ci spiega perché), la questione dei neuroni specchio (Aristotele associa meglio la percezione alla cognizione). Potremmo andare avanti ancora. Nei quotidiani e in TV il mito della medicina che guarisce, della salute asintomatica. I farmaci sono sempre più “avanzati”, manca poco all’eternità biologica. Accompagna questo mito l’idea fondativa che ogni sofferenza, ogni dolore sia “anormale”, che a star male si perde sempre. E la nostra umanità diventa sempre più artificiale, come aveva preconizzato Emanuele Severino con la sua critica alla società della teknè.
2. La vita nella crescita è dura, altro che bellezza della giovinezza! Il calo demografico produce figli nati da genitori sempre più vecchi, figli sempre più solitari, figli cui si chiede la perfezione per il sé genitoriale, non per loro. Questo figlio deve stare sempre bene, per esempio deve sempre divertirsi (non giocare, che è altra cosa). A questa mitologia si accompagna la scuola sempre più quantitativa (ah, le competenze diventate quintali di schede-fotocopie!). Questo figlio non deve mai farsi male, mai soffrire. Su questa premessa socio educativa la medicina della Grande Malattia agisce con una seduzione avvincente. Ed una certificazione leva qualsiasi senso di colpa, responsabilità. Meglio “un po’ ammalati” che cattivi. Meglio una tecnica che una pedagogia vera.
3. Sono in crisi profonda i luoghi di comunità, quelli dove “insieme se ne esce”. La solitudine e la perdita di reti comunitarie fa da pendant alla selezione darwiniana e al senso del futuro come minaccia (vedi Hobswam “Il secolo breve”). Da qui va in crisi anche la scuola come luogo che “accoglie tutti”, che “comprende tutti”, che sa travasare l’un l’altro doti e difetti. Insomma l’apprendimento come “capitale sociale” di più menti che lavorano insieme pur con diverse performances viene sostituito da prove INVALSI, voti, olimpiadi disciplinari, selezione per l’università, e così via. Stiamo quindi perdendo un perno del nostro immaginario pedagogico, quello del gruppo di pari che cresce per merito reciproco. E nella competizione, tutti gli strumenti sono buoni per non restare indietro, meglio se individuali, specializzati. Così si confezionano pedagogie quantitative senza sapore, alunni saputelli ma non saggi.
4. La figura degli insegnanti non è mai stata così in basso come in questa epoca, tra insulti perché lavativi, a ignoranti perché non moderni, né carismatici perché poveri. Lo stesso accade ai genitori, che non sentono più dentro di sé l’autorevolezza adulta, ma l’insicurezza di essere poco bravi come genitori. Da qui una disistima dell’educazione come forza trasformativa delle singole persone e delle generazioni dopo di noi. Da qui il sopravvento della tecnica sulla didattica, dei metodi sulla progettazione flessibile. A questi bistrattati insegnanti si danno sempre più alunni, alunni sempre più complicati, si accorciano le risorse. Dunque questi insegnanti sono spesso costretti, loro malgrado, a vedere nello “specialista” una risposta consolatoria, nell’insegnante in più un po’ di respiro, nell’esperto colui che ti cava le castagne dal fuoco con ricette precotte.
Naturalmente so molto bene che bambini dislessici, con
caratteri difficili, con difficoltà ad apprendere, di scarsa intelligenza
generale, con storie personali e sociali drammatiche, ce ne sono in
quantità. So anche bene come la crisi economica aumenti certe difficoltà. Ma
non riesco a vedere tutto questo dolore se non in chiave olistica e
pedagogica. Non nego la presenza di “sintomi”, anzi ne riconosco tutta la
serietà e la necessità di studio. Ci vorrebbe forse più deontologia nei
ricercatori (spesso il ricercatore è la sua ricerca), ma la questione
principale è ermeneutica: la persona è una, non è fatta di parti, se tocchi
un punto tocchi tutto. La persona esiste perché ha relazioni. Dunque?
Sono stupito dal silenzio imbarazzato dei pedagogisti speciali, da cui mi
attenderei un’analisi critica della confusione del presente, e della
necessità di sguardi interdisciplinari che oggi non ci sono.
Penso che purtroppo (nonostante da parte di alcuni in buona fede) le attuali
politiche scolastiche sul “dolore” in età evolutiva (dalla legge 170 alla CM
sui BES come alcuni fraintendimenti sulla legge 104) non siano la soluzione
ma il problema. Creano cioè nuove contraddizioni e aberrazioni educative
perchè strappano sguardo e azione pedagogica in rivoletti tecnicistici.
Riprendiamoci la pedagogia, insomma, con un’onesta critica al presente ed
un’onesta ricerca di soluzioni individuali e di comunità diverse da quelle
dei nuovi sacerdoti della teknè empirista.
Ritengo, tra l’altro, che la legge 170 sui DSA abbia provocato più danni
che risultati. Penso che l’approccio ai BES con la logica della Legge 170
sia peggio ancora. La logica del “compensativo e dispensativo” è questione
didattico-pedagogica di responsabilità del docente, non tecnica misurata da
psicologi cognitivi. Avevamo già la Legge 517 (del 77!) che prevedeva l’
“individualizzazione”, parola molto più bella e flessibile di queste due
che sanno di burocratico e sindacale. Soffro a vedere gli insegnanti piegati
a ricevere “ricette tecniche” da esterni, senza la forza e lo spazio per una
propria ricerca professionale autonoma, solo questa utile a rimettere
insieme l’unità tra persona e comunità, che è la vera anima dell’educazione.
Questo saggio è solo il primo (la cornice teorica) di una serie che sto scrivendo sul tema della Grande Malattia e che per economia di lettura ho diviso in 5 puntate. Nelle prossime: