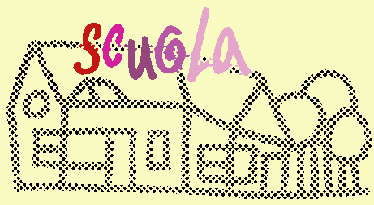 |
PavoneRisorse |
03.09.2014
Il lavoro
del docente, un "mestiere" di confine (prima parte)
di
Franco De Anna
La parola “riforma”,
riferita alla scuola è ormai una sorta di buzz word, un ronzio
fastidioso che si ripete di convegno in convegno, di legislatura in
legislatura, di ministro in ministro, di indicazioni e curricoli.
Più recentemente si abbina all’idea che occorrano interventi direttamente
coinvolgenti gli insegnanti (formazione, merito, orari di lavoro,
articolazioni professionali) e, nelle motivazioni di tale abbinamento, si
articolano e convalidano nel chiacchiericcio politico e mediatico che spesso
sostituisce la riflessione, curiose rappresentazioni contraddittorie degli
insegnanti stessi. Agli estremi: una categoria professionale, certo
retribuita modestamente, ma che lavora poco e senza controllo; un ceto di
“eroi” sottopagati che, pure, nel suo sacrificio regge un edificio cui si
dedicano poche risorse e attenzioni.
Nell’intento di contribuire a superare tali contraddizioni e semplificazioni
e di cogliere elementi di realtà essenziali ad una sensata politica
scolastica (quali ne siano le scelte alternative..) propongo una
interpretazione del lavoro del docente come “un mestiere di confine”.
Quella del “confine” è una metafora complessa, ambigua e affascinante (come
ogni metafora che si rispetti).
Il confine è la linea di separazione, ma anche di congiunzione e di
prossimità; è la “superficie di scambio” tra distinzioni e meticciamenti; è
il “limite” e dunque congiuntamente il vincolo e la sfida.
I motivi per attribuire tale metafora al lavoro del docente sono tanti e
ovviamente non disposti linearmente nell’argomentazione e neppure
equivalenti.
Ma cercando di dipanarne gli intrecci si incontrano molte delle
contraddizioni che segnano questo lavoro e il ceto che lo interpreta. E su
tali contraddizioni proprio tale approccio consente di fare più luce di
quanta (poca) rischiari i più generici inviti alla cosiddetta ”centralità”
della scuola.
Il primo confine: tra relazione educativa e sistema organizzato
L’impegno quotidiano di
ogni docente, quale ne sia la preparazione professionale, l’esperienza, la
disponibilità individuale, è collocato entro la “relazione educativa”. Una
relazione asimmetrica che, come tutte le relazioni asimmetriche, comporta
dolore e rischi patologici nella sua gestione.
E’ una relazione polimorfa: uno-a–uno, uno–a–molti, molti–a-molti. E
ciascuna dimensione presenta problematiche specifiche tra loro connesse. Si
consideri inoltre che dall’esterno di tale relazione (dalla società, dalla
politica, dalla cultura, dalla moda) provengono sollecitazioni che volta a
volta pongono in evidenza l’una o l’altra dimensione, e dunque interrogano
in modo vario il lavoro del docente. Per esempio la sottolineatura alla
“personalizzazione”, che da oltre un decennio viene proposta nelle politiche
scolastiche; o, per altro verso, il richiamo alla necessità di esplorare e
sviluppare nella scuola l’attenzione alla dimensione molti-a-molti (la
relazione e la gestione con “i gruppi” nella classe, posto che la classe
solo per comodità erronea viene indicata come un gruppo: non lo è).
Un richiamo più che fondato se si pensa che la scuola è oggi sempre più
l’unico luogo organizzato di sviluppo e gestione della “noità” che è
dimensione essenziale nella formazione del soggetto, sia sotto il profilo
psicologico (il superamento dell’io infinitamente desiderante e della
dimensione ristretta della appartenenza famigliare), sia sotto il profilo
sociale e collettivo, come “premessa” della cittadinanza compiuta e
consapevole.
Nell’immaginario
(nell’ideologia) di ogni (buon) insegnante (professionalmente) motivato e
(apprezzabilmente) preparato alla professione, è fondativa la vocazione
“pedagogica” (non necessariamente la effettiva cultura pedagogica). Il
docente si rappresenta il proprio lavoro come finalizzato ad accompagnare lo
sviluppo dell’allievo verso l’adultità, la autonoma capacità di affrontare
la vita, il lavoro, lo sviluppo successivo, ecc…Insomma il proprio lavoro di
commisura a confronta con lo sviluppo del soggetto con cui interagisce nella
relazione educativa.
Contemporaneamente, il lavoro del docente è inserito in un “sistema
organizzato”, un “potente” sottosistema sociale che concentra e organizza
notevoli quantità di risorse, di lavoro, di tempi, di spazi, di processi
normati e regolati. Senza voler scimmiottare Derrida: un “sistema” è sempre
potere e cristallizzazione autoritaria di significati.
A quel “sistema”
vengono assegnati un significato, una funzione, una specializzazione
sociale che è quella della “riproduzione”: dei valori sociali riconosciuti,
delle enciclopedie disponibili, delle appartenenze culturali e sociali, del
senso comune, della divisione del lavoro…
E tutto ciò si traduce in lavoro scolastico corrispondente, tempi e spazi
di erogazione, programmi, compiti e regole operative, gerarchie e culture
organizzative.
Sono due aspetti del lavoro docente (quello “istituente” rapportato al
soggetto, e quello “istituito” rapportato al “sistema”) che, come le
classiche due facce della medaglia rappresentano il primo e fondamentale
“confine” da esplorare.
Una dialettica difficile da ricomporre e che, di volta in volta, trova
“formazioni di compromesso” (mi si passi la terminologia psicanalitica)
diversamente collocate lungo essa: l’orientamento al curricolo (alla
riproduzione) e l’orientamento al soggetto devono ricomporsi in un sensato
lavoro quotidiano, e tale ricomposizione dà fondamento ai diversi profili di
diversi insegnanti. E questa è la fatica di ognuno.
Ma tutto ciò ha anche una dimensione collettiva, legata a fasi storico
politiche, a suggestioni culturali prevalenti che ispirano politicamente il
“sistema”, ma anche a immaginari collettivi che attingono dinamiche sociali
esterne al sistema stesso.
La storia dei sistemi di istruzione ha conosciuto specializzazioni e
funzioni assai diverse sia in linea diacronica, sia sincronica tra segmenti
diversi di sistema.
E’ del tutto evidente che il passaggio alla scolarizzazione di massa, non
solo per i livelli elementari della “scuola per il popolo” ma nella
istruzione superiore, si è riflessa sui caratteri del “lavoro docente”, così
come è evidente che le “specializzazioni” interne ai sistemi si riflettono
in dislocazioni oggettive e nelle percezioni professionali soggettive dei
docenti stessi. Specie in sistemi che hanno una rilevante resistenza
riproduttiva interna (come quello nazionale).
Basti pensare alla distanza ancora oggi riprodotta sia nelle realtà
strutturali (tempi e spazi di lavoro, retribuzioni p.es.) sia negli
immaginari professionali soggettivi tra un docente della scuola
dell’infanzia ed uno di un Liceo Classico. Una differenza che, nella scala
di valori riconosciuti e riprodotti che vi si connette, non tiene affatto
conto (anzi..) che il lavoro del primo è più che determinante delle
condizioni e del possibile successo del lavoro del secondo.
Il secondo confine: tra vecchio e nuovo
Ha un ovvio fondamento
strutturale. Il lavoro docente è quotidianamente ( si potrebbe dire
“fisiologicamente”) posto di fronte alle nuove generazioni, il cui
rinnovamento (linguaggi, mode, consumi) ha conosciuto accelerazioni più che
significative negli ultimi quaranta anni, con una presa progressiva di
egemonia del mercato rispetto alle agenzie tradizionali come la famiglia e
la scuola stessa.
Linguaggi, mode, consumi plasmati dal mercato e dalle sue convenienze, tanto
più in condizioni di progressivo restringimento delle platee delle
popolazioni corrispondenti (dal mercato giovanile e unificato di massa degli
anni ’70, ai mercati articolati e selezionati attuali), accelerano le
cadenze dei passaggi generazionali. Cinque, sei anni (le durate dei cicli
scolastici) segnano spesso modificazioni radicali, che si offrono alla
permanenza e continuità del lavoro docente come altrettante difficoltà alla
sua capacità di interpretazione.
Ma il confine tra vecchio e nuovo, al di là di tali dinamiche più recenti, è
un tracciato strutturale che corrisponde a quello indicato nel punto
precedente: da un lato l’impegno alla “riproduzione” dei significati, dei
valori e delle appartenenze (la conservazione), dall’altro la “formazione”
della autonomia personale del soggetto la cui espressione piena è la podestà
di alterazione dei significati stessi, la deliberazione sui valori e sulla
appartenenze (l’innovazione).
Il docente opera a cavallo di tale confine, tra il dolore del “tradimento
come traguardo” (l’alterazione dei significati riprodotti, come compimento
della relazione con il maestro) e il rischio della manipolazione e
mortificazione della autonomia del soggetto entro la asimmetria della
relazione educativa. Oggi inoltre alimentato dalla rilevanza assunta dalla
rielaborazione dell’informazione e della comunicazione attraverso la
digitalizzazione e la rete, capace di “virtualizzare” ogni esperienze reale
che dovrebbe accompagnare la formazione del soggetto.
Lo sviluppo di capacità critica verso gli apparati di manipolazione e
riproduzione dei significati che operano dentro/fuori la a scuola, si pone
sempre più come urgenza cogente del lavoro formativo, ma contemporaneamente
e specularmente si individua come essenziale l’obiettivo di sviluppare una
“disciplina della ribellione” come condizione per superare il rischio più
evidente della reiterazione del consumo che sostituisce la responsabilità e
identità del desiderio.
Penso che, a cavallo di tale dialettica si richieda oggi al docente una
capacità di “lungimirante severità” che risagomi anche un tradizionale e
inevitabile “peterpanismo” caratteristico del resto di tutti quanti operano
a contatto con le nuove generazioni.
Ma si tratta evidentemente di una istanza che a sua volta si dovrebbe
rideclinare in rapporto alla stessa età dei docenti. Il nostro sistema di
istruzione ha un livello medio di età tra i più elevati a livello mondiale;
ma, proprio per questo e in relazione ai caratteri del rapporto di lavoro,
ha una prossima stagione di turnover e rinnovamento generazionale di
dimensioni quantitative più che significative e che possono essere
“calcolate” con precisione statistica; e dunque suggeriscono
(suggerirebbero) politiche del personale (formazione, mercato del lavoro
interno, mobilità professionale, ecc..) consapevolmente “mirate” a tali
mutamenti strutturali, e in grado di superare pratiche (per esempio
sindacali) confortevolmente riproduttive.
Il terzo confine: tra ceti e culture sociali.
Nel pieno della stagione
storica della scolarizzazione di massa (anni ’70) si pubblicò la prima
ricerca sociale sugli insegnanti italiani condotta da Barbagli e Dei. Il
titolo, “Le vestali della classe media”, era più che efficacemente
rappresentativo della sintesi dell’insieme di dati che la ricerca aveva
rilevato.
Caratterizzava un ceto professionale in tumultuosa crescita numerica,
collocato entro un sistema (istituzionale, amministrativo, organizzativo)
sottoposto a tensioni innovative strutturali (l’ingresso all’istruzione di
ceti tradizionalmente esclusi) e coinvolto in parziali e segmentati
tentativi di innovazione istituzionale che, per quanto interpreti di quella
innovazione, dovevano misurarsi con resistenze e stratificazioni
riproduttive, specie amministrative, capaci di mandare fuori bersaglio ogni
politica scolastica riformatrice. Essa si espresse comunque in interventi
segmentali mai complessivi di sistema: la scuola media, e poi a distanza
decennale la scuola elementare; per la secondaria superiore ci vollero
quarant’anni (ammesso che oggi…).
Allora, nelle citazioni di quella ricerca, nei richiami ad essa, nel
dibattito pubblico che si sviluppò, il titolo veniva regolarmente deformato:
“Le vestali della classe media” diventava regolarmente “Le vestali della
scuola media”.
Un lapsus che vale più di tante analisi approfondite. Un “luogo” di
inconsapevolezze plurime. La ricerca sottolineava la permanenza, custodia,
riproduzione di valori tradizionali relativi al ceto medio, in contemporanea
all’impegno alla estensione della platea sociale dei riferimento, con
l’ingresso di ceti popolari prima esclusi dall’istruzione. La “lettura” del
ceto professionale era invece egemonizzata dall’ideologia del rinnovamento,
in particolare nel segmento che più ne era investito (la scuola media), ma
poco si interrogava sulle corrispondenze tra struttura sociale e suoi
bisogni specifici e set di valori e significati in riproduzione.
Il massimo di consapevolezza “progressista” si esprimeva in termini di
“apertura e facilitazione” all’ingresso di nuovi ceti nel medesimo
contenitore (e nel medesimo approccio culturale), pensato ed organizzato per
altri valori che rimanevano tuttavia, esplicitamente o sotterraneamente, i
medesimi.
Usando altre parole: il sistema ampliava “liberisticamente” i propri
“contenitori”, ma conservava, attraverso la permanenza e riproduzione di
valori e significati, le medesime gerarchie culturali e sociali, custodite
dal ceto professionale anche quando sé dicente “progressista”. (Si ricordi
che ci volle un contratto dei metalmeccanici per dare vita ad una esperienza
di formazione degli adulti come le 150 ore. E la situazione attuale dello
sviluppo della istruzione permanente porta ancora i segni della
“indifferenza” istituzionale da un lato alla ”cultura del lavoro” e
dall’altro alla “formazione per tutta la vita”)
Il “ceto professionale” dei docenti era (è) attraversato da tale confine,
con riflessi soggettivi e collettivi sulla declinazione e sugli immaginarti
professionali, con tante dislocazioni interne più profonde e a volte occulte
che permangono e si riproducono anche nelle stagioni sè dicenti innovative.
Potremmo invocare riprove attuali di tali permanenze più o meno sotterranee:
che dire del fatto che il recente “ritorno” alla valutazione numerica abbia
visto da un lato le proteste (tenui) degli orientamenti “facilitatori ed
accoglienti” e dall’altra il tacito sospiro di sollievo di chi ne apprezza
la semplificazione o interpreta (finalmente!) la possibile “vendetta
pedagogica” rispetto alla stagione del “progressismo accogliente”? Certo
posizioni opposte, segno di profonde dislocazioni interne anche se
curiosamente unificate da una proposizione largamente condivisa che
scongiura comunque, come comune pericolo, la possibilità di un “valutatore
esterno”.
Anche questo confine ha declinazioni diverse sia strutturali/culturali che
storico/soggettive.
Gli insegnanti costituiscono un ceto professionale con un elevato e
significativo tasso di “endogamia” (si sposano spesso tra loro) anche al
confronto con altri “ceti professionali”. La loro bassa retribuzione
individuale e la sicurezza del rapporto di lavoro nel caso di personale in
ruolo, in tale condizione media, diventano elementi di classificazione
sociale da fascia di ceto medio, sia pure a livello modesto; (anche a
prescindere da considerazioni relative a patrimoni famigliari comunque
riferibili mediamente sempre a stratificazioni sociali intermedie. Qui
basterebbe considerare la stratificazione sociale interna dei laureati e la
sua evoluzione).
D’altra parte, a partire dal dato relativo al grado di endogamia, va
ricordato che il processo di femminilizzazione del ceto professionale si è
esteso progressivamente dai livelli scolari inferiori a quelli superiori,
dai docenti ai dirigenti. E in parallelo è cresciuta la soglia di età di
ingresso al lavoro scolastico. Il confine della stratificazione sociale è
dunque oggettivamente esplorato sempre più in relazione al “coniuge” e al
reddito famigliare. E se rifacessimo la ricerca di Barbagli?