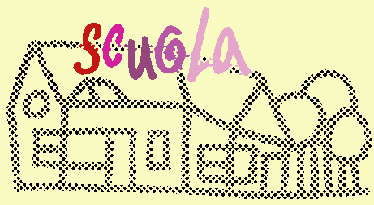 |
PavoneRisorse |
18.03.2014
Leader,
giullari e impostori: a proposito di leadership nella scuola
di
Franco De Anna
Rubo il titolo ad uno scritto di
Manfred Kets De Vries, a mio parere fondamentale per impostare e
comprendere la problematica della leadership nelle moderne organizzazioni.
Il furto approfitta della provocazione contenuta, ma non prelude ad una
esegesi del pensiero di De Vries: la questione della leadership pare
acquistare, nel più recente dibattito sulla dirigenza scolastica un rilievo
particolare e, volendo contribuirvi, mi pare assennato porre in rilievo
quell’irriverente accostamento, come richiamo a tante trappole concettuali o
meno, in agguato.
La leadership tra miserie e nobiltà.
Registro un grande ed interessante
impegno da parte dei molti che si cimentano con il problema della leadership
nella scuola, a definirne “attribuzioni”: leadership condivisa, distribuita,
pedagogica, relazionale, provvisoria, a rotazione, carismatica…. Finanche
“democratica”.
Ciascuna attribuzione mette capo ad un “dover essere” che corrisponde ad una
sorta di sforzo per tracciare il profilo di una “leadership ideale” o meglio
ad un idealtipo di leadership, considerata adeguata alla scuola.
Affermazione di “intenzioni” dunque e sforzo definitorio di “profili”
selezionati e indicati come “più appropriati” alla organizzazione della
scuola.
Non si può che apprezzare tale sforzo dedicato agli “aggettivi”
qualificativi. A patto di non far prevalere l’attenzione all’aggettivo sulla
considerazione del sostantivo: la leadership ha sempre a che fare con il
potere ed il suo esercizio. Il modo di interpretarla costituisce la “miseria
e nobiltà” del leader.
Dal sostantivo dunque è essenziale partire. Due sole notazioni aggiuntive a
tale affermazione (già per sé oggetto di discussione).
La prima: saper “distribuire”, dividere, con-dividere, il potere è (oltre
che una buona strategia..) il “massimo” della espressione del potere.
La seconda: il fascino esercitato dalla leadership carismatica andrebbe
sempre corretto dalla considerazione che ogni Cesare trova sempre il suo
Bruto. Ottaviano ebbe certamente meno carisma (non minore abilità, anzi,
nella gestione del potere) e morì nel suo letto, edificando un impero.
Pro-memoria semantico.
Indigestione del termine leadership.
Curioso il ricorso quasi inevitabile all’anglosassone. Come se gli
equivalenti italiani non avessero altrettanta “concentrazione” semantica. Ma
allora occorre tenerne conto. To lead è “essere in testa”, guidare (il
gruppo, l’esplorazione…), ship è la nave, la “flotta”. Per estensione una
organizzazione, un’insieme di persone impegnate in uno scopo comune…
La semantica rinvia agli ingredienti necessari per poter declinare il
termine: innanzi tutto “qualcuno che è (che è messo…) in testa”. Poi una
“nave”, una flotta, una organizzazione; poi una meta, un “luogo da
raggiungere”. I caratteri determinati di questi tre ingredienti daranno
fisionomia determinata alla leadership. “In testa” ci si trova per processi,
meccanismi, riconoscimenti diversi che vanno da legittimazioni formali a
processi informali e “spontanei”; una flotta, un esercito, una scuola, una
impresa sono organizzazioni con caratteri del tutto determinati e non
equivalenti; affrontare una battaglia con il nemico, conquistare una terra
sconosciuta, realizzare un buon prodotto sono mete affatto diverse e che
richiedono apporti differenti, al di là delle “metafore linguistiche” (usate
ed abusate) che possono rimanere le medesime. I tre ingredienti devono
essere compresenti. Se muta anche solo uno di questi, muta il carattere
della leadership. Il medesimo gruppo di persone che opera per esempio in una
impresa, se si riunisce dopo il lavoro in una cena collettiva, vedrà
modificarsi i meccanismi e le manifestazioni della leadership.
Del resto… ogni Carnevale elegge il suo re, e non è il medesimo della
Quaresima.
Se proprio dobbiamo rimanere sul piano delle definizioni leader è colui che guida la flotta verso la meta e la raggiunge conservandone ( per il possibile) l’integrità. Ma tra “il capitano” e il “nostromo” vi è una fondamentale differenza.
In proposito richiamo un aforisma che contiene grande verità e che mi esime da analisi impossibili in questa sede: il manager “sa fare le cose”; il leader “sa cosa va fatto”. Con una nota aggiunta, questa storicamente determinata: in genere i grandi leader sono anche abili nel “fare qualche cosa” di concreto, anche se la loro funzione non si esaurisce in quella “competenza”. Napoleone Buonaparte era un “mago” dell’artiglieria mentre per la cavalleria doveva rivolgersi altrove; e lo sapeva fare bene tanto da ovviare anche per ciò che l’artiglieria non poteva fare. Ricordate le letture giovanili? Sandokan era un ineguagliabile timoniere, ma si metteva materialmente al timone solo nelle cruciali contingenze della battaglia e dello scontro.
L’aforisma e la precisazione, nella
loro sinteticità, contengono il riflesso di una questione più generale: la
leadership è attività “pratica”, concreta; si misura con la realtà, non con
i suoi modelli. Per stare alla scuola: si misura con le realizzazioni
necessarie e possibili per una istituzione scolastica autonoma (con “questa”
autonomia) e che opera in un contesto concreto (in “quella” realtà socio
economico geografica, e non con il “sistema”); non con le diverse
interpretazioni o con le “scuole di pensiero” che si esercitano
sull’autonomia.
Quest’ultimo è esercizio fondamentale per determinare, decidere, criticare
assetti istituzionali e alternative organizzative; ma assolutamente
“deviante”, o comunque inutile, se usato come “canovaccio” per tracciare un
idealtipo di leadership scolastica: è come scambiare la “divisa” del
comandante ed i suoi fregi per la sua capacità di portare la flotta a
destinazione e in salvezza.
La leadership come questione “situata”.
Il pensiero sul potere, le sue
miserie e nobiltà, costituisce un leitmotif della riflessione umana e
delle sue manifestazioni: la storia, la filosofia, la letteratura ne sono
sature (insieme al pensiero sull’amore e a quello su dio).
Ma qui restringiamo il campo: il riferimento è agli studi ed elaborazioni
sulla questione della leadership nelle organizzazioni moderne, come capitolo
essenziale delle scienze e della cultura dell’organizzazione che si sono
sviluppate a partire dalla seconda rivoluzione industriale.
Per eccesso di schematismo, cito tre fasi di sviluppo di tale pensiero.
All’inizio (quando la
leadership divenne oggetto di riflessione della scienza dell’organizzazione)
il riferimento fu la grande impresa fordista taylorista. Moltitudini di
uomini impegnati, con diverse funzioni definite e sempre più formalizzate
(si pensi alla line taylorista, e allo staff in cui si
concentrano le diverse intelligenze del processo produttivo) finalizzate ad
una meta definita e individuata (dare una automobile a tutti i cittadini
americani e del colore che vogliono, “purchè sia nero”, come diceva Ford).
L’analisi di molti “scienziati” dell’organizzazione si diresse, per
simmetria, a studiare la leadership dei “grandi condottieri” della Storia.
Le direzioni del personale delle grandi imprese si attrezzavano a
riconoscere la presenza di “qualità” personali predittive di capacità di
leadership, e gli stessi paradigmi della ricerca postulavano che esse
fossero iscritte in “qualità” individuali originarie, restringendo
significativamente l’apporto di processi di apprendimento: leader si nasce…
La fase storica era quella della affermazione strategica, dello sviluppo
affluente, della affermazione di un modello organizzativo “vincente”. Il
leader doveva guidare “masse” ingenti e coordinare il loro lavoro secondo
strategie inequivoche. Il leader ideale è “orientato alla meta”.
La seconda fase fu
quella della “stabilizzazione” del modello. La preoccupazione dominante si
spostava dalla “guida” di grandi masse alla “manutenzione” di organizzazioni
di grandi dimensioni ma di dinamiche interne consolidate. Se nella prima
fase prevalevano “gli ingegneri di linea”, i progettisti, gli innovatori di
prodotto e processo, nelle seconda prevalevano i “manutentori di uomini”,
gli psicologi, i costruttori e conservatori di relazioni.
L’accento si spostava su contenuti di leadership che si prestavano a qualche
“apprendimento” nutrito proprio dalla psicologia, e dunque si fonda la
“psicologia dell’organizzazione”. Leader, almeno in parte, “si impara”(?!).
La terza fase ha
caratteristiche in gran parte attuali: il modello della grande impresa viene
falsificato. Si destruttura, delocalizza, esternalizza. Nella strategia di
impresa prevalgono le istanze del coordinamento, della tempistica
distributiva, della logistica e del rapporto con il mercato più che quelle
della line di produzione (il colore dell’automobile o del pullover
diventa “effettivamente” strategico.. per richiamare la famosa e antica
battuta di Ford). E sulla linea di produzione si passa dalla continuità
serializzata e lineare alla riorganizzazione per gruppi con relativa
autonomia nella ripartizione di tempi e funzioni (il toyotismo e l’ideologia
della “qualità” e responsabilità del team).
Ovviamente l’idea stessa di leadership si trasforma, si “decentra”.
Acquisita progressivo primato una immagine di “team leader” (la leadership
riferita al piccolo gruppo) che si afferma sulle altre.
Rispetto alla realtà, il passaggio
del “primato” della leadership espressa dalla capacità di direzione di
grandi moltitudini, a quella di manutenzione di tante soggettività, a quella
di guida di un team, è appunto “primato ideologico”, enfatizzazione di
scuole di pensiero, diversa stratificazione dell’attenzione. Si guardino le
attribuzioni assegnate alla leadership in tanta letteratura organizzativa
recente e di varia impostazione: sono tratti corrispondenti alla conduzione
di un (piccolo) gruppo.
La realtà richiede invece comunque, sia pure in misura diversa, l’esercizio
di tutti i livelli di leadership diversamente stratificati (esattamente come
le diverse forme di organizzazione di impresa si stratificano tra
innovazioni e permanenze). Metterne in rilevo l’una rispetto all’altra
corrisponde ad una “modellizzazione” che contiene sempre qualche rischio di
“ideologizzazione”. Speculare effetto, del resto, di alcune proposizioni
ammantate da “scienza”, come quelle che affermano la fine del modello
taylorista. (Ci si provi ad analizzare gli allegati dell’accordo FIAT di
Pomigliano che riguardano l’organizzazione del lavoro....).
Ci si provi a misurarsi con la realtà di quanto avviene davvero in tante
imprese italiane e, sopratutto in tante imprese dei paesi cosiddetti
emergenti che “nutrono” il nostro mercato di beni durevoli. Si scoprirà
quale dose di “ideologia” viene immessa nella analisi (che certo contiene
elementi essenziali di comprensione della realtà) che vorrebbe
caratterizzare la fase post industriale.
Si nasce o si diventa?
La risposta classica di Totò (..io,
modestamente, lo nacqui..), come spesso accade alle battute di Totò, svela
almeno una parte di verità. Ma non si può condannare alla inutilità una gran
messe di letteratura che si sforza di “insegnare la leadership” e dunque di
promuovere il possibile aspirante a diventare leader. Iscrivo d’ufficio a
tale genere letterario tutti i tentativi (alcuni di gran pregio analitico)
di tracciare il profilo dell’idealtipo di leadership adeguata all’idealtipo
di scuola che si considera (secondo le diverse scuole di pensiero)
interpreti più adeguatamente la “scuola dell’autonomia”.
Come rammentato nella breve e schematica rivisitazione della storia della
problematica della leadership nell’impresa moderna, il prevalere della
modellizzazione del “team leader” dà fondamento alla possibilità di
identificarne competenze precise (di comunicazione, di gestione di gruppo,
di rielaborazione del conflitto..) che si prestano “ragionevolmente” ad
essere insegnate e apprese. Anche a tal proposito, per sintetizzare la
disamina di una questione che qui non è possibile sviluppare, me la cavo con
una “battuta”: è probabile che alcune componenti della leadership possano
essere insegnate/apprese. Ma che tipo di leader si ottenga da tale
insegnamento/apprendimento è tutt’altro che determinato.
Vorrei perciò ripercorrere schematicamente i tre elementi fondamentali per
caratterizzare la leadership citati in apertura (l’essere “in testa” e con
quali procedure; una organizzazione; una meta da raggiungere) nel caso della
scuola “per ciò che è” e poi semmai esercitarsi sul “ciò che deve essere” o
vorremmo che fosse.
E’ bene distinguere tra elementi “strutturali” delle organizzazioni scolastiche e configurazioni istituzionali/formali (ma ciò vale per qualunque organizzazione). Rispetto ai primi elenco un sommario repertorio di affermazioni.
La scuola è una organizzazione di medie dimensioni. In particolare con i ripetuti e recenti dimensionamenti. Oltre un centinaio di dipendenti, qualche migliaio di “clienti” (alunni, famiglie, comunità locale di riferimento) configurano dimensioni da piccola-media impresa
È una organizzazione ad alta intensità di lavoro e bassa intensità di capitale. Nella composizione tecnica del processo produttivo, il lavoro vivo rappresenta la variabile di gran lunga più determinante nel configurare l’organizzazione.
La “classificazione” del lavoro è relativamente complessa, ma la parte più rilevante impegnata nella produzione diretta del servizio (i docenti) è caratterizzata da elevatissima autonomia professionale e padronanza individuale degli strumenti operativi. Le modalità di erogazione del lavoro configurano una struttura più simile all’antico atelier dei primordi dell’industrializzazione, piuttosto che dell’impresa moderna.
La sequenza centrale della produzione con caratteri di continuità e serialità (l’atelier, la sequenza curricolare) è accompagnata da inserzioni trasversali di “servizi” alla produzione con diversa composizione tra continuità e durata. (dai “progetti”, alla gestione amministrativa, alle attività di ricerca operativa quando e se vi sono)
Il livello di strutturazione gerarchica interna è a bassa intensità e articolazione ultra semplificata: in sostanza due soli livelli. Una figura messa “in testa” e con basso potere gerarchico e un “gruppo di pari”.
Naturalmente l’elenco dei caratteri “strutturali” potrebbe essere ancora più lungo e articolato. Mi fermo qui perché anche da queste semplici indicazioni è possibile estrarre conseguenze sulla tipologia della leadership determinate da tali caratteri.
Le dimensioni quantitative della organizzazione escludono che chi è “messo in testa” (il dirigente Scolastico) possa esaurire il proprio esercizio di leadership nella dimensione del team leader. L’equipaggio è numeroso e l’articolazione gerarchica assai tenue.
La leadership scolastica è fortemente segnata e condizionata dall’orientamento alle persone. (alta intensità di lavoro e bassa intensità di capitale).
Viceversa la esilità di articolazione organizzativa reale (quella legata al processo produttivo) e la linearità e permanenza del processo (le sequenze curricolari) riducono drasticamente la vera e propria “strutturazione” per team ad alcune componenti ”trasversali” del ciclo produttivo (la progettazione di “ampliamento” dell’offerta) e ad alcuni “servizi” alla produzione e all’utenza.
La problematica del lavoro per team non investe la sequenza centrale della produzione, dunque la sua proposizione come problematica “generale” rischia di esercitasi sul piano di “auspici”, e il suo limite è quello di non misurarsi pienamente con un mutamento organizzativo che avrebbe invece la portata del passaggio da uno pseudotaylorismo ad un modello “toyota”. Dunque implicherebbe una decostruzione complessiva del modello organizzativo: dalla classificazione del lavoro, ai livelli di gerarchia, a spazi e tempi di produzione.
Il limite di molte elaborazioni
sulla leadership distribuita, anche quando danno vita a qualche
sperimentazione interessante, sta proprio nel fatto che si configurano come
“dichiarazioni di intenzioni” e, per quanto siano apprezzabili queste
ultime, la “struttura” dell’organizzazione rimanendo immutata, ne consente
applicazioni tutto sommato residuali. Questa struttura organizzativa
concentra la leadership sul “profilo di ruolo” del Dirigente; e, per quanto
accennato più sopra, enfatizza la necessità di un “orientamento alle
persone” rispetto all’altra polarità tipica della leadership rappresentata
dall’orientamento agli obiettivi.
Anche l’uso del costrutto “staff/line” è approssimativo. Chi è la
line nella organizzazione scolastica? E senza line la struttura
di staff ha il solo significato di “alleggerire” il lavoro del
Dirigente, e non è un “dato strutturale” dell’organizzazione.
Naturalmente è sempre possibile immaginare un dirigente capace di tenere
l’equilibrio tra un alto orientamento alle persone ed un elevato
orientamento agli obiettivi. Si tratta con tutta evidenza della leadership
“carismatica”: un “evento” difficilmente perseguibile ”per regolamento” e
difficilmente riconducibile a processi di apprendimento di tecniche e
competenze, né tanto meno selezionabile attraverso uno dei nostri
“concorsi”.
Se l’analisi si sposta sull’assetto
formale e istituzionale dell’organizzazione scolastica se ne generano altre
considerazioni utili a rielaborare pensieri sulla leadership.
Il fulcro è ovviamente l’autonomia che ridefinisce tale assetto sul finire
del secolo scorso. I riferimenti formali sono come è noto un disegno di
riforma complessiva della Pubblica Amministrazione (la Legge 59/97 “bassanini”)
e la sua applicazione al servizio di istruzione attraverso il Regolamento.
Ispirazione di fondo che ha trovato successivo riscontro anche in modifiche
istituzionali (Titolo V Cost.). L’azione legislativa ha tradotto (o ha
cercato di farlo) un intreccio di motivazioni e ispirazioni di carattere
politico, culturale, economico, istituzionale anche molto diverse tra loro e
comunque “ricomposte” nella mediazione legislativa. Esse sono operanti
ovviamente nella costruzione della riforma riproponendo sempre diversi
rapporti di forza. (vale per l’azione riformatrice ciò che Calvino diceva
della traduzione: tradurre è sempre un poco “tradire”).
Le elenco sommariamente.
L’affermazione della distinzione, non declinata nell’ordinamento amministrativo tradizionale italiano , tra la dimensione “autoritativa” dell’amministrazione, che “produce” norme, autorizzazioni, sanzioni, e la dimensione di “produzione di servizi” (che ovviamente dovrebbe avere altre regole, afferenti all’economia e non al diritto amministrativo..). Tale elaborazione si coniuga strettamente con l’enorme sviluppo quantitativo e qualitativo assunto dalla produzione pubblica di servizi alla cittadinanza (scuola, sanità, previdenza). Tale consapevolezza ha animato, dalla fine degli anni ‘70 una riflessione fondamentale sul riassetto della P.A. (Massimo Severo Giannini, Sabino Cassese, Bassanini, solo per fare alcuni nomi indicativi di una scuola di pensiero).
Alla fine degli anni ’70 lo sviluppo compiuto del
welfare (si pensi alla scuola di massa) investe l’universo della
popolazione, ma, contemporaneamente si delinea quella che è stata
chiamata “la crisi fiscale dello Stato”. Una fase che certo investe
tutto il mondo occidentale, ma che nel nostro Paese si stratifica sulle
contraddizioni precedenti.
Una linea di uscita è cercata ed individuata nello “smontaggio” della
piramide organizzativa tradizionale della P.A. decentrando
funzionalmente ad “unità produttive” che assumono la responsabilità
della produzione finale del servizio in rapporto più stretto e diretto
con la cittadinanza. La veicolazione del “comando” caratteristica
dell’assetto piramidale, deve essere sostituita dalla rielaborazione di
categorie economiche di efficacia, efficienza e produttività.
L’autonomia scolastica è, nella elaborazione teorica, figlia di quella
ipotesi. (L’autonomia cosiddetta “funzionale”)
La ricerca di alternative alla “crisi fiscale” dello Stato, che non siano semplicemente lo smantellamento del welfare, trovano diverse espressioni nella ricerca internazionale; una di queste, rielaborata dal New Public Management di scuola anglosassone, è l’idea del “quasi mercato”. In sostanza lo Stato non è più “produttore” di un servizio, ma esercita il ruolo del provider, definendo le prestazioni pubbliche, le “regole” fondamentali, i criteri di qualità e di valutazione, e “contrattando” i costi del servizio con i “produttori”. Per qualcuno, addirittura, lo Stato diventa committente. I produttori dovrebbero costituire una pluralità di soggetti variamente configurati (qui diventano essenziali le configurazioni istituzionali caratteristiche di ciascuna realtà).
La rielaborazione del principio di sussidiarietà. Ne assumo, per sintesi, la definizione operativa di Delors: la sussidiarietà consiste nel fatto che lo Stato si astiene dall’intervenire in proprio quando una comunità locale sia in grado di risolvere da sé i propri problemi, ed anzi interviene per favorire l’espressione di tale capacità. Ovviamente è un “principio operativo” che, valorizzando l’autonomia delle comunità locali, distingue contemporaneamente la dimensione tecnico-politica dei problemi. Dunque richiede non tanto la predicazione di principio, quanto la elaborazione attenta e qualificata della politica pubblica (un ambulatorio locale è cosa assai diversa da un ospedale che garantisca prestazioni specialistiche e attrezzature diagnostiche e curative avanzate).
La valorizzazione della autonoma capacità di organizzarsi e produrre della società civile. Nel nostro linguaggio la questione del “terzo settore”, e nella tradizione nazionale (diversa da quella anglosassone..) fa riferimento alle esperienze del movimento cooperativo, del volontariato, e nella legislazione più recente nelle Onlus, le fondazioni, l’associazionismo.
Si tratta, come si comprende, di
ispirazioni affatto diverse. Ma tutte sono accomunate dalla affermazione
che lo Stato (e dunque la P.A.) non saturano la dimensione del “pubblico”,
ma semmai ne costituiscono una “intelaiatura”, una cornice che si esprime,
appunto, nella definizione delle regole, dei livelli di qualità e delle
garanzia di eguaglianza nelle prestazione, e dunque nell’attività valutativa
conseguente. (La funzione valutativa viene coerentemente enfatizzata).
L’intrecciarsi variamente declinato di tali suggestioni, oltre che postulare
un mutamento fondamentale del ruolo e del funzionamento della P.A. pone il
problema della configurazione dei “produttori” finali dei servizi pubblici.
L’autonomia operativa, la responsabilità del prodotto finale,
l’interpretazione delle categorie economiche dell’efficacia e della
produttività; il rispetto, sottoposto a valutazione, delle regole e della
qualità delle prestazioni, sono categorie che accomunano diverse concezioni;
ma la configurazione formale/istituzionale della pluralità dei “produttori
finali” costituisce una “scelta politica” fondamentale che accompagna il
disegno di riforma dello Stato.
Lascio al lettore il compito di misurarsi, nelle sua riflessione, sul come
siano stati interpretati tali problemi nella politica degli ultimi quindici
anni nel nostro Paese, tra devolution, regionalizzazione, decentramento,
federalismo (!?), sviluppo delle municipalizzate, ecc…
In proposito vorrei solamente mettere in luce che, a parte l’insostenibilità
dell’ordinaria corruzione, il confronto pubblico su tali questioni è stato
mortificato dal fatto che le realizzazioni operative siano state affidate
alla medesima P.A. che si voleva riformare radicalmente e che ha invece
messo in campo tutti i meccanismi di autodifesa e di riproduzione dei propri
paradigmi. Sul fronte opposto dell’opinione “critica”, è stato agitato con
semplicismo proporzionale spesso all’enfasi urlata, il fantasma della
“privatizzazione” al quale è stato confezionato un mantello di ampiezza
talmente smisurata da occultare i problemi invece che discriminarli.
Rispetto alla pluralità delle ispirazioni culturali, scientifiche, politiche
qui sommariamente elencate, la scelta di configurazione della “scuola
autonoma” assunta in traduzione operativa della riforma della Pubblica
Amministrazione (la “Bassanini”) fu quella di istituirle come Enti Pubblici.
(in singolare controtendenza, mentre si procedeva allo sfoltimento della
jungla degli enti pubblici se ne creavano 10 mila nuovi)
Una scelta che aveva alternative “pubbliche” (fondazioni, aziende pubbliche
per es…) la cui definizione avrebbe certamente costituito una grande sfida
politica e culturale insieme.
La scelta (tradizionale) dell’Ente pubblico, non ostante il coraggio
travasato nel regolamento dell’autonomia, pose fin dall’inizio le condizioni
della progressiva decostruzione dell’autonomia stessa alla quale abbiamo
assistito in questi anni.
Da tale scelta discendono infatti: le regole di gestione economica mutuate
dal Bilancio dello Stato, la cristallizzazione amministrativa della
classificazione e della disponibilità operativa del personale (dal
reclutamento, ai “fogli di lavorazione”, ai modelli organizzativi), la
formalizzazione dei profili di ruolo e delle articolazioni gerarchiche, a
cominciare proprio dalla dirigenza; il prevalere dei paradigmi del Diritto
Amministrativo rispetto all’orientamento al “prodotto finale”; la
limitazione drastica della “padronanza” dei fattori produttivi (lavoro,
risorse, organizzazione), e il mantenimento della dipendenza “fisiologica”
dalla catena di comando ministeriale.
Ma le contraddizioni che segnano la transizione dalla “costituzione formale” dell’autonomia alla sua “costituzione materiale” rivelano ulteriormente le incongruenze presenti nella prima. Un Ente Pubblico di nuova costituzione è affidato ad un sistema di governo (gli organi collegiali) elaborato con le logiche e le problematiche di un trentennio prima (la riforma degli Organi Collegiali è un altro consunto leitmotif della politica scolastica di questi ultimi quindici anni). I processi materiali più recenti, per esempio, con la crescita dimensionale delle “unità produttive” rivelano la profondità delle contraddizioni insite in quella scelta iniziale di configurazione pubblica. Il rilievo assunto da problematiche gestionali, amministrative, economiche finisce per operare come una lente di ingrandimento sugli irrisolti: la divisone del lavoro interna all’organizzazione; i caratteri “misti” della dirigenza; il rapporto tra dimensione “tecnica” della produzione e “servizi interni ed esterni” ad essa; la padronanza effettiva dei fattori per esercitare ottimizzazione dei costi e dei risultati; le responsabilità di indirizzo “politico” e quelle di “gestione” ed il loro apporto. Tutte questioni presenti fin dall’inizio di questa storia ma che la “piccola dimensione” consentiva di mantenere ad un livello di “ragionevole complessità” affrontabile “adattando” gli strumenti tradizionali.
La leadership e l’ornitorinco.
Dopo un quindicennio di “costruzione e decostruzione” dell’autonomia scolastica siamo di fronte ad un coacervo di contraddizioni, agli esiti di una transizione irrisolta, a tensioni divergenti che mescolano insieme istanze di rinnovamento e autodifese conservative, sia che ci si riferisca ai dati strutturali dell’organizzazione scolastica, sia che si guardi alla sua configurazione istituzionale e formale. Ho già usato l’immagine dell’ornitorinco: i peli di un mammifero, gli arti palmati di un animale acquatico, il becco di un uccello. Non trovo altra descrizione dello “stato dell’autonomia” nella scuola. Ma qui importa rispecchiare tali contraddizioni sulla problematica delle leadership la cui “tipologia” è investita proprio sia dai caratteri strutturali dell’organizzazione, sia dai suoi assetti formali.
Le scelte istituzionali (Ente Pubblico) hanno “messo in capo” un dirigente pubblico che è in larga misura assimilato ai paradigmi tradizionali della P.A. Però è responsabile di un “prodotto finito” in rapporto diretto con la cittadinanza a cui dovrebbe rendere conto. Ma ha una padronanza ridotta sui fattori di produzione.
Caso unico rispetto ai dirigenti amministrativi è posto a capo di un equipaggio numeroso e senza articolazioni gerarchiche interne. Dunque il suo “lavoro” sarebbe fortemente “orientato al personale” (nessun Direttore Generale o Capo dipartimento deve misurarsi quotidianamente e direttamente con un numero di collaboratori confrontabile). Ma le competenze che gli vengono richieste formalmente sono di altro tipo, e iscritte nei paradigmi del Diritto Amministrativo.
L’organizzazione operativa è radicata su sequenze
lineari e continuative cui presiede un gruppo di pari, sia pure
attraversate da qualche ripartizione (spesso residuale) di
progettazione.
Ma su tale realtà si universalizza ideologicamente “l’idea del progetto”
fino a indicarla come base per un ipotetico modello di valutazione del
personale (i “progetti” di miglioramento..).
Le suggestioni pure positive, a
livello di riflessione ed elaborazione, sulla leadership distribuita,
condivisa, “orientata al prodotto” (pedagogica), ecc… devono dunque
misurarsi con la realtà strutturale e istituzionale della organizzazione
dell’autonomia.
Rimando ad un approfondimento sulla realtà e la cultura organizzativa della
scuola; ma mi servo di una battuta un poco tranchant: posso esercitarmi a
rielaborare figure di team leader, ma il “vecchio” modulo della scuola
elementare costituiva un team (organizzava materialmente la produzione); un
“consiglio di classe” non è un team di produzione (al massimo si scambia
informazioni).
Rimangono dunque sullo sfondo due campi di intervento innovativo capaci di
inverare o meno le elaborazioni sulla leadership.
Il primo è costituito dai modelli organizzativi della scuola: il superamento
dello pseudo taylorismo delle sequenze operative ripartite e segmentate che
accompagnano la classificazione del lavoro, i tempi e gli ambienti
dell’insegnamento e apprendimento. Altrove metaforizzavo il passaggio
indicando un modello “toyota” nel quale insegnamento/apprendimento si
ristrutturasse effettivamente in una “isola” produttiva capace di ripartirsi
lavoro e responsabilità al proprio interno. (Corollari: semplificazione
della classificazione del lavoro; flessibilizzazione di tempi e spazi e
impieghi; mobilità interna alle organizzazioni, ripartizione delle
responsabilità e articolazioni dei regimi di lavoro; padronanza effettiva
dei fattori produttivi)
Il secondo è quello della riconfigurazione istituzionale della scuola
autonoma. In questi anni si sono susseguite diverse proposte che vorrebbero
“attualizzare” modelli di gestione e direzione. Sono interessanti perché,
nelle loro contraddizioni, rivelano e confermano le analisi precedenti che
muovono dalla contraddizione iniziale della configurazione di Ente Pubblico.
Ci si è provati a indicare “Consigli di Amministrazione”, configurazioni da
“Fondazioni”, e così via. Come se, rispetto agli Organi Collegiali; si
potesse semplicemente sovrapporre e integrare categorie interpretative come
“la partecipazione” (anni ’70) con “la gestione della produzione”
(l’autonomia anni 2000); la rendicontazione contabile da “contabilità
pubblica” con la rendicontazione sociale; il Bilancio pubblico con il
fund raising. Insomma la manutenzione dell’ornitorinco.
La attuale Ministra della Pubblica Istruzione è per esempio firmataria di
una delle proposte di disegno di legge che assegna alle scuole autonome la
“podestà statutaria”. Cioè le assimila agli Enti Locali, alle Università.
Dunque Enti nei quali è fondamentale il meccanismo elettorale nella
identificazione di chi è “messo in capo” dell’organizzazione (il Sindaco, il
Rettore..) e si distingue perciò tra il leader così riconosciuto e il
“nostromo” (il Direttore Generale, il Segretario comunale, il City manager
come si dice oggi).
Non ho alcuna preclusione nell’affrontare in termini di principio alcuna
ipotesi di rimodellizzazione. Mi auguro però che si abbia piena
consapevolezza del campo che si apre e dell’impegno esplorativo che si
propone. Insomma la consapevolezze che ciò che si affronta non è n
“adattamento cosmetico” di antiche categorie concettuali e interpretative,
ma una rifondazione “strutturale” dell’organizzazione scolastica.
In modo analogo tutta l’elaborazione sulla leadership deve misurarsi con
tali processi, se non vuole ridursi, a sua volta, ad interpretazione
“buonista” dei modelli di direzione.